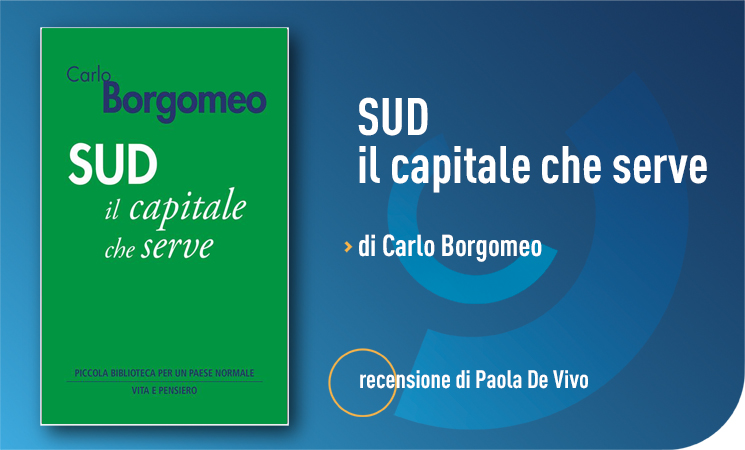
Il volume di Carlo Borgomeo arriva in un momento cruciale per l’Italia alle prese con il PNRR, le opportunità che potrebbe generare per il Mezzogiorno e le criticità di attuazione che vanno emergendo. Sin dal titolo, Sud il capitale che serve, si coglie intuitivamente che la prospettiva proposta è volta a rivedere categorie concettuali e interpretazioni convenzionali sul perseverare dell’arretratezza del Sud dell’Italia. La tesi principale sostenuta è che il capitale sociale è una precondizione per lo sviluppo e, in quanto tale, occorre adoperarsi per generarlo: «la vera discontinuità nelle politiche per il Sud sta nell’assumere una nuova cultura dello sviluppo. Nel rovesciare il paradigma: il sociale prima dell’economico» (pag. 45).
Il richiamo al capitale sociale come leva dello sviluppo appare da subito una scelta di campo precisa e puntuale nella ricerca di una diversa e alternativa strategia di sviluppo per il Mezzogiorno. Quest’ultima appare oggi dispersa in molti rivoli e perciò poco in grado di stabilire delle priorità da perseguire, poiché l’originario obiettivo mirato all’industrializzazione si è indebolito nel corso del tempo. Borgomeo ci conduce così alla riscoperta − ad un vero e proprio rilancio, dopo l’ascesa e il successivo declino − di questo concetto che ha dominato il panorama scientifico delle scienze sociali degli anni ‘90, ma che nel campo delle politiche e delle pratiche territoriali ha incontrato non pochi ostacoli nella sua affermazione.
Come si ricostruisce agevolmente dai Capitoli in cui è suddivisa l’opera, l’intento è di offrire un quadro approfondito delle vicende politiche, economiche e sociali che hanno contrassegnato la storia dello sviluppo del Mezzogiorno, nel tentativo di dimostrare che si è commesso l’errore di trascurare il ruolo che la società può avere nell’ostacolare o sostenere i processi economici. E da questa occorre perciò ripartire, investendo con convinzione sulla costruzione di reti fiduciarie, sul welfare, sulle risorse umane. Seppur minoritaria, questa intuizione l’avevano già avuta policy makers ed esperti sin dai tempi dell’intervento straordinario, su tutti Segrebondi, i quali avevano provato ad insistere sulla necessità di inserire a pieno titolo il sociale nelle politiche di sviluppo, trovando però poco spazio nelle scelte pubbliche. Per quanto sottotraccia e in modo carsico, il tema era presente nel dibattito, ma stentava a trovare una sua legittimazione operativa, offuscato da una impostazione teorica e politica che dava credito all’idea che la grande impresa era il motore dello sviluppo e che lo Stato si doveva impegnare per insediarla nei mercati dove mancava.
Il filo conduttore che guida tutto il ragionamento è rivolto, sul piano analitico-concettuale, al problema della ridefinizione dell’azione pubblica, dipanato attraverso un’analisi dei limiti di attuazione delle politiche nazionali e regionali. Il fallimento delle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia è l’approdo finale di scelte sbagliate, o, comunque, non ben ponderate. Si parte da due constatazioni importanti. La prima. Dopo settantadue anni di sostegno finanziario pubblico il Sud rimane una delle più vaste aree arretrate dell’Italia e dell’Unione europea. La seconda. Nel 1951 il PIL pro capite del Sud era pari al 52,9% rispetto a quello del Centro-Nord; nel 2021 esso è del 56,2%. Mettendo insieme questi due fatti stilizzati, l’implicazione che ne discende per l’Autore è che altro non si può fare se non prendere atto di un fallimento generalizzato dell’azione pubblica. A prescindere dalle modalità di intervento adottate, dall’alto o dal basso, non si è stati capaci di smuovere, di rivitalizzare, di rifondare l’economia e la società meridionale.
Se così è, resta da chiedersi a che cosa servano le politiche, ma a mettersi su questo crinale si rischia di ritornare all’idea che soltanto le forze di mercato possano scuotere il Mezzogiorno dal suo torpore. E di sottovalutare quanto il contesto esogeno abbia contribuito a tale fallimento. Su questo aspetto, l’Autore si addentra poco, poiché non è su di esso che si intende concentrare. Inserire il quadro esogeno e i vincoli che ha comportato all’economia meridionale, avrebbe però permesso di qualificare maggiormente una parte delle cause del fallimento di cui si discute. La persistenza dell’arretratezza meridionale va osservata infatti nel solco dei deludenti risultati economici che l’Unione europea, e ancora di più l’Italia, hanno conseguito negli ultimi trent’anni. Il fallimento del Mezzogiorno si inscrive anche nei condizionamenti causati dalla globalizzazione e dal ridisegno della divisione internazionale del lavoro, con la geografia dello sviluppo che è stata completamente rivoluzionata dai percorsi di crescita dell’India, del Brasile, della Cina. Altre nazioni, dell’Africa e del Medio Oriente, si sono incamminate lungo lo stesso percorso.
L’economia italiana ha stentato, e stenta tuttora, ad adeguarsi a queste trasformazioni. A ciò vi è da aggiungere la differente collocazione del Mezzogiorno nel contesto geo-politico europeo a seguito degli allargamenti ai paesi dell’Est. Ma non è questo il punto che Borgomeo vuole sollevare attraverso la lettura del volume, quindi lo si può tralasciare. È più interessante, invece, ritornare al rapporto tra politiche e fallimento. Su questa relazione si sarebbe dovuto compiere un maggiore approfondimento di cosa si intende per fallimento, ammettendo che esso è spesso usato come una categoria reificata. L’uso di questa parola potrebbe oscurare e confondere i molti e diversi processi che invece questa etichetta contiene. D’altra parte, la nota e ben accreditata letteratura sul fallimento delle politiche per lo sviluppo, altro non è che uno strumento usato per veicolare rappresentazioni e retoriche sul Mezzogiorno al fine di influire sulla reputazione delle stesse, in positivo o in negativo. Il gioco consiste in questo: il fallimento, presunto o reale, delle politiche rimanda alla necessità, anche morale, di investire ulteriormente l’azione pubblica dei problemi che una parte della cittadinanza meridionale sperimenta; oppure, viceversa, esso può validare l’idea che la spesa pubblica genera inefficienze e sprechi, e, quindi è bene ridurla o addirittura sospenderla. Le basi morali o quelle
economiche-finanziarie che costruiscono e alimentano l’idea di fallimento delle politiche a sostegno del Mezzogiorno, pur non essendo riuscite a imporsi nettamente l’una sull’altra, hanno depotenziato la credibilità delle politiche per lo sviluppo nel dibattito pubblico e politico. La costruzione del fallimento, inoltre, varia in rapporto al tempo e alla percezione degli esiti, che mutano in relazione al contesto, agli attori, alle logiche di azione.
Quando, perché e come inizia il fallimento dell’intervento pubblico per il Mezzogiorno è ben spiegato dall’Autore, con il richiamo di volta in volta alle risorse finanziarie pubbliche investite (o disinvestite), alle modifiche normative, al cambio delle procedure seguite, ai differenti modelli di governance utilizzati nelle fasi storiche che si sono susseguite. Eppure, la visione complessiva che fuoriesce è appiattita verso la riproduzione di un unico e grande fallimento, poiché Borgomeo sembra guardare agli esiti complessivi dello sviluppo con il metro del successo − che è lo specchio dell’insuccesso − di un parametro economico, il PIL, che egli stesso ben contesta con le sue argomentazioni. Gli interrogativi inerenti al fallimento cui Borgomeo fa riferimento sono i seguenti:
Penso che sia necessario partire, non eludendo la domanda sul perché in settantadue anni l’obiettivo è stato mancato. Perché le risorse assegnate al Sud sono state insufficienti e perché le politiche nazionali hanno sempre privilegiato lo sviluppo del Nord? Perché il Sud non è stato capace di spendere le risorse, poche o tante che fossero? Perché le classi dirigenti meridionali sono state incapaci, clientelari, corrotte in qualche caso colluse con la criminalità organizzata? O semplicemente perché – argomentazione generica ma assai pericolosa – è una questione di ‘mentalità’ dei meridionali? (pag. 11).
La risposta a questi interrogativi che egli dà è che nessuno di essi, da solo può spiegare il fallimento delle politiche. È la strategia che è stata sbagliata, puntata sull’offerta di politiche e non sulla domanda. A posteriori, questo lo si può certamente affermare, ma resta il fatto che andrebbe meglio articolato il perché di una tale sconfitta. Qui però vi è da porre un’altra domanda, oltre a quelle fatte dall’Autore ed è di questa natura: siamo certi che si tratti di un unico grande fallimento o da una analisi interna al fallimento si possono ricavare indizi diversi? Il Mezzogiorno è rimasto indietro ma, date le condizioni di partenza e le epocali trasformazioni di ordine storico vissute a livello mondiale, si può pensare che esso abbia comunque tenuto? E che ciò sia accaduto basandosi proprio su fattori sociali? Quanto hanno contato cioè il volontariato, l’economia sommersa, il ruolo delle famiglie nelle piccole e medie imprese, l’istruzione pubblica nell’aiutare il Sud a non soccombere del tutto? In sintesi, studiare i meccanismi del mantenimento del Sud può forse aprire nuove piste anche rispetto al significato del fallimento. D’altro canto, nelle stesse scienze sociali è stata data maggiore attenzione al concetto di successo e meno a quello di fallimento, portando a una visione semplificata del funzionamento delle politiche di sviluppo e più in generale delle politiche pubbliche. All’interno dello stesso grande fallimento si possono rivenire, infatti, parziali successi, oppure fallimenti di minore entità da cui ripartire. C’è una tendenza da parte dei governi a offrire programmi basati su aiuti finanziari esterni concepiti con l’idea che l’azione dei tanti attori coinvolti in essi si svolga sotto la condizione di una conoscenza perfetta e razionale, per poi scoprire ex post le criticità che si verificano durante l’implementazione. Invece, queste conseguenze inattese possono trasformare i fallimenti in risorse e opportunità da sfruttare per intraprendere nuove direzioni. Una sorta di sorpresa che può alimentare la ricerca di soluzioni producendo e gestendo altre politiche, misure e programmi di intervento. Questi possono essere in continuità o differire da quelli inizialmente pensati, essere rivisti in tutto o in parte, ma originarsi da quanto fatto in precedenza, rappresentando nuove possibilità di azione in termini di visioni, strategie e risorse da adottare.
Sebbene le politiche possano non dispiegarsi in modo compiuto e lineare, una traccia di quanto fatto rimane. Altrimenti, non si potrebbero spiegare i progressi comunque compiuti dal Sud dal dopoguerra ad oggi. Insomma, osservare i fallimenti da questa prospettiva fornisce un exit per ridurre la costante frustrazione e le inadeguatezze che le aspettative sullo sviluppo comportano. D’altra parte, l’approccio teorico dell’economia neoclassica è tutt’oggi egemone e i metodi usati per studiare lo sviluppo spesso determinano percezioni e immagini diverse di ciò che lo sviluppo è, potrebbe essere o potrebbe diventare. Per evitare queste trappole che ancora si incontrano in questo campo, Borgomeo suggerisce comunque di cambiare l’impostazione precedentemente utilizzata nelle politiche per il Sud. Una presa di consapevolezza, anche se non del tutto inizialmente esplicitata nella trattazione, circa il fatto che le politiche non devono pretendere di esaurire l’universo: c’è il loro specifico divario interno (tra formulazione e attuazione possibile e quello reale), e quello esterno riguardante la realtà sociale in movimento. La lezione di Segrebondi, ma anche di Hirschman, è citata e ripresa per dimostrare proprio questo. Le politiche potrebbero già dalla formulazione tenere in conto in misura ragionevole dei limiti e delle aporie dell’agire razionale e della pianificazione, cercando di valorizzarle piuttosto che negarle. Si fa il possibile, non l’ottimo. Prendere atto di una soglia di ineliminabile incertezza conferirebbe all’intelligenza degli attori un ruolo strategico. Rispetto ai cicli politici chiusi, costruiti a distanza dai territori, gli attori responsabili del processo potrebbero imparare un gioco diverso; normative più pertinenti, standard più esigenti, incentivi più selettivi, strumenti di ricompensa e capacità. In sostanza, gli attori istituzionali e non istituzionali verrebbero inseriti in un processo politico più rigoroso di prima, dove i particolari giochi strategici vengono incanalati verso un’azione a scopo condiviso. Saranno sempre presenti interessi e gruppi o individui discordanti, ma anche qui si tratterebbe di soglie. L’esistenza di un giudizio discrezionale circa le politiche è, in fondo, inevitabile. Per coloro che da esse guadagnano, sono ritenute adeguate e soddisfacenti negli esiti, viceversa per gli altri.
Quali progressi può portare un approccio che valorizzi i fallimenti all’analisi delle sfide a cui è sottoposto il Mezzogiorno? Qui la riflessione di Borgomeo conduce in un altro ambito, molto promettente. La risposta alla domanda implica maggiori sforzi per esplorare tutte le dimensioni latenti o sottovalutate presenti nei processi di sviluppo che possono aprire nuovi modi di agire per l’intervento pubblico. Un potenziale esistente, ma inespresso, poiché non sfruttato nel policy making. Un esempio potrebbe essere, come l’Autore suggerisce, l’economia informale che è assente nella formulazione delle politiche di sviluppo e lo stesso accade per la criminalità o la corruzione, spesso trascurate nelle finalità delle iniziative pubbliche, ma presenti nel concreto funzionamento dell’economia e della società. O, per restare agli ultimi tempi, l’esplosione delle emergenze, come quelle finanziarie o sanitarie, che ha fatto saltare lo schema codificato delle politiche, ponendole di fronte all’ignoto e all’imprevisto, favorendo la riscoperta del welfare. Su questo aspetto, egli argomenta che il Sud può trarre nuova linfa nell’elaborazione di una proposta politica e culturale che si incardini intorno alle esigenze e ai diritti di cittadinanza, mai pienamente soddisfatti, di questa parte della popolazione italiana.
La debole capacità di produzione e regolazione da parte dello Stato di beni collettivi comporta una negazione di diritti fondamentali e formalmente sanciti. Concretamente, si tratta del cattivo funzionamento dei servizi pubblici. Le disuguaglianze sociali si acuiscono in virtù di una mancata garanzia e tutela dei diritti al lavoro, all’istruzione, all’abitazione necessari per la riproduzione individuale, familiare e collettiva di una larga componente di popolazione meridionale. È un tale stato di necessità che genera una profonda divisione all’interno della società meridionale, foriera di ulteriori forme di disuguaglianza, tra coloro che dispongono di reti economiche, politiche, sociali usate per sfuggire ad una simile situazione e coloro, invece, che ne sono privi. Così aumenta la forbice cui si è accennato, con una fascia di popolazione che diventa sempre più «questuante»; una fascia che sperimenta condizioni di vita al di sotto di quelli comunemente stabiliti come standard minimi ed accettabili; una folla di soggetti accomunati da fenomeni di svantaggio lavorativo, economico, di status e, in una prospettiva più ampia, da una perenne difficoltà di partecipazione alla vita sociale.
«L’altro divario» è dunque nella questione sociale irrisolta nel Mezzogiorno. Mentre il divario economico ha assorbito molta attenzione, minore se ne è prestata a quella che meritava la formazione delle estese forme di diseguaglianze sociali che si andavano a costituire in vaste aree regionali. È come se il tema della crescita economica si fosse progressivamente distaccato da quello dello sviluppo sociale. Ciò nonostante il confronto serrato che si è avuto nelle scienze economiche e sociali, con una parte della comunità scientifica che ha tentato di spiegare come evitare di cadere nella trappola di un riduzionismo economico, rivelatosi spesso incapace di interpretare le cause e le ragioni dei differenti rendimenti nello sviluppo che si riscontrano nelle società odierne.
Il caso del Mezzogiorno rimane emblematico sin da quando approdare all’industrializzazione dell’area rappresentava il crocevia irrinunciabile attraverso cui passava il riscatto sociale delle popolazioni meridionali e la conquista di istituzioni civili. Il rovesciamento di questa strategia è la nuova strada da intraprendere. Sino a che punto la strategia di sviluppo tracciata da Borgomeo può contribuire al contenimento delle problematiche sociali appena evidenziate? Il cambiamento di paradigma invocato nell’approccio allo sviluppo del Mezzogiorno, con la maggiore attenzione dedicata alla valorizzazione del capitale umano e sociale, riapre una scommessa importante per almeno due ragioni.
La prima è che rafforza il convincimento, laddove ce ne fosse ancora bisogno, che una impostazione degli interventi a sostegno dello sviluppo basata soltanto sul capitale finanziario si è dimostrata inefficiente e inefficace. Serve tutt’altro capitale, quello sociale. La seconda è che le variabili di natura istituzionale, per dirla con North, contano e possono condizionare le performance economiche. Alla stessa stregua potrebbe non bastare trattare i fattori socio-istituzionali come una variabile che si possa «razionalmente» predeterminare attraverso meccanismi di incentivazione economica a favore del sociale. Questo è la parte più delicata e critica della tesi avanzata. Nel senso che una strategia fondata sul primato del sociale potrebbe far trascurare altre scelte pubbliche dalle quali non si può prescindere. Può bastare riprendere il tema della costruzione della fiducia, e degli altri concetti da essa derivati (dalla cooperazione al capitale sociale), a ridare slancio allo sviluppo del Mezzogiorno? La componente “immateriale” è certamente fondamentale nei processi economici, ma il punto è che paradossalmente per svilupparsi e consolidarsi ha bisogno essa stessa dell’esistenza di buone condizioni “materiali”. La fiducia cioè cresce con più difficoltà nei contesti in cui esistono ancora troppi doppi turni per la mancanza di strutture scolastiche, dove i centri di aggregazione sociale dalle piazze ai giardinetti si contano sulle dita di una mano, dove i servizi pubblici sono fatiscenti e non rispondono alle esigenze della collettività. Dove è più facile, perciò, che si acuiscano le spinte verso la ricerca di una soluzione individuale a problemi che sono invece collettivi. E dove quindi gli individui finiscono per adottare la logica del si salvi chi può. La fiducia cresce quindi con più difficoltà, il che non vuol dire che non cresce. Più semplicemente, essa non nasce in un vuoto storico. I legami che si instaurano tra i soggetti che danno vita allo sviluppo e le modalità della loro interazione sono in parte frutto della storia dei territori. Con ciò non si intende sostenere che esista un condizionamento deterministico, ma sarebbe un controsenso affermare che una strategia basata su una logica di radicamento e identità territoriale, possa poi avere dei meccanismi di attuazione e di funzionamento tali da renderla del tutto slegata da esso. In questo non facile compito di ricostruzione del sociale rimane pertanto primario il ruolo delle amministrazioni pubbliche nel creare fiducia sistemica, nell’orientare i comportamenti individuali verso scelte collettive, nel mediare gli interessi individuali, nel sanzionare modi di agire poco rispettosi delle regole. Il punto è che alla base di qualsiasi ipotesi di sviluppo alla componente pubblica spettano compiti diversi da quelli di imparare semplicemente ad attrarre o a distribuire risorse finanziarie, per quanto questi siano aspetti importanti. Si tratta di compiti di garanzia, di neutralità, di controllo delle risorse pubbliche che nell’attività di regolazione sono propri della sfera statale, ma che le vicende del Mezzogiorno, hanno sempre mostrato come difficili da realizzarsi. Compiti mai rivelatosi facili per le amministrazioni pubbliche locali, né nel passato, né nel presente, per la nozione di istituzione pubblica che presiede al funzionamento delle amministrazioni meridionali. Nell’uso delle risorse pubbliche, qualunque sia la fonte di provenienza: Unione Europea, Governo nazionale, Regioni, rimane molto diffusa la pratica secondo cui, nel migliore dei casi, tale uso finisce per essere fine a sé stesso. E questo non ha mai giovato allo sviluppo del Mezzogiorno, né ieri né oggi. Né tantomeno può permettere l’attivazione e la crescita di rapporti fiduciari, poiché in tal modo si finisce per perdere di vista il fine ultimo dell’agire amministrativo: la risposta ai problemi collettivi.
Per tutte queste ragioni, rimane fondamentale agire sul sociale, ma in forte raccordo con altre politiche pubbliche. Le opere infrastrutturali servono, le politiche industriali servono, gli investimenti sulla manutenzione delle scuole, sulla povertà, sull’occupazione femminile e giovanile servono. Bisogna evitare di slegare la società dall’economia. Non si tratta di stabilire un primato tra loro, ma di integrarle. Queste due sfere devono collegarsi maggiormente. Attraverso la ricerca di metodi di azione e strumenti di accompagnamento focalizzati sull’integrazione tra i soggetti svantaggiati, strutturalmente presenti nel Sud, e i programmi di investimento che si realizzano. Politiche per l’industria, politiche per il lavoro e politiche sociali dovrebbero dialogare. Qualunque sia l’ammontare delle risorse disponibili, esso non può essere più sprecato per iniziative che non abbiano coerenza ed integrazione con la ricerca di un piano di rilancio della competitività italiana e con il contenimento delle diseguaglianze sociali e territoriali che caratterizzano, in questo momento, la nazione. Stabilire delle priorità, definire delle scelte pubbliche partecipate e condivise, integrare e concentrare gli ambiti di intervento attraverso la riscrittura di un patto tra le forze sociali per la competitività, l’occupazione e la coesione sociale è un passo da compiere.
Sul che fare per il sociale, Borgomeo detta una linea molto chiara e largamente condivisibile: accumulare capitale sociale, utilizzando anche l’esperienza di casi di buone pratiche presenti nel Terzo settore. Un Manifesto fondato su dieci percorsi − centri per l’aggregazione giovanile, contrasto alla povertà educativa, lotta all’usura, prevenzione della violenza sulle donne, valorizzazione dei beni confiscati, integrazione servizi socio-sanitari, sostegno ai detenuti e alle famiglie, emersione del sommerso, promozione beni culturali e riqualificazione ambientale, revisione delle politiche di accoglienza – che nella loro composizione fanno emergere come l’economia sociale rappresenti una risorsa, non più secondaria e neppure residuale, da attivare e da potenziare. Le potenzialità di crescita di questa peculiare forma di intrapresa socioeconomica sono ancora in gran parte inespresse, sia per quanto riguarda le opportunità sul fronte occupazionale, sia per il ruolo che essa ha nell’offerta di servizi ai cittadini che si aggiungano a quelli ordinariamente forniti e gestiti dalle Amministrazioni pubbliche.
In questo quadro, assume grande rilevanza l’offerta di servizi che gravita intorno al tema dell’integrazione sociosanitaria e della tutela ambientale. Molti dei fabbisogni socio-sanitari, soprattutto quelli provenienti dall’assistenza e cura degli anziani, degli ammalati, dei disabili, sviluppano opportunità lavorative che, adeguatamente sostenute, creano ed ampliano la domanda di riferimento delle imprese sociali. Le criticità finanziarie, infrastrutturali ed organizzative del comparto pubblico sanitario possono così essere compensate dal rapporto sinergico che esso instaura con i soggetti del terzo settore (si pensi alla vasta area dell’assistenza domiciliare integrata). Per di più, oltre a un fattore di cooperazione, che contribuisce a rafforzare il tessuto sociale stesso, si innescano meccanismi di sana competizione che incidono sull’innalzamento degli standard qualitativi nella fornitura e nella gestione dei servizi sociali.
Occorre sperimentare percorsi che includano pratiche di conciliazione tra vita, lavoro e studio. I compiti di riproduzione e cura, dei bambini, dei malati e degli anziani, sono spesso appannaggio delle donne di famiglia che le espletano gratuitamente, oppure di straniere che vengono assorbite da mercati asfittici, percependo retribuzioni in nero e molto basse per la tipologia di lavoro che svolgono. Le difficoltà che incontrano i giovani nella ricerca di lavoro potrebbero poi essere mitigate dall’inserimento in nuove occupazioni agricole, ambientali, del sociale, anche attraverso forme di autoimpiego. Per gli studenti delle scuole superiori o dell’Università, si tratterebbe di promuovere percorsi sperimentali di alternanza scuola lavoro e opportunità di lavoro stagionale.
In sostanza, Borgomeo ci invita a sviluppare un Piano per il sociale collegato ai bisogni economici e sociali emergenti, per evitare forme di assistenza fine a sè stessa. La strada è indicata, ora bisogna percorrerla.
di Paola De Vivo


