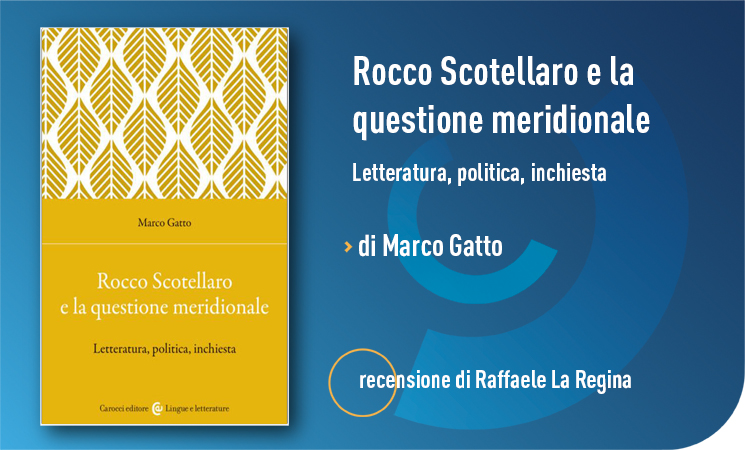
La pubblicazione del saggio di Marco Gatto, intitolato «Rocco Scotellaro e la questione meridionale» (Carocci, 2023), cade volutamente in un momento di grandi attenzioni verso il poeta lucano, sindaco di Tricarico: siamo entrati, difatti, nell’anno del centenario dalla sua nascita, nel pieno di un dibattito nazionale sulle questioni legate al Mezzogiorno, come quello sull’autonomia differenziata o sulla costituzione della zona economica speciale unica. Gatto, professore di Critica letteraria e Teoria della letteratura presso l’Università della Calabria, attraverso questo volume intende sconfessare il mito del “poeta contadino”, spesso coltivato da una certa retorica pubblica, restituendo a Scotellaro un forte ruolo politico e sociale, oltre che culturale.
Il mito del “poeta contadino”, al quale per troppo tempo è stato legato l’intellettuale lucano, è innanzitutto smontabile a partire dalla descrizione del suo nucleo familiare: il padre Vincenzo era un calzolaio mentre la madre, Francesca Armento, era capace di leggere e scrivere, competenza che veniva messa spesso a servizio della comunità di Tricarico. Una figura, quella della madre, fondamentale per Scotellaro e descritta benissimo da Maria Teresa Imbriani, Carmela Biscaglia e Luigi Boneschi nel 2011 in «Francesca Armento. Dalla nascita alla morte di Rocco Scotellaro. Il racconto e le immagini». Anche la sua biografia racconta un contesto borghese all’interno del quale si era formato il futuro sindaco: dal Convitto serafico dei Cappuccini a Sicignano degli Alburni a Cava de’ Tirreni, dal ginnasio a Matera, nel Liceo “Emanuele Duni”, al primo anno di liceo al “Quinto Orazio Flacco” di Potenza, fino al diploma conseguito a Trento, con un anno di anticipo, presso il liceo “Giovanni Prati”. Gli anni della formazione scolastica, trattandosi di un uomo scomparso a soli 30 anni, assumono una centralità straordinaria: la fase in convitto, seppur sofferta, sarebbe stata fondamentale nell’imprimere nel poeta i principi del solidarismo, così come l’anno trascorso presso il Flacco a Potenza ne avrebbe forgiato la coscienza politica in un contesto nel quale, come riporta Gatto citando Angrisani (1980), «si entra fascisti e si esce disimpegnati o antifascisti».
L’autore propone, all’interno di un lavoro di natura bibliografica, di ripoliticizzare il poeta, l’amministratore pubblico, lo studioso, il meridionalista. Nel ripercorrere queste definizioni, ci si rende conto di quanto Scotellaro rappresenti un potente vettore attraverso il quale si proietta un forte messaggio politico, non nel senso più stretto dell’appartenenza partitica, quanto nella più lunga tradizione riconducibile a una particolare attenzione per i problemi del Sud e delle sue genti.
L’analisi dei testi è un punto focale, nel lavoro di Gatto, per ricostruire un momento storico – quello del secondo dopoguerra – nel quale il Mezzogiorno e le classi contadine rivestono un ruolo di assoluta centralità nel processo di ricostruzione economica e sociale del Paese. Nella poesia «La mia patria è dove l’erba trema», ad esempio, Scotellaro prova a rivolgersi non solo a una classe sociale, a una generazione o a una comunità, ma incontra una platea molto più vasta, una intera civiltà. Lui dice di sentirsi un filo d’erba che trema e cioè, uno degli ultimi, uno degli altri. La poesia è del 1949, quando è già sindaco di Tricarico, dopo anni di studio e consapevole di detenere un sapere che rappresenta il tratto distintivo del mondo borghese. Porta il peso sulle spalle di una civiltà contadina ai margini del mondo, confinata nella periferia dell’Italia dove non esistono infrastrutture, lavoro e servizi essenziali. È la Basilicata descritta nel «Cristo si è fermato a Eboli» di Carlo Levi, la fotografia delle aree interne italiane e del Mezzogiorno.
La sua casa è dove l’erba trema, dove si sommano e si moltiplicano le fratture sociali causate dal fascismo, dove la ricostruzione avviata nel 1946 tarda, nei luoghi in cui lo Stato si avverte molto meno e dove nella figura contadina si concentrano tutte le contraddizioni politiche, dal borbonismo al dogma comunista del combattente: tutt’altro, dunque, che una banale descrizione crepuscolare o neorealista come sottolinea lo stesso Gatto.
È nel suo sentirsi poeta al bivio, nell’essere “tenuto” dalla terra, nel suo percepirsi “uno degli altri”, nell’appartenenza a una patria che si colloca “dove l’erba trema”che l’autore prova a ricostruire da un punto di vista narrativo e storico la figura di un intellettuale che esce da una dimensione locale per conquistare un ruolo nazionale di primo piano.
Scotellaro sindaco e dirigente politico del PSIUP è stato capace – nella Basilicata del 1946 e degli anni successivi – di coniugare al meglio, fin dai primi anni di impegno, la chiave di lettura comunista legata al «Piano del lavoro» del 1949 della CGIL e dell’occupazione delle terre, che ebbe il suo culmine nella rivolta di Montescaglioso, con quella della Democrazia Cristiana che immaginava, invece, grazie a un importante lavoro di influenza di Pasquale Saraceno, Donato Menichella e altri intellettuali vicini alla SVIMEZ, un grande piano per la ripresa economica e sociale per il Mezzogiorno attraverso l’intervento pubblico e la convinta centralità dello Stato: proprio quest’ultima impostazione, tra l’altro, avrebbe incontrato finanche il favore di Di Vittorio, seppur con accese discussioni parlamentari nelle quale le opposizioni accusavano di clientelismo la DC, nonché quello di Luigi Einaudi, da sempre considerato faro del liberismo nell’Italia di quegli anni.
Fin dalle prime pagine, nel paragrafo intitolato «La fatica della mediazione», viene in mente il saggio di Gabriella Gribaudi «Mediatori. Antropologia del potere democristiano nel Mezzogiorno». Un testo del 1980, edito da Rosenberg & Sellier, nel quale l’autrice Gribaudi ha codificato pionieristicamente il ruolo di mediazione assunto dai dirigenti della Democrazia cristiana nei confronti delle popolazioni meridionali, nella fase in cui si comprese, specialmente con l’avvio della Cassa per il Mezzogiorno e dopo le elezioni del 1953, anno della morte di Scotellaro, quanto fosse necessario percorrere la via del meridionalismo per lo sviluppo del Paese.
È stata proprio questa la forza del sindaco di Tricarico, il cui impegno andrebbe riattualizzato oltre che ripoliticizzato, consistente nell’aver compreso prima e meglio di altri quanto l’Italia non potesse guardare alla stagione del progresso economico ed industriale senza occuparsi del Mezzogiorno, delle aree marginali, dei contadini meridionali che in quegli anni erano in lotta per la terra, dei servizi sociali essenziali, delle infrastrutture, dei servizi igienici: sono descritti molto bene da Gatto gli anni da amministratore, che meriterebbero un ulteriore approfondimento archivistico. Sono gli anni delle mediazioni, appunto. Mediare in situazioni di grandi emergenze legate alla miseria causata dalla disoccupazione, dalla mortalità elevata, dall’analfabetismo. In quel contesto, pertanto, pare di scorgere anche la necessità di una mediazione culturale di cui si sarebbe dovuta far carico l’élite colta, l’unica in possesso di strumenti capaci di favorire, in un contesto in progressiva trasformazione, non soltanto l’emancipazione, ma anche la piena integrazione del mondo contadino nel nuovo contesto repubblicano.
Una mediazione con la Chiesa e con le classi sociali più deboli fu quella che consentì di dare priorità ad alcuni interventi, come quello relativo alla costruzione dell’ospedale di Tricarico, così come opportunamente descritto da Mazzarone e da Biscaglia, nonché ripresi da Gatto. Il contributo della Chiesa e di monsignor Delle Nocche è riconosciuto come determinante tanto da favorire, il 7 agosto 1947, l’inaugurazione del terzo nosocomio lucano in un territorio assai arretrato.
Intorno all’impegno per l’ospedale credo si possa individuare un filone intellettuale che, pur condividendo la lettura interpretativa di Gatto sull’asse Scotellaro-De Martino-Gramsci, continua a legare il poeta lucano a Levi come emerge dallo scambio epistolare del 1948 fra i due. Una relazione schietta e cristallina fondata sul riconoscere quelle condizioni di miseria descritte in modo preciso dallo scrittore torinese e, da classe dirigente, adoperarsi per uscire da quella situazione provando a dare voce a quelle persone. Un’impostazione che credo possa rappresentare il nucleo di un’analisi che avrebbe assunto struttura nell’inchiesta scotellariana «Contadini del Sud», che Laterza avrebbe pubblicato postuma nel 1955.
Nel recente convegno internazionale Rocco Scotellaro, un intellettuale contadino, scrittore oltre la modernità tenutosi fra Tricarico e Matera dal 26 al 28 giugno 2023, Gatto ha parlato di Contadini del Sud come di un tentativo mirante ad allestire una mediazione mimetica con l’universo sociale contadino che, agli occhi di Scotellaro, appariva addomesticabile, in movimento e ideologicamente frammentato, nel quale esistevano punti di vista inconciliabili.
Egli intende emancipare, in chiave universalistica, le masse popolari rendendole protagoniste delle sue opere. È qui che Gatto trova la chiave di lettura migliore nel politicizzare un grande intellettuale che decide di tornare, dopo un lungo peregrinare, nella propria terra ponendosi il grande problema della militanza che lo porterà a un bivio ulteriore: essere sindaco e interpretare il ruolo che Gramsci aveva identificato con quello dell’intellettuale organico, seppur con una tessera differente nel taschino. Un giovane uomo capace di stringere relazioni nazionali importantissime come quella con Manlio Rossi-Doria con il quale avrebbe collaborato a Portici dove, dopo le grandi delusioni legate alla politica e al carcere, avrebbe partecipato a una ricerca sull’organizzazione del sistema scolastico in Basilicata, entrata successivamente nel Piano di sviluppo del territorio lucano al quale lavorava la SVIMEZ.
Da poeta contadino a poeta universale che, per Gatto, arriva fino ad Alessandro Leogrande e alla sua frontiera attraverso l’autodeterminazione del mondo rurale che parta da una nuova alleanza fra braccianti e contadini poveri contro le logiche dell’agroindustria.
L’opera di Gatto, arricchita dalla prefazione di Goffredo Fofi e dal richiamo a illustri studiosi come Franco Vitelli, Carmela Biscaglia, Maria Teresa Imbriani e altri, riconosce una lezione di grande meridionalismo nei trent’anni di vita di Scotellaro e un ruolo di primo piano assoluto del poeta lucano, riattualizzando il suo sguardo e allungando la prospettiva d’analisi dal mondo arcaico contadino, descritto anche da De Martino, fino ai braccianti sfruttati dal caporalato dei giorni nostri descritti da Leogrande.
Tra storia e attualità, pertanto, una nuova riflessione sull’opera del poeta tricaricese si impone opportunamente alla riflessione politica, prim’ancora che letteraria, nel bivio, stavolta tutto contemporaneo, rappresentato da scelte che siano davvero in grado di traguardare al futuro attraverso la lente autentica e coraggiosa della lezione scotellariana.
di Raffaele La Regina


