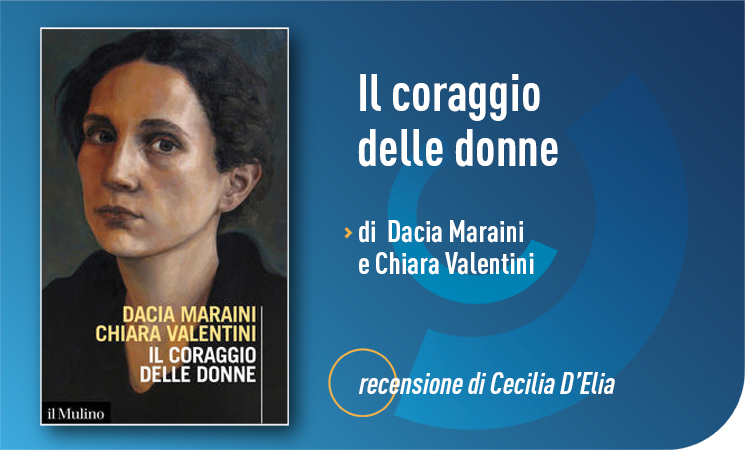
Un carteggio, come quelli di una volta, quando per comunicare bisognava affidarsi alla parola scritta e solo le lettere erano capaci di superare le distanze tra le persone. Nell’anno 2020, tempo di lockdown e distanziamento, mentre L’Onu solleva la preoccupazione che la pandemia faccia tornare indietro di decenni la condizione femminile e i dati Svimez ne confermano la gravità nel mezzogiorno d’Italia, due importanti intellettuali femministe, Dacia Maraini e Chiara Valentini decidono di scambiarsi lettere per continuare attraverso la scrittura il loro costante dialogo sulla condizione delle donne, lo stato dei movimenti femministi, il protagonismo di tante e i rischi del momento (Dacia Maraini e Chiara Valentini, Il coraggio delle donne, Il Mulino, Bologna, 2020, pp.161, euro 14).
Le unisce l’ammirazione per il coraggio di donne che in ogni tempo hanno combattuto per l’affermazione di se stesse. Le autrici sono – come loro stesse raccontano – due scrittrici la cui vita è stata cambiata dal femminismo della seconda metà del secolo scorso. Ogni lettera che compone Il coraggio delle donne è dunque un intreccio di ricordi, riferimenti storici, letture e avvenimenti.
La prima parte del libro, dedicata al bilancio delle conquiste fatte, è anche un’occasione di ricostruzione di quanto avvenuto e di riflessione sull’uguaglianza, la differenza, la ricerca di senso delle donne su sé stesse. La seconda parte è un vero e proprio omaggio al coraggio delle donne. Attraverso la narrazione della vita di alcune di loro, Dacia Maraini e Chiara Valentini celebrano quante in ogni tempo hanno avuto la forza di difendere la propria libertà e l’audacia di quelle che hanno saputo affermare sé stesse, pagandone spesso un prezzo altissimo.
La lettura ci consegna un senso di gratitudine, ammirazione e riconoscimento per le nostre antenate e la forza di sapere che abbiamo una storia. Davvero non è poca cosa, ma è una delle straordinarie eredità del femminismo novecentesco: aver riattraversato l’avventura dell’umanità alla ricerca delle donne, troppo spesso dimenticate nel racconto del passato scritto dagli uomini.
La prima mossa spetta a Chiara Valentini, la quale opta per una dichiarazione di ottimismo, che è anche un modo di guardare alla situazione attuale. Propone di partire da una citazione de La fine del dominio maschile di Marcel Gauchet:
L’avvenimento non è di poco conto. Anzi, è talmente enorme da suscitare incredulità – del genere: “Una cosa simile non può succedere”. Invece può essere così, stiamo assistendo alla fine del dominio maschile. Intendiamoci: è morto come principio, lasciando però dietro di sé tutta una serie di strascichi che possono nascondere la profondità della rottura o consentire di negarne l’esistenza. La fine, comunque, c’è stata e bisogna farci i conti.
Affermazione che a Dacia Maraini appare azzardata, guardando alle discriminazioni ancora in atto in tutto il mondo nei confronti delle donne, anche dove formalmente la parità è stata raggiunta. Si tratta di una discussione cruciale, che attiene al modo in cui si guarda alla fine del patriarcato e alla confusione che ne deriva. Se stiamo alle statistiche sulla parità di genere nel mondo, il potere è ancora saldamente in mano maschile. Ma quello che è profondamente cambiato ovunque è che il “patriarcato è diventato inaccettabile per milioni di donne” (Valentini.) Dunque, non funziona più come sistema globale.
Pur ritenendo che “nel campo simbolico il dominio maschile sia stato intaccato” Dacia Maraini sottolinea invece il conflitto e l’odio nei confronti delle donne che questo suscita e i sentimenti d’ira che sembrano prevalere oggi. Il cammino è ancora molto lungo, quindi.
Pur ricordando i grandi movimenti e le manifestazioni del secolo scorso, entrambe si soffermano sul gesto “rivoluzionario” di una giovane donna. Un’audace “no” al regime del dominio maschile, detto dalla diciassettenne Franca Viola nel cuore degli anni 60. Siamo in Sicilia, ad Alcamo – e qui crollano anche gli stereotipi sull’arretratezza meridionale – e questa ragazza rifiuta il matrimonio riparatore, mostrando l’abominio di una norma che poteva legarti per sempre a chi aveva usato violenza nei tuoi confronti, mettendo in salvo il buon nome di famiglia, ma traducendosi per la sposa in una condanna a vita. Un destino che Franca Viola rifiuta, aiutata dal padre. Il matrimonio riparatore rimarrà nei nostri codici fino al 1981, ben oltre il gesto di Franca. Del resto, solo nel 1996 la violenza in Italia diventa reato contro la persona.
Possesso e dominio hanno segnato i rapporti tra i sessi. E le donne erano educate alla sottomissione. “Il femminismo ha avuto la grande forza di rendere popolare il sentimento dell’ingiustizia storica subita e di proporre un mondo diverso, in cui le donne siano riconosciute come persone pensanti, con competenze, esperienze e abilità proprie e all’altezza di qualsiasi compito.” (Maraini)
Ma il cuore, ricorda Chiara Valentini, è trovare la propria misura di se stesse e del mondo, non di diventare come gli uomini. Dunque, non solo la lotta all’ingiustizia, ma per ogni donna la sfida a poter “esprimere il suo senso dell’esistenza”, come scrisse Carla Lonzi in Sputiamo su Hegel, testo del 1970, tra i più importanti del femminismo italiano.
Il dialogo continua passando dalla questione dell’aborto – l’importanza che ha avuto per affermare la propria autonomia e una maternità responsabile – al modo in cui le donne hanno sublimato gli istinti aggressivi in capacità di cura, al ruolo della cura nella società, affidata in gran parte al lavoro gratuito femminile. E qui vengono in aiuto gli studi di Nancy Fracer. Ma sono tante le donne citate, da Simone De Beauvoir a Harriet Taylor, moglie di Stuart Mill, autrice di alcune opere a lui attribuite. Nel libro incontriamo scrittrici, ma anche i luoghi delle donne, le librerie, gli spazi come le “case delle donne”, le compagnie teatrali.
E c’è il 2020, la pandemia, l’esperienza della reclusione totale, le disuguaglianze acuite dalla crisi sanitaria e economica, l’attualità e l’importanza del discorso femminista, che ha sempre chiesto un cambio di civiltà. Domanda che anima anche la giovane Greta Thunberg. Critica femminista e critica ambientalista del modello di sviluppo si incontrano. Il carteggio piega così sul tema della differenza, del valore del corpo, delle possibili specificità propriamente femminili o in realtà frutto di una collocazione storica che ha determinato attitudini e uno sguardo differente di cui fare tesoro. E si discute molto del movimento femminista, del suo essere carsico, a ondate che irrompono travolgendo “l’omertà” e il senso comune generale in modo inaspettato. Così è successo con il metoo. Ondate che possono aiutare gli uomini a una critica di sé stessi. Oppure provocare la reazione maschile, la paura della fine del dominio, che anima tanto populismo illiberale dei nostri giorni.
La storia ha visto donne coraggiose all’opera e di questo si occupa la seconda parte del libro, dedicata al racconto della vita di alcune di loro, mentre tante sono anche solo citate. Ci sono quelle note, come Ipazia, o altre quasi sconosciute come la poetessa lucana Isabella Morra. Donne che avevano creduto alle paritarie idee del cristianesimo, come Viba Perpetua di Cartagine o alla promessa di uguaglianza della Rivoluzione francese, come Olympe de Gouges. Oppure protagoniste del sogno democratico della repubblica romana mazziniana, come Cristina Trivulzio di Belgiojoso, o regine come Costanza d’Altavilla “una siciliana coraggiosa di cui poco si sa” (Maraini), normanna data in moglie al re svevo Enrico, madre di Federico II, partorito in una pubblica piazza a Jesi perché tutti vedessero che la quarantenne Costanza era capace di dare un figlio e un erede. Fino a Renata Viganò, l’autrice de L’Agnese va a morire, nata borghese, costretta a interrompere gli studi, che decise di diventare infermiera: “così ebbi il mio posto nella classe operaia” e che sceglierà di unirsi con il suo bambino ancora piccolo al marito partigiano e alla resistenza. Chiara Valentini ripropone un’intervista in cui Renata Viganò ricorda quella scelta senza trionfalismo e retorica: “Qui somigliai davvero alla mia bisnonna Caterina …”, che era stata l’iniziatrice dell’azienda di famiglia. Quasi a suggerire che il coraggio delle donne scorre attraverso le generazioni, che è possibile ricostruirne la genealogia.
L’esito della fine del dominio maschile non è scontato, ma la forza e il coraggio delle donne sono ovunque e in ogni tempo.
di Cecilia D’Elia


