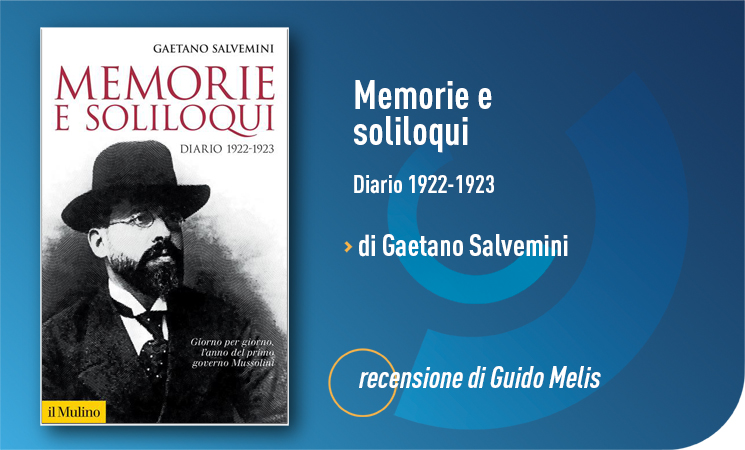
Opportuna ristampa di un libro edito nel 2001 ma che forse ebbe all’epoca poca circolazione. Gaetano Salvemini era poco meno che cinquantenne quando assistette in prima persona agli eventi rievocati in questo suo singolare Diario. Singolare soprattutto perché rimasto l’unico esempio, come subito avverte Roberto Vivarelli nelle non banali pagine che lo introducono, di diaristica salveminiana. L’autore di una sterminata bibliografia, fatta di studi storici importantissimi, di saggi politici acuti e penetranti, di edito- riali e polemiche giornalistiche vivacissime, si concesse al genere intimistico del diario una sola volta in tutta la sua vita operosa, appunto nel breve periodo di questo testo, palesemente scritto “sul tamburo”, giorno per giorno o quasi, senza dedicare troppo tempo alle correzioni e ai dettagli: “Questo diario comincia a portarmi via troppo tempo!”, an- notava del resto lui stesso spazientito nel gennaio 1923. Ciò che lo aveva convinto a scrivere è confessato con la consueta nettezza nella prima pagina del manoscritto:
“Firenze, 18 novembre 1922. Vorrei vedere se mi riesce di tenere un diario continuato degli avvenimenti politici e personali degni di nota. Nella determinazione disperata, a cui sono pervenuto, di abbandonare la politica militante, forse questo diario mi permetterà di sfogare la mia…elettricità con me stesso, anzi che farla esplodere in pubblico: chissà che io non mi avveda che le mie idee, messe sulla carta, non mi ingombra- no più lo spirito, non mi tormentano, non mi spingono più all’azione politica, anche se la carta è destinata a rimanere inedita”.
L’impegno era serio, da non sottovalutarsi, né Salvemini lo sottovalutava: si proponeva infatti di scrivere “almeno una volta la settimana”, senza necessariamente un ordine, quasi nella forma di appunti (e spesso infatti si trovano rinvii ad altre fonti o ab- breviazioni o richiami ad approfondimenti futuri), registrando da cronista ciò che acca- deva; anche per supplire – diceva – ai primi deficit della memoria e per metter da parte “gli elementi per una storia contemporanea vissuta giorno per giorno” (pp. 23-24). An- noterà più in là (9 gennaio 1923, pp. 49-150), in una chiave quasi di riflessione sul mestiere dello storico: “Come è difficile ricostruire la verità anche per fatti così vicini a noi, avendo a disposizione molte fonti d’informazione! La verità dei fatti lontani la ricostruiamo con l’aiuto di notizie frammentarie, che ci risulterebbero malsicure o addirittura false, qualora ci fossero pervenute tutte le altre notizie che si sono perdute. E quanto più si scende nei particolari, tanto più è difficile accertare la verità vera. Si possono ricostruire con relativa approssimazione alla verità le sole linee essenziali degli avveni- menti”.
Tre tipi di materiali, per lo più grezzi, confluivano nella raccolta un po’ magmatica del Diario: il primo era costituito, come naturale, dalle esperienze stesse del suo estensore, dalle sue idee e dalle riflessioni del giorno per giorno: un “diario dell’anima”, insomma; il secondo era rappresentato dalla lettura attenta, quasi minuziosa, analitica, della stampa, specie quotidiana (con annotazioni puntuali, brani fedelmente riportati, commenti a margine); il terzo era il frutto disparato della vastissima rete delle conversa- zioni personali, intessute con amici e collaboratori, a loro volta foriere di ulteriori noti- zie, giacché Salvemini amava registrare il contenuto di commenti, indiscrezioni, fatti e fatterelli anche personali, talvolta inerenti al privato o persino all’intimità dei protagonisti grandi e minori di quel biennio fatale. Fatale perché aperto dalla marcia su Roma (il Diario iniziava non a caso il mese successivo) e teatro degli eventi del primo fascismo al potere, profilava quella che sarebbe poi stata, dal 1925 in poi, la dittatura vera e pro- pria. Non mancavano però anche, come in specie nei reiterati flashback, ritorni indietro della memoria al passato recente: il periodo dell’interventismo (cui Salvemini aveva preso parte con passione sincera) e quello della guerra; quello delle trattative di pace e dei complessi problemi del dopoguerra; la questione delle origini stesse del fascismo sin dal periodo sansepolcrista; il dannunzianesimo e le sue contorsioni prima e dopo i fatti di Fiume; le oscillanti e opportunistiche strategie mussoliniane nei mesi intensi della vigilia del colpo di Stato (ma era poi davvero tale o era stato semplicemente il cedimento del re?), quando erano parse (anche a Salvemini) possibili le più disparate soluzioni del- la crisi italiana, dall’ipotesi non del tutto campata in aria di un governo Mussolini- Turati-Giolitti, a quella di un ministero Salandra aperto ai fascisti.
Emergono dal groviglio delle informazioni (vere e false che siano) specialmente le contraddizioni del dopo- guerra: le titubanze di Vittorio Emanuele III sino al suo voltafaccia filomussoliniano del 28 ottobre 1922; le esitazioni opportunistiche del presidente del Consiglio Facta; le mille facce di un Mussolini più che mai politicien; le errate previsioni di un Giolitti (e forse anche di un Nitti) troppo sicuri di poter svolgere il ruolo dei registi del gioco politico- istituzionale; le estremistiche posizioni del massimalismo socialista e comunista; le con- tradizioni profonde di un Partito popolare spaccato in due tra fedeli a Sturzo e ministerialisti orientati verso il fascismo (e sullo sfondo il ruolo ambiguo del Vaticano). Salvemini aveva informatori dappertutto, e di prima mano: Carlo Sforza era uno di loro (specie sulla politica estera); il cattolico Giuseppe Donati un altro; il vecchio amico fiorentino Paolo Boldrini un altro ancora; e poi c’era l’ambasciatore britannico a Madrid Esme Howard, ma soprattutto Giustino Fortunato, Giovanni Amendola, Giuseppe Lombardo Radice (da leggere le note sulla sua nomina a direttore generale da parte di Genti- le, ministro fascista il cui disegno di riforma scolastica, di ispirazione idealistica, Salvemini condivise), Giuliana Benzoni (attraverso la quale arrivavano le osservazioni del nonno Ferdinando Martini), un don Brizio francescano ma vicino a Mussolini, Giuseppe Borgese, Carlo Rosselli, Piero Jahier, Arcangelo Ghisleri, persino a un certo punto Cesarino Rossi. E Giacomo Matteotti anche, che l’autore incontrò nella biblioteca della Camera e che gli confidò di sperare in un suo (di Salvemini) ritorno nel partito socialista riformista. Ognuno di costoro aveva una sua rete di conoscenze, ognuno gli riferiva più o meno in confidenza ciò che lo interessava; si stendeva così nelle pagine del diario una sorta di mappa cognitiva, ricca di varianti, che andava a saldarsi con quella costituita dai fatti (i giornali) e preparava, opportunamente scremata, quella che sarebbe poi stata la sua interpretazione degli eventi. Come se il Diario fosse un laboratorio un po’ disordinato, nel quale ancora si badasse più a raccogliere i dati per poi tentarne una prima sistemazione, rimandandone magari la definizione a un secondo tempo.
Salvemini – bisogna dire, ma non è una grande scoperta – è stato sempre acutissimo osservatore. Solo, e lui stesso lo ammette nel diario in un passaggio di estrema sincerità, affezionato a volte testardamente alle sue nette e a lungo coltivate antipatie: come quella (una vera ostilità, più che solo un’antipatia) per Giovanni Giolitti, la cui pratica denunciata più volte in passato di “ministro della malavita”, appare all’autore del diario (e lo scrive a chiare lettere) come la vera preparazione del fascismo (gli ascari precursori dello squadrismo), anzi come una sua preventiva legittimazione; o come quella per Filippo Turati, leader del detestato socialismo riformista alleato storico del capitalismo del Nord in nome e per conto degli operai di fabbrica ma contro i contadini poveri del Sud, lasciati senza difesa in mano al grande latifondo agrario: il Turati complice di Giolitti, retore insopportabile in parlamento (si vedano solo, p. 27, le righe quasi di satira dedicate a un suo discorso in aula: “esempio di bello stile nel discorso Turati” è l’incipit urticante).
Che Salvemini nel Diario analizzasse e comprendesse a fondo la natura del fascismo e ne intuisse pienamente sin dal 1923 quale ne sarebbe stata l’evoluzione verso la dittatura aperta e feroce, non si può dire. Come non lo aveva compreso la classe diri- gente liberale, fiduciosa di utilizzarlo in senso antisocialista per poi integrarlo; come a sinistra non lo avevano compreso Bordiga, chiuso nel suo rigido dogmatismo, e Serrati, e lo stesso Gramsci, che lo assimilava a una forma di reazione capitalistica, così anche Salvemini sembra catalogarlo qui nell’ambito delle ricorrenti recrudescenze reazionarie legate ai caratteri storici della borghesia italiana. Ma intanto, mentre si profilava l’interruzione del Diario, i fatti si facevano più eloquenti, e minacciosi. Scriverà il 3 luglio 1923: “Continuo a tenere questo diario stranamente. In verità non c’è nulla di nuovo intorno a me. E quello che succede in me, non mi sento né la volontà, né la capacità di scriverlo!” (p. 389). Si intensificavano le violenze fasciste, arrivavano minacce (addirittura da Mussolini in persona) contro Luigi Albertini, che nel 1925 avrebbe dovuto “vendere” – obbligato dal fascismo – la sua quota nella proprietà del “Corriere della sera”; e don Sturzo si dimetteva da segretario del Ppi, mentre la questura negava allo stesso Salvemini il passaporto per l’Inghilterra. Avutolo, infine, avrebbe annotato da Brighton (28 agosto 1923): “Questo quaderno è rimasto muto per un mese e mezzo (…) Vorrei ora provare a riprendere il tempo perduto” (p. 395). Ma avrebbe proseguito, con soste e brevi annotazioni, solo sino alla fine di settembre. Poi si sarebbe aperta, non solo nella sua vita ma in quella italiana, un’altra pagina drammatica: il rientro in Italia, le elezioni e l’assassinio di Matteotti, l’adesione al “Non mollare”, l’arresto del 1925, l’amnistia, la sua partenza per il lungo esilio.
di Guido Melis


