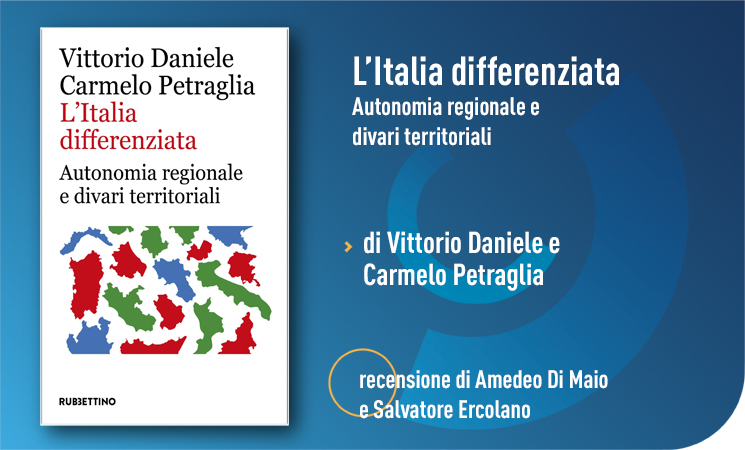
Il volume di Daniele e Petraglia racconta e analizza la cosiddetta riforma dell’autonomia differenziata con il pregio di rivolgersi sia ai «non addetti ai lavori», sia a lettori più strettamente
«economisti». I primi vengono efficacemente informati dell’iter legislativo, delle motivazioni politiche e dei «presunti» richiami di teoria economica che dovrebbero giustificare la scelta di policy. Proprio su quest’ultimo aspetto gli Autori accompagnano il lettore, in maniera semplice ma rigorosa, lungo un sentiero che mostra in che modo i richiami di teoria economica e in particolare di finanza pubblica siano utilizzati spesso in maniera scorretta o comunque parziale dai politici desiderosi a diverso titolo di questa autonomia regionale differenziata.
Sul piano generale gli Autori giustamente inquadrano la legge 86/2024 nel contesto di un Paese fortemente e perennemente caratterizzato da dualismo economico territoriale. Una legge che
«differenzia», territorialmente, ancor di più, «il profilo dei diritti di cittadinanza e delle opportunità offerte ai cittadini» (p. 6). Un «differenziare» che non tiene conto sia del conseguente riemergere della «questione meridionale», sia della illusione che l’autonomia rappresenti condizione necessaria ed esaustiva per la crescita economica del Nord e del conseguente miglioramento della qualità di vita dei suoi cittadini.
Sul piano legislativo gli Autori ricordano che la legge è stata si approvata nel giugno di questo anno ma si basa sulla estemporanea riforma del Titolo V della Costituzione. Riforma di ventitré anni fa riguardante i rapporti tra i vari livelli territoriali di governo e che prevede la possibilità, per le Regioni, di ottenere «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia». Uno dei tanti pregi del libro è quello di non limitarsi alle, pur importanti, vicende riguardanti la possibile attuazione della legge 86. Nel libro si ricorda la formulazione originaria del Titolo V della Costituzione, le dispute politiche, il richiamo alla Costituzione spagnola del 1931, soprattutto per la nascita delle Regioni a statuto speciale, ai modelli mitteleuropei per le Regioni a statuto ordinario, sottolineando una non secondaria osservazione dell’Assemblea costituente secondo la quale l’Ente Regione «non sorge federalisticamente».
Nel testo gli Autori fanno una importante disanima del particolare centralismo delle funzioni di amministrazione pubblica, già presente dall’Unità d’Italia e ovviamente rafforzato nel ventennio fascista. Un centralismo che ha continuato a essere presente anche nella Repubblica nata nel 1946 e che non è stato abbandonato con l’istituzione delle Regioni nel 1970. Un centralismo che tuttavia sembra indebolirsi a partire dalla fine degli anni ‘70 del secolo scorso, soprattutto, rilevano gli Autori, a causa della, pur graduale, rinascita dell’ideologia liberista desiderosa della fine dei sistemi statali socialdemocratici. A questa rinascita si è associata soprattutto in Europa, sul piano politico, l’ascesa di «movimenti regionalisti, secessionisti e federalisti» (p. 12). Questi movimenti sembrano nascere soprattutto dall’idea che l’indebolimento del centralismo (in alcuni casi totale, in altri parziale) non può che condurre a una finanza pubblica decentrata, caratterizzata da una presunta maggiore efficienza, grazie alla quale sarà anche possibile ridurre i divari territoriali. Attraverso dati OECD relativi a paesi dell’Europa, nel libro gli Autori sconfessano questa narrazione, portando alla luce gli elementi che rendono questa storia meno lineare e semplice di quello che si voglia raccontare; infatti, anche confrontando paesi caratterizzati da diversi assetti istituzionali (dal federalismo consolidato della Germania, al più recente assetto federale belga, per arrivare al regionalismo spagnolo) Daniele e Petraglia suggeriscono che, sulla base delle evidenze teoriche ed empiriche «i divari regionali di sviluppo non dipendono strettamente dalla forma di Stato e della sua organizzazione territoriale» (p. 82).
Passando alle possibili ragioni storiche del divario territoriale italiano, nel libro viene ricordata, con una giusta analisi critica, la tesi di Putnam consistente nel motivare il divario Nord-Sud con i differenti assetti politico-sociali caratterizzanti, già dal Medioevo, i due territori, derivante a sua volta dalla prospettiva proposta anni prima da Banfield di un Sud espressione del familismo. Nel libro, piuttosto che accettare questa spiegazione deterministica e comportamentale dalle lontane e incerte origini, che ha spostato l’attenzione dai fattori materiali ai fattori immateriali del dualismo, si riflette (con riferimento alla storia contemporanea) su una «modernizzazione senza sviluppo» (p. 100) dovuta a una spesa pubblica che ha avuto un indirizzo meno rivolto alla industrializzazione, rispetto al
«clientelismo». Fenomeno che, unito all’irrobustimento del sistema di piccole e medie imprese nelle aree del Nord e del Centro Italia, con conseguente necessità di rafforzamento del welfare state, ha generato l’idea dell’esistenza di una questione settentrionale che ha successivamente legittimato la nascita di un movimento politico separatista prima, e poi desideroso di almeno maggiore autonomia regionale, financo differenziata.
Sul piano contabile, la questione settentrionale viene intesa esistente soprattutto guardando ai residui fiscali e una «totale» autonomia regionale sarebbe realizzata solo quando questi diverrebbero nulli. Ovviamente, per totale autonomia v’è da intendersi l’assenza di uno Stato unitario e quindi principii di equità tra i cittadini che andrebbero rispettati solo e solamente nella singola autonoma Regione. Eppure, con i dati riportati nel libro, appare evidente che la spesa pubblica pro capite (dell’Amministrazione) è significativamente più bassa nelle Regioni meridionali, con i valori più elevati nelle Regioni e Provincie a statuto speciale, in particolare del Nord. Ciò conduce a residui fiscali, pro capite, positivi per tutte le Regioni del Mezzogiorno ma anche per quelle speciali del Nord. I valori negativi più elevati riguardano Lombardia, Emilia e Romagna e Veneto, due delle quali hanno in particolare contribuito alla volontà politica di varare la legge sulla autonomia differenziata. Gli Autori esaminano i problemi impliciti (Cap. 5, p. 105 e ss.) e l’aumento delle diseguaglianze (Epilogo p. 123 e ss.) dovute, appunto, al regionalismo differenziato.
Pregevolmente nel testo, pur sempre con una buona capacità di sintesi, gli Autori richiamano in maniera attenta e rigorosa i principali aspetti teorici del cosiddetto federalismo fiscale (o, come avrebbe preferito Domenicantonio Fausto, gli aspetti teorici di finanza pubblica locale), portando alla luce una certa incompatibilità tra alcuni fondanti principi di suddetta teoria con le diverse funzioni che la legge 86/2024 vuole devolvere dallo Stato centrale alle Regioni.
I due Autori correttamente prendono le mosse dalla nota tripartizione «musgraviana», ricordando innanzitutto, sulla base proprio dei principali contributi della teoria del federalismo fiscale, che la funzione della stabilizzazione macroeconomica deve restare di competenza dello Stato centrale anche nei contesti federali. Lo stesso dicasi per la funzione redistributiva che ha a che fare direttamente con i principi di equità orizzontale e verticale; le politiche redistributive in via generale devono riferirsi a tutti i cittadini dello Stato e quindi è opportuno che siano gestite dall’Ente centrale. Anche su questo aspetto, come è noto, pur con marginali distinzioni (si pensi al saggio di Pauly del 1973), la teoria economica tende sostanzialmente a convergere.
Sicuramente più dibattuta è invece la funzione allocativa. Lo suggeriva lo stesso Oates, Autore del cosiddetto teorema del federalismo fiscale; partendo dalla richiamata tripartizione musgraviana, nel suo contributo seminale del 1968, Oates ricordava che se stabilizzazione e redistribuzione rappresentano due funzioni primariamente centrali, esistono diverse ragioni per credere che l’allocazione di determinati beni e servizi pubblici possa essere efficacemente affidata alle Amministrazioni locali.
Nel testo dei nostri Autori si ricorda, anche in linea con la letteratura politologica di matrice prevalentemente statunitense (si pensi a De Tocqueville), che gli amministratori degli Enti decentrati, più vicini agli amministrati, dovrebbero conoscere meglio i bisogni, o come amano dire gli economisti, le preferenze dei cittadini, garantendo quindi forniture di beni e servizi pubblici più efficienti. Tuttavia, esistono alcune limitative condizioni, spesso dimenticate nelle narrazioni approssimative, che, in estremo, consentirebbero un «miglioramento paretiano» nell’allocazione locale (tutte condizioni ben note allo stesso Oates!). In primis la fornitura deve riguardare un bene pubblico che abbia solo rilevanza locale e non crei fenomeni di traboccamento. Anche da questo aspetto, ma non solo, discende che gli investimenti, di valenza locale, non devono prevedere economia di scala. Gli Autori inoltre non dimenticano che la teoria suggerirebbe l’affidamento di questa funzione al Governo locale solo quando le preferenze della comunità siano sufficientemente omogenee attorno a un ipotetico cittadino-elettore mediano; ne discende dunque assumere l’assenza di asimmetrie informative e quindi anche delle cosiddette illusioni fiscali e politiche locali. Gli Autori ricordano che il sistema delle preferenze viene spesso utilizzato anche dai fautori del federalismo competitivo. L’idea di base, a partire dal contributo di Tiebout, è che in presenza di preferenze eterogenee, i cittadini potranno pur sempre «votare con i piedi», in un fantasioso mercato delle residenze dove le scelte abitative, non soggette al mercato del lavoro (è una delle ipotesi base del modello di Tiebout!) discendano dal solito meccanismo ottimizzante e razionale che si arresterà solo quando il beneficio marginale associato a beni e servizi pubblici eguagli il relativo costo marginale. Un ipotetico meccanismo tanto affascinante quanto lontano dalla storia e quindi dalla realtà!
Nel testo si fa luce, dunque, sulla complessità che emerge dalla lettura dei principali contributi della teoria di finanza pubblica locale, sottolineando le criticità intrinseche che sottendono il disegno di legge sull’autonomia differenziata. In primis, non appaiono compatibili qualità e numerosità (23) delle funzioni da far gestire da una autonomia, financo differenziata. Quello che invece sembra emergere è, da un lato, l’indebolimento delle politiche nazionali e, dall’altro, un aumento delle diseguagliane. Al fine di fornire una disamina di questi aspetti, gli Autori prendono in considerazione due importanti beni di merito: l’istruzione e la sanità. Molto in sintesi, la devoluzione della gestione di detti servizi non appare compatibile con l’art. 33 della Costituzione e non può farsi riferimento agli standard minimi, poiché non garantiscono di certo l’eguaglianza di trattamento tra i cittadini dello Stato. Da un punto di vista economico, in questi casi non è la domanda che deve produrre l’offerta, bensì l’offerta che deve incentivare (in alcuni casi obbligare) la domanda. Giustamente, rilevano gli Autori, i divari nazionali di detti beni non possono misurarsi con riferimento alla domanda (per esempio, il criterio INVALSI per l’istruzione) che ha come argomenti della funzione indicatori delle diseguaglianze territoriali (ad esempio, il PIL pro capite); e non ci si può difendere diversamente, su base territoriale, dalle malattie infettive, senza dimenticare che l’offerta del bene meritorio sanità deve tener conto soprattutto del fallimento di mercato rappresentato dalle esternalità (positive e negative). Nel libro si dimostra che l’impianto disegnato nella legge 86/2024 è «una sorta di puzzle» (p. 118), contenente una autonomia differenziata superficiale che crea problemi di finanza pubblica tali da non garantire quantità e qualità dei beni e servizi pubblici per l’interesse generale e per rispettare l’eguaglianza dei diritti tra i cittadini (p. 119 e ss.). Ne discende l’epilogo nel quale si evidenzia quanto con detta legge aumenti il grado delle diseguaglianze esistenti e se ne creino di altre.
Ci appare evidente che l’obiettivo dei due Autori è rendere espliciti i lunghi e complessi meccanismi giuridici ed economici volti alla realizzazione di un sistema di autonomia regionale differenziata. Gli Autori si riferiscono alla esistenza del cosiddetto dualismo in Italia perché, come abbiamo già detto, rappresenta la ragione prima di alcune espressioni politiche che spingono a favore dell’autonomia differenziata ma chiariscono che, indipendentemente da esso, la struttura federale disegnata appare incompatibile con le consolidate teorie economiche e che nella storia, pur recente, non si individuano esperienze simili in altri paesi. Con grande attenzione invece si cerca di mostrare come gli effetti economico-sociali di detta autonomia potrebbero addirittura accentuare una serie di criticità sia nelle Regioni «differenziate», sia nelle altre.
La lettura del libro rafforza la pur ovvia osservazione che il federalismo è unione tra separati e quindi è impossibile farlo nascere da una preesistente unione, soprattutto differenziando.
di Amedeo Di Maio e Salvatore Ercolano


