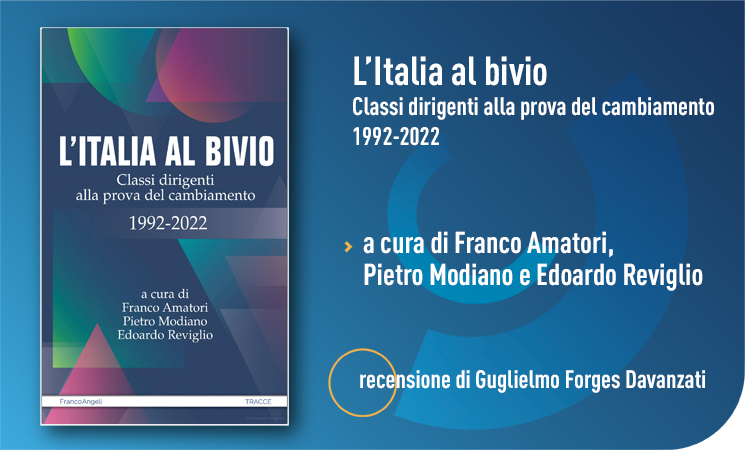
Questo contributo trae spunto dalla lettura del volume curato da Franco Amatori, Pietro Modiano e Franco Reviglio L’Italia al bivio. Classi dirigenti alla prova del cambiamento: 1992- 2022 (Franco Angeli, Milano, 2024, pp. 289) per svolgere alcune considerazioni su cause e conseguenze della svolta impressa all’economia italiana nei primi anni ‘90.
Il volume è parte del filone di letteratura, ormai abbastanza ampio, sul cosiddetto declino economico italiano e si sofferma, in particolare, sulle vicende del 1992. Come è noto, si tratta di un anno cruciale nella nostra Storia recente, per il contestuale verificarsi delle inchieste di Mani Pulite, della crisi valutaria e finanziaria e della firma del Trattato di Maastricht. Vengono qui raccolti i testi di dodici incontri tenutisi nel 2023 presso la Casa della Cultura di Milano, con i contributi di Perugini, Artoni, Modiano, Amato, Amatori, Ranieri, Onado, Reviglio, Bernabé, Musso, Cofferati, Doria, Colli, Cipolletta, Sangalli, Fumagalli Romario, D’Antone, Viesti, Quaglia, Ciocca, Pennacchi, con un’intervista conclusiva a Romano Prodi. Sono voci autorevoli di alcuni fra i principali studiosi dell’economia e della politica italiana e di protagonisti di quella stagione.
I singoli Capitoli si soffermano su aspetti cruciali della vicenda analizzata: il debito pubblico, l’ingresso nell’Unione Monetaria Europea, le privatizzazioni, le relazioni industriali, l’impresa pubblica, i divari regionali. È un libro a più voci, ed è questa la sua ricchezza. Si tratta di un patrimonio informativo importante relativo a vicende che hanno segnato in modo significativo la nostra Storia recente. Il volume di sofferma sul dibattito sulle cause della svolta di politica economica del 1992.
Questo contributo è articolato in tre sezioni. Nella prima, si fornisce una ricostruzione critica di questo dibattito; nella seconda, si aggiungono ulteriori elementi di valutazione, che attengono alla svolta che la teoria economica, su scala globale, subì negli anni ‘80, con ovvi riflessi anche su quella elaborata in Italia; nella terza e ultima sezione, si mostra, anche sulla base di ricerche recenti di chi scrive e della letteratura internazionale recente sul c.d. «declino economico italiano», come e attraverso quali dinamiche macroeconomiche, tuttora in atto, il 1992 è l’anno nel quale si sono poste le basi per delineare una dinamica di lungo periodo di rallentamento del tasso di crescita e aumento dei divari regionali.
- Il dibattito sulle cause della svolta del 1992
Per quanto attiene al dibattito sulle cause della svolta del 1992, gli Autori convergono in una visione sostanzialmente critica delle scelte effettuate quell’anno. Si evidenziano, tuttavia, nella lettura del testo, alcune differenze fra le interpretazioni avanzate dai diversi studiosi, sulle quali è opportuno soffermarsi. Per comprendere i termini del dibattito, conviene partire da questi dati di fatto.
In primo luogo, nel 1992 si realizzò, per l’Italia, un rapido jump to the market, teorizzato e realizzato nei paesi dell’ex blocco sovietico. Si trattò, in altri termini, di transitare dal modello di economia mista e programmata (Barucci, 1978) a un modello basato sui principi della superiore efficienza del settore privato e del mercato come dispositivo di allocazione delle risorse. Come rileva, in questo volume, Pierluigi Ciocca, la fase dell’economia mista e programmata fu caratterizzata da tassi di crescita della produttività del lavoro fra i più alti dell’area OCSE. Proprio a partire dalla svolta dei primi anni ‘90, quell’esperienza cominciò ad essere oggetto di una vera e propria damnatio memoriae, che si attuò mediante una sua raffigurazione eccessivamente semplificata e ricondotta alla generalizzazione di casi, pur esistenti, di corruzione e ingerenza della sfera politica nella gestione delle imprese a partecipazione statale (si veda, su questo aspetto, il contributo di Franco Amatori in questo libro).
Il dibattito sulle cause della svolta ruota schematicamente intorno a due posizioni distinte.
- Da un lato, vi è chi ritiene che – letto a posteriori – il sostanziale fallimento del modo nel quale fu gestita la svolta dei primi anni ’90 – che comunque secondo questa lettura non aveva alternative – sia da imputare alla bassa qualità istituzionale del Paese, ovvero della sua classe politica e dirigente (Salvati, 2000). Ci si riferisce, in particolare, al problema che viene oggi definito della «governabilità», ovvero al fatto che, come scrive qui Romano Prodi, la nostra crescita economica fu frenata dal «continuo cambiamento dei Governi» (p. 268).
- Dall’altro lato, vi è chi – come Pierluigi Ciocca – vede nel 1992 l’avvio di una stagione, che, anche indipendentemente dalla durata dei Governi, appare caratterizzata soprattutto dalla carenza di innovazioni e dalla creazione di rendite: sia per le inefficienze del settore privato, sia per il crollo degli investimenti pubblici in settori ad elevato valore aggiunto e la rinuncia alla politica industriale (p. 243).Questa lettura contrappone alla tesi della debolezza istituzionale la tesi della fragilità della nostra struttura produttiva.
Quest’ultima posizione, a mio avviso, appare convincente e maggiormente in linea con l’evidenza empirica disponibile sul caso italiano relativamente alla relazione fra durata dei Governi e crescita economica. Attenendosi, infatti, a studi accreditati di Storia economica (Toniolo, a cura di, 2013), si può mostrare che le scelte effettuate nel 1992 e la loro reiterazione nei decenni successivi hanno generato esiti esattamente opposti a quelli desiderati. In primo luogo, il grado di
«libertà economica» è considerevolmente aumentato, in Italia, a partire dalla svolta dei primi anni ‘90 (Toniolo, a cura di, 2013, p. 31), a seguito delle privatizzazioni e delle misure di deregolamentazione del mercato del lavoro. In secondo luogo, è aumentata la durata media dei nostri Esecutivi. Questi cambiamenti sono stati diffusamente presentati, negli anni ‘90 e oggi, come successi rilevanti nella direzione del superamento di un modello di sviluppo frenato dall’eccessiva ingerenza dello Stato in economia e dalla breve durata dei Governi. Contro la vulgata, l’evidenza storica mostra, per contro, che gli esiti sono stati esattamente contrari a quelli perseguiti e attesi. In altri termini, gli anni che Toniolo definisce l’«età dell’oro» della nostra economia – ovvero la convergenza secolare con i paesi più sviluppati, – fra il 1950 e il 1973 sono stati anni nei quali gli Esecutivi duravano, in media, nel decennio considerato (ed era inferiore il grado di libertà economica), meno di un anno; gli anni successivi al 1992, con un tasso di crescita della produttività tendenzialmente inferiore alla media dei paesi industrializzati, sono stati, invece, gli anni nei quali i Governi italiani hanno avuto la più lunga durata (quasi due anni).
- Le basi teoriche della svolta del 1992
La direzione impressa alla politica economica nel 1992 fu fortemente condizionata – come evidenziato in questo volume – dalla convinzione che l’elevato debito pubblico fosse il principale problema dell’economia italiana e che le misure di contenimento della spesa pubblica fossero le sole possibili in quelle circostanze.
Restarono inascoltate le tesi critiche, riferibili qui in particolare a quella avanzata da Augusto Graziani, per la quale l’aumento del debito pubblico era il risultato dell’aumento dei tassi di interesse finalizzato all’attrazione di capitali per riequilibrare il saldo della bilancia dei pagamenti e che le politiche di austerità non avrebbero risolto e avrebbero addirittura peggiorato il problema (Graziani, 1998).
Ancora in quest’ambito, si può notare come il ridisegno delle relazioni industriali di quel periodo costituì la realizzazione di orientamenti teorici che motivavano la necessità del contenimento delle dinamiche salariali in Italia e che insistevano sulla opportunità di dotarsi di un
«vincolo esterno». Quest’ultimo fu visto come strumento di disciplina del ceto politico, in vista della realizzazione di misure antinflazionistiche, da raggiungere mediante il contenimento della dinamica salariale e l’austerità fiscale. La teoria economica del periodo rivestì un ruolo importante in questa vicenda: ci si riferisce, in particolare, alla c.d. «controversia Modigliani» (Autore richiamato nel Capitolo di Perugini, in questo libro) e alla tesi in base alla quale l’azione sindacale, nel nostro Paese, avrebbe nociuto alla competitività delle nostre imprese (Cattabrini, 2012).
Sul piano delle idee economiche, si fece affidamento anche alle teorie dei distretti industriali, al c.d. «piccole è bello», alle presunte specificità del nostro capitalismo, per il «saper fare» artigianale e per le relazioni di cooperazione che si instaurerebbero fra datore di lavoro e dipendenti nelle imprese di piccole dimensioni4 e alla possibilità e necessità di esportare il modello dei distretti al Sud. La coda lunga di quella stagione teorica arriva, nei tempi più recenti, passando per l’abolizione dell’intervento straordinario, al prevalere – nel dibattito pubblico e negli indirizzi successivi della politica economica – dell’impostazione di quella che è stata definita la «lega confindustriale» (Giannola e Lopes, 2021) e dell’idea che occorra prendere atto del fallimento delle politiche perequative dei decenni precedenti (Tabellini, 2009)5. Da ciò segue la convinzione che i trasferimenti al Mezzogiorno abbiano costituito esclusivamente spreco di risorse e che il decentramento istituzionale – oggi, attraverso l’autonomia differenziata – rappresenti lo strumento principale per ottenere guadagni di efficienza derivanti dalla responsabilizzazione del ceto politico del Sud.
- Gli effetti di lungo periodo della svolta del 1992 su crescita economica e divari regionali
Come si è detto supra, il 1992 pone le basi del c.d. declino economico italiano, misurabile dalla riduzione di lungo periodo del tasso di crescita della produttività del lavoro e dall’aumento dei divari regionali. Conviene scomporre questi effetti in due sotto-sezioni: (i) la prima attinente ai canali attraverso i quali la realizzazione delle misure neo-liberiste di quella fase hanno inciso con segno negativo sul tasso di crescita della produttività del lavoro; (ii) la seconda relativa alle ricadute di questa impostazione sull’economia del Mezzogiorno.
Procediamo con ordine.
Come ho cercato di mostrare in altre sedi (Forges Davanzati, Patalano e Traficante, 2017; Forges Davanzati e Giangrande, 2020), in linea con alcuni contributi contenuti in questo libro (soprattutto quelli di Cofferati e Pennacchi), e anche sulla scia delle più recenti acquisizioni della letteratura sull’argomento (Storm and Naastepad, 2015; Storm, 2019a; Storm, 2019b), è proprio a partire da quella fase che, si inaugura una lunga stagione di interventi basati sostanzialmente su tre pilastri: le privatizzazioni, il consolidamento fiscale e la moderazione salariale7. Queste misure erano (e sono tuttora) finalizzate a generare un modello di sviluppo neo-mercantilista, di tipo export-led, basato sulla compressione dei costi di produzione e sulla competitività di prezzo. Per le ragioni che verranno sinteticamente esposte a seguire, questa linea di politica economica contribuì ad accentuare la riduzione di lungo periodo del tasso di crescita della produttività del lavoro derivante dalla crescente specializzazione produttiva in settori a basso valore aggiunto, in un’economia popolata prevalentemente da imprese di medio-piccole dimensioni con bassa propensione all’innovazione8, e ad accentuare i divari regionali. Sia qui sufficiente ricordare che dal 1991 al 2023 l’avanzo primario del bilancio pubblico rispetto al PIL è stato pari al 2,3%, superiore al valore registrato in Francia (0,9%) e Germania (0,8%), e secondo, in Europa, esclusivamente al Belgio (2,7%) e che si è avuto disavanzo del settore pubblico solo nel 2009, a seguito della grande crisi finanziaria dell’anno precedente, e nel periodo della pandemia, nel 2020-20219. I salari reali, in Italia, si sono ridotti del 2,9% dal 1990 al 2020, su fonte ISTAT, unico caso nell’ambito dei paesi OCSE. a fronte del +33% della Germania, del +31% della Francia e del +6% della Spagna. La riduzione della quota dei salari sul PIL, nel nostro Paese, è stata la più alta nell’area OCSE (-12% dal 1970 al 2013), seconda solo alla Spagna (-14%). La compressione dei salari, nel nostro Paese, è stato anche l’effetto della crescita relativa dell’incidenza di settori produttivi poco sindacalizzati (per esempio, il turismo, soprattutto nel Mezzogiorno), con l’aumento dell’occupazione, in particolare, nei servizi, e, dunque, con riduzione del potere contrattuale del lavoro anche in altri settori. Giocano un ruolo decisivo le misure di quel periodo in materia di deregolamentazione del contratto di lavoro: la percentuale di lavoratori con contratto a tempo determinato sul totale dei lavoratori dipendenti passa dal 10% del 1993 al 17% del 2022.
- Le privatizzazioni. Come sottolinea, in questo libro in particolare, Franco Amatori, le ragioni che portarono alla vendita di molte imprese pubbliche in quel periodo furono sostanzialmente tre: innanzitutto, si riteneva necessario farvi ricorso per ridurre il debito pubblico in rapporto al PIL; in secondo luogo, vi era molta fiducia nell’esistenza, in Italia, di una «riserva di imprenditorialità in quantità e di qualità tale da rivitalizzare società pubbliche ritenute al presente gestite in modo non efficiente» (p. 69). L’obiettivo di «fare cassa» vendendo proprietà pubbliche fu quello prevalente, secondo questa lettura, e fu strettamente connesso, secondo Amatori, alla «mancanza di un disegno strategico» in ordine a quali settori industriali fosse eventualmente opportuno tutelare, per gli interessi nazionali e per la crescita economica di lungo periodo. In particolare, con le privatizzazioni di quel periodo, si perse il fondamentale contributo che IRI dava alla ricerca e sviluppo. La Storia dell’IRI di Laterza documenta che, ancora negli anni ‘80, la quota di ricerca effettuata in quell’impresa era superiore a quella realizzata da tutto il settore privato (Russolino, 2014). Attenendosi all’evidenza empirica registrata dall’OCSE, nel Rapporto Regulatory Reform in Italy del 2001, come sottolinea Amatori, le privatizzazioni italiane hanno costituito uno dei più imponenti trasferimenti di ricchezza della Storia occidentale da uno Stato sovrano a imprenditori privati. In particolare, il nostro Paese è arrivato tardi a privatizzare, ma ha fatto di più e ha fatto più rapidamente di tutti gli altri paesi industrializzati (così come ha fatto di più e più rapidamente, rispetto ai principali paesi europei, in termini di risanamento finanziario e di misure di flessibilità del lavoro, come misurata dall’Employment Protection Legislation dell’OCSE).
- Il consolidamento fiscale e la moderazione salariale. I meccanismi attraverso i quali le misure inaugurate in quell’anno hanno agito sulla caduta del tasso di crescita della produttività del lavoro sono riconducibili ai seguenti. In primo luogo, le politiche di austerità, riducendo la domanda interna, hanno effetti di segno negativo sul tasso di crescita della produttività del lavoro per l’operare della Legge di Kaldor-Verdoorn, ovvero per la presenza di economie di scala statiche e dinamiche associate all’aumento delle dimensioni d’impresa, di aumento del grado di divisione del lavoro e di approfondimento della specializzazione produttiva in settori ad alto valore aggiunto, di processi di apprendimento e per l’endogeneità dell’avanzamento tecnico incorporato nel capitale (Kaldor, 1966; Sylos Labini, 2004). L’aumento delle esportazioni nette viene, poi, almeno parzialmente vanificato dalla maggiore concorrenza di paesi con specializzazione produttiva paragonabile alla nostra e con analoga modalità di competizione basata sulla compressione dei costi di produzione. In più, per la componente delle nostre esportazioni che riguarda i beni di lusso vale la competitività non di prezzo, incluso l’effetto Veblen, per il quale è al crescere del prezzo che aumentano le quantità vendute: in tal caso, la compressione dei salari non è rilevante per l’acquisizione di quote di mercato negli scambi internazionali. In secondo luogo, la precarizzazione del lavoro accresce l’incertezza dei lavoratori in ordine al rinnovo del contratto e, dunque, incentiva risparmi precauzionali deprimendo consumi e domanda interna. In più, in quanto consente alle imprese di recuperare competitività attraverso compressione dei costi ed elevato turnover dei dipendenti, tende a disincentivare le spese per la formazione professionale e le innovazioni frenando, per questa via, il tasso di crescita della produttività del lavoro.
La riduzione del tasso di crescita della produttività del lavoro si inscrive in una dinamica europea caratterizzata dalla crescente polarizzazione, fra un core (Germania e paesi del Centro- Nord del continente) e due periferie, peraltro in un contesto globale caratterizzato da crescente finanziarizzazione e de-industrializzazione: quella dell’Est Europa, soprattutto dopo l’allargamento ai paesi di Visegrad del 2004, e quella mediterranea, che include l’Italia nel suo complesso15. Per quanto possa apparire prima facie contro-intuitivo, l’evidenza empirica mostra che nel continente vi è stata convergenza del PIL pro capite prima dell’unificazione monetaria (in particolare, dal secondo dopoguerra alla prima crisi petrolifera del 1973) e che, in particolare dopo l’adozione della moneta unica, si è semmai registrata divergenza o, nel migliore dei casi, stazionarietà (De Grauwe, 2016). L’economia italiana approfondisce il suo ruolo di fornitore di produzioni intermedie al capitale del Nord Europa, generando, al tempo stesso, un movimento interno di crescita delle divergenze regionali (Accetturo et al., 2022), con il Sud che accentua la configurazione di esportatore di input (in particolare, forza-lavoro qualificata) in regime di dipendenza da centri decisionali esterni (Cresti et al., 2023; Dosi et al., 2015)16. Questa modalità di partecipazione al network produttivo globale ed europeo peggiora considerevolmente la qualità del lavoro in Italia e, ancor più, nel Mezzogiorno (Ardeni e Gallegati, 2022). Il downgrading delle produzioni italiane, soprattutto se riferito alla perdita progressiva di intensità tecnologica, va di pari passo con la compressione del tasso di crescita relativo del Paese, che, non a caso, aumenta meno della media europea da venticinque anni.
A decorrere dalla svolta del 1992, la crescita dei divari regionali è la conseguenza di queste dinamiche, per l’operare di un duplice effetto: l’uno spontaneo, l’altro indotto dalla politica fiscale:
- L’esistenza di un meccanismo che, seguendo Gunnar Myrdal (1957; 1959), si definisce «causazione circolare cumulativa» (CCC). Una volta, cioè, determinatasi l’agglomerazione di imprese in una determina area (in questo caso al Nord) per l’operare di economie di scala, quell’area diventa un attrattore di investimenti provenienti da altre aree. Cresce dunque il PIL nell’area già ricca e tendono ad amplificarsi i differenziali di crescita. Un’economia di mercato deregolamentata produce, per questa via, crescenti diseguaglianze territoriali e lo fa spontaneamente. Il meccanismo si autoalimenta e non si arresta automaticamente: l’aumento dei redditi nell’area ricca spinge i lavoratori, particolarmente quelli più qualificati, a emigrare dall’area più povera, generando, anche per questo meccanismo, guadagni di produttività nella prima e, simmetricamente, perdite di produttività nella seconda21.
- La non neutralità territoriale delle politiche di austerità. Le misure di consolidamento fiscale messe in atto, in particolare, negli anni della c.d. crisi dei debiti sovrani (2010-2013) hanno avuto conseguenze particolarmente negative sull’economia meridionale, a ragione di una duplice circostanza: la bassa propensione alle esportazioni delle imprese del Sud, che hanno quindi, beneficiato in misura ridotta della moderazione salariale; il progressivo ridursi del perimetro della P.A., tradizionale e rilevante datore di lavoro nelle regioni più povere (De Vivo e Russo, 2021; Aimone Gigio e Camussi, 2022).
- Considerazioni conclusive
In questo contributo è stato proposto un commento critico ad alcune autorevoli riflessioni sulla svolta del 1992 contenute in un libro recente curato da Franco Amatori, Pietro Modiano e Franco Reviglio. È stato rilevato che quella svolta è all’origine del c.d. «declino economico italiano» degli anni successivi e ha dato luogo alla reiterazione di una linea di politica economica che, con l’obiettivo di superare il modello italiano di economia mista programmata, ha peggiorato, per quasi tutte le macro-variabili considerate, le condizioni dell’economia italiana.
Il volume è estremamente rilevante non solo come documento storico, ma anche come strumento di riflessione sulle condizioni dell’economia italiana di oggi ed eventualmente sulle sue prospettive. Una futura auspicabile ricerca su questi temi potrebbe utilmente approfondire maggiormente l’analisi dei condizionamenti che quelle scelte subirono, non solo per l’ingresso nell’Unione Monetaria Europea e, quindi, per il «vincolo esterno» (qui ampiamente dibattuto), ma anche per le conseguenze per l’Italia della riunificazione tedesca del 1990 e soprattutto per la nostra ri-collocazione geopolitica a seguito della fine dell’esperienza sovietica.
di Guglielmo Forges Davanzati


