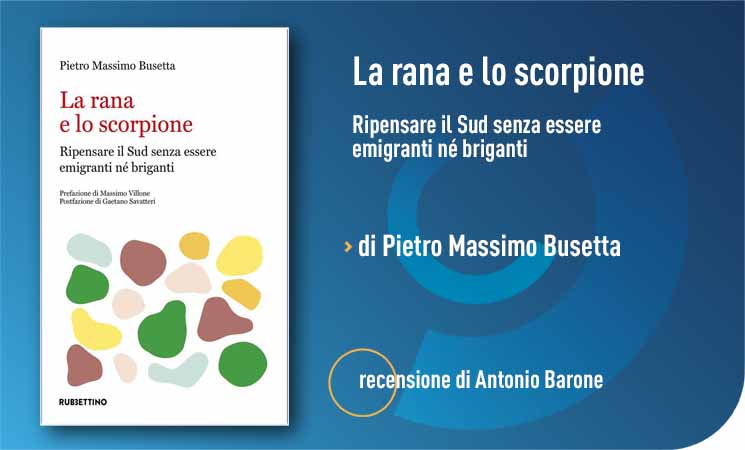
Con “La rana e lo scorpione. Ripensare il sud per non essere né emigranti né briganti” Pietro Massimo Busetta completa la trilogia di lavori monografici dedicata ai temi della “questione meridionale”, con l’obiettivo di disvelarne le ragioni più profonde che (in particolare) l’hanno aggravata nel corso del tempo.
Agli occhi del giurista gli studi di Busetta colpiscono per la capacità straordinaria di interpretare un labirinto di dati quantitativi di grande interesse, che forniscono una chiave di lettura originale e mai banale. Sia sufficiente pensare che se il Mezzogiorno fosse uno Stato dell’Unione Europea, sarebbe quello fra i più popolosi, precisamente il sesto Paese.
L’analisi che l’Autore conduce ha il sapore di una critica amara, al contempo serrata e graffiante, mai arrendevole, piuttosto costruttiva e propositiva rispetto a tematiche purtroppo poco esaminate dalla dottrina giuspubblicistica.
Il volume si apre con un accorato appello (di sturziana memoria) rivolto ai “liberi e forti” affinché, senza pregiudizi e preconcetti, trovino la forza e il coraggio di farsi protagonisti di un cambiamento epocale, culturale prima ancora che politico e istituzionale, capace di condurre alla rinascita del Paese. Busetta invita i lettori ad abbandonare l’idea di un meridione colpevole del proprio destino, accendendo i riflettori sulle responsabilità del governo centrale, della classe dirigente “del nord” spesso in combutta con la “classe dirigente estrattiva meridionale”, interessata a mantenere lo status quo. Ciò con una netta critica nei confronti della ormai drammatica carenza di infrastrutture e servizi alle persone (asili nido, scuola, sanità, etc.), così come nei confronti della prevalente e comunque prioritaria destinazione di risorse e investimenti in favore del nord Italia, con il correlato incremento di fenomeni migratori e desertificazione di competenze a danno del meridione.
L’Autore invita altresì a riflettere sul ruolo chiave che il Mediterraneo sta assumendo nelle politiche europee e internazionali, specie a seguito dell’emergenza bellica che ha colpito l’Ucraina. Elemento, questo, che non può essere trascurato se l’Italia tutta vuole evitare di perdere competitività a livello sovranazionale.
Busetta sente il bisogno di ricercare colpe e colpevoli nelle politiche del passato. Attraverso un’analisi a tutto tondo, spesso procedendo per sciabolate orizzontali, senza esclusione di colpi per nessuno e con incedere incalzante, l’Autore si addentra nei “gironi dell’inferno”, per la gravità delle responsabilità a ciascun soggetto imputate, per i ritardi, le inefficienze, le frodi subite dal Mezzogiorno.
Ben 18 gli imputati al tavolo accusatorio: dall’Unione europea, ai governi del passato, alla classe dirigente meridionale “estrattiva” (non già inclusiva e propositiva), all’istituzione del “PUN” (partito unico del nord), alla chiesa, ai difensori d’interessi consolidati (Confindustria e sindacati), ai media, passando in rassegna, poi, più in generale, le scelte politiche spesso prive di visione sistemica, dal federalismo all’autonomia differenziata (che creerebbe zone del Paese “di serie A” e altre “di serie B” incrementando le disuguaglianze e i divari di cittadinanza), le scelte economiche operate dalla Banca d’Italia, e infine, non ultimi, le mafie, le massonerie, i clientelismi.
L’Autore non risparmia critiche all’attuale dibattito sui LEP, sui criteri di riparto delle risorse su cui si sono fondati, in particolare quello dalla spesa storica, nonché alla visione ancora miope che del Mezzogiorno si ha, quale riserva dell’apparato produttivo della restante parte del Paese, fatta propria secondo Busetta anche dal Governo attuale.
Dalle ceneri del passato e sulle rovine non sempre mal celate del presente, l’Autore trova ancora lo slancio per guardare al futuro, per compiere quella rivoluzione copernicana necessaria per rilanciare l’Italia ripartendo dal Mezzogiorno, dalla presa di coscienza della necessità di attuare politiche
differenziate per le due parti del Pese (centro-nord e Mezzogiorno), pur nel rispetto di una strategia che deve essere espressione di una visione unitaria del Paese.
Molte le idee propositive per future riforme politiche: dalle ZES manifatturiere, al rilancio del turismo, alla valorizzazione delle piattaforme logistiche e delle infrastrutture, sino alla proposizione di politiche fiscali di vantaggio, alla differenziazione del cuneo fiscale.
L’Italia, del resto, è stata la principale destinataria dei fondi del Next Generation EU proprio in applicazione dei criteri di riparto di queste risorse in sede europea, come il PIL, il reddito pro capite ed il tasso di disoccupazione. I meriti o, se si vuole, i demeriti della parte più debole del nostro Paese, in particolare del Mezzogiorno, hanno quindi legittimato il primato italiano nella acquisizione dei fondi europei Next Generation, come lucidamente evidenziato da Busetta.
L’analisi del volume “La rana e lo scorpione” stimola numerose riflessioni di taglio giuridico che, nell’economia del presente contributo, non possono essere compiutamente sviluppate (talora anche in termini critici). Tuttavia, un dato centrale emerge nitidamente per il giurista: il lavoro di Busetta rilancia l’ormai ineludibile riflessione sui doveri costituzionali perequativi di fronte alle sempre più insostenibili disuguaglianze territoriali che caratterizzano il nostro Paese.
Come è stato evidenziato, questo è il tempo della politica di coesione a livello europeo, unico vero argine di fronte ai rischi connessi all’aumento drammatico dei divari territoriali in conseguenza dell’emergenza pandemica. La questione meridionale italiana, al pari della questione della riunificazione tedesca, non riguarda e non può riguardare solo una parte del nostro Paese ed è, anzi, una priorità nazionale ed al contempo una questione di interesse europeo.
«Ripresa e resilienza» presuppongono la coesione economica, sociale e territoriale: ripresa e resilienza non possono realizzarsi senza coesione economica, sociale e territoriale. Lo sviluppo sostenibile, infatti, implica il superamento degli squilibri sociali, culturali e territoriali.
Il nostro è quindi (anche) il “tempo della perequazione”; un tempo in cui finalmente riconoscere un vero e proprio dovere costituzionale di assicurare la coesione tramite interventi perequativi dello Stato in favore delle comunità territoriali più deboli; un dovere costituzionale che trova fondamento negli artt. 2, 3 e 119 Cost. e che si lega direttamente con le previsioni del TFUE in materia di coesione (ad esempio, gli artt. 174 e 175).
Questo dovere costituzionale di perequazione, di assicurare la coesione tramite interventi perequativi, vincola sia il legislatore che l’amministrazione e non può non trovare appositi canali di giustiziabilità. Sul fronte dell’Amministrazione, in particolare, la prospettiva del «dovere amministrativo inderogabile» (di perequazione), rilancia il profilo della doverosità della funzione amministrativa, della non dismissibilità dell’intervento perequativo. Questo dovere di perequazione trova talora previsioni legislative di espressa attuazione e assume quindi i tratti dell’obbligo giuridico, con importanti conseguenze anche sul fronte della tutela processuale.
In via esemplificativa, può pensarsi al caso della c.d. perequazione infrastrutturale nell’ambito del federalismo fiscale. In questa ipotesi, l’inerzia amministrativa nell’adozione dei provvedimenti attuativi della perequazione infrastrutturale può essere contestata attraverso l’apposito rito processuale contro il silenzio della pubblica amministrazione. Parimenti, la violazione degli obblighi di perequazione infrastrutturale determina la illegittimità degli atti amministrativi in tal senso eventualmente adottati.
Anche il mancato rispetto del vincolo del 40% della destinazione delle risorse PNRR in favore del Mezzogiorno può trovare sanzione giurisdizionale, ad esempio sul piano della illegittimità dei bandi competitivi per l’assegnazione di tali risorse, che mettono in competizione (strutturalmente impari) le autonomie territoriali del Mezzogiorno con quelle del centro-nord. Ciò, peraltro, a fronte del dato recentemente certificato dalla Corte dei Conti, secondo cui oltre il 40% degli enti territoriali di Sicilia, Calabria e Campania sono in situazione di dissesto o pre-dissesto finanziario, incapaci quindi di programmare le proprie politiche di bilancio e del personale per raggiungere livelli di maggiore competitività.
Volgendo lo sguardo ad un’altra epoca storica, è innegabile che, pur tra luci e ombre, tra l’inizio degli anni ’50 e la metà degli ’70 dello scorso secolo si è realizzato l’unico caso della storia d’Italia in cui il divario Nord-Sud si è effettivamente ridotto.
Si trattò di interventi molto importanti legati a scelte politiche non contingenti, (quanto meno) di medio periodo. Peraltro, la fine dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno non può cancellare i risultati in termini di modernizzazione che furono raggiunti.
L’emergenza pandemica ha rilanciato gli interventi di coesione attraverso la perequazione nella prospettiva della loro doverosità, della loro non dismissibilità, ricollegandosi direttamente alla garanzia dei diritti fondamentali della persona. Il “tempo della perequazione” richiede anche scelte organizzative forti, in via straordinaria anche a scapito delle autonomie territoriali, attraverso la creazione di nuove strutture centralizzate capaci di gestire o comunque supportare gli enti territoriali nella gestione dei fondi NGEU.
Nella prefazione del volume, Massimo Villone evidenzia lucidamente come perseverare nelle politiche attuali significhi consegnare il Mezzogiorno al mesto destino della desertificazione economica e sociale, legittimando uno scenario “non solo incostituzionale, ma soprattutto politicamente ed eticamente inaccettabile”.
Sono profondamente convinto che il corretto inquadramento giuridico delle tematiche magistralmente esaminate da Busetta possa contribuire a rendere effettive le soluzioni da adottare per invertire l’inaccettabile situazione attuale del nostro Mezzogiorno. L’attuazione dei doveri perequativi, la “battaglia” civica per la riduzione dei divari di cittadinanza non possono che svolgersi nel contesto del nostro ordinamento democratico, con autonomie territoriali e cittadini “liberi e forti” disposti finalmente ad attivare nei confronti dello Stato centrale le garanzie (anche giurisdizionali) esistenti (e troppo spesso ignorate) per la tutela dei propri diritti e interessi.
di Antonio Barone


