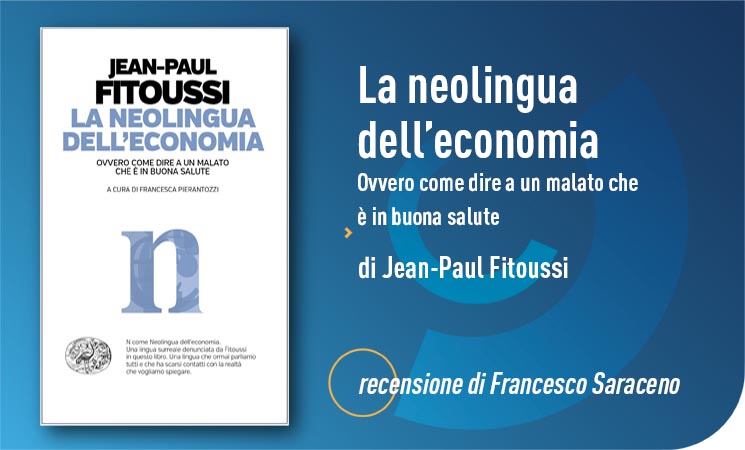
Con La neolingua dell’economia, scritto in forma d’intervista con Francesca Pierantozzi, Jean-Paul Fitoussi sferra un attacco frontale alla doxa che ha dominato la teoria e la pratica della politica economica negli ultimi quarant’anni. Questo volume viene a chiudere un cerchio ideale, che Fitoussi ha iniziato a tracciare nel 1995 con Le débat interdit (tradotto per Il Mulino nel 1997). In Il dibattito proibito Fitoussi aveva fustigato l’ossessione dell’epoca per il controllo dell’inflazione come unico mezzo per assicurare stabilità macroeconomica e crescita. Erano gli anni della disinflazione competitiva e dei tassi d’interesse elevati, che riducevano l’inflazione ma facendo pagare all’economia un prezzo elevato in termini di «crescita molle» (un’espressione usata spesso da Fitoussi) e disoccupazione elevata. L’economista francese non era l’unico a criticare la svolta neoliberale della politica economica, che in quegli anni cominciava ad impregnare le istituzioni e le politiche europee. Ma l’originalità di Il dibattito proibito, che ne spiega il successo, consisteva proprio nel concentrarsi sul discorso pubblico che aveva accompagnato la svolta neoliberale dei primi anni ’80. Un discorso pubblico marcato da un pensiero unico che si era rapidamente imposto dopo la crisi della teoria keynesiana, restringendo progressivamente lo spazio per visioni alternative e arrivando alla fine ad una sorta di autocensura di intellettuali e policy makers: il dibattito proibito, appunto. È proprio in quegli anni, del resto, che Margaret Thatcher coniò il celebre motto There is no Alternative (TINA), riferendosi alle politiche di riduzione dell’intervento pubblico in economia. Già negli anni ’90, insomma, l’attenzione di Fitoussi si concentrava sull’influenza del dogmatismo in economia sulla libertà e sulla qualità del dibattito pubblico.
Il pensiero unico contro cui Fitoussi si batte fin dagli anni ’80 è la versione moderna della teoria neoclassica, incentrata sulla superiorità dei mercati nel coordinare le azioni di agenti razionali e massimizzanti. I mercati convergono autonomamente verso un equilibrio detto «naturale», che in caso di assenza di rigidità e imperfezioni di mercato è anche ottimale. In questo quadro, il ruolo della politica economica è solo quello di rimuovere le imperfezioni tramite le riforme strutturali (avvicinando così l’economia all’equilibrio ottimale) e garantire la stabilità dei prezzi per non perturbare il funzionamento dei mercati. In altre parole, la politica economi ca non sceglie tra equilibri diversi, ma facilita il funzionamento dei mercati. In quanto tale, essa può essere affidata ad istanze tecnocratiche, che individuano l’equilibrio naturale dell’economia, e mettono i mercati in condizioni di raggiungerlo; anzi più che potere, essa deve essere sottratta alla sfera politica, per proteggere i meccanismi di mercato dall’appropriazione di rendite da parte di interessi particolari che controllano il processo politico.
In Il dibattito proibito un Fitoussi combattivo ma ottimista riteneva che proprio la moneta unica e l’integrazione europea, che negli anni ’90 avanzavano a passi da gigante, fossero l’occasione per riaprire la discussione che si era fatta asfittica all’interno dei confini nazionali e riportare le scelte sull’economia nella sfera della politica. Con il passare degli anni, la prospettiva dell’economista francese si è fatta sempre più cupa. Il palcoscenico europeo non ha consentito di liberare un dibattito che era diventato pensiero unico; al contrario, ha trasferito a livello europeo la tentazione tecnocratica, sostituendo la dialettica democratica con un governo delle regole (monetarie, di bilancio) contro cui Fitoussi si scaglia già in Il dittatore benevolo. Saggio sul governo dell’Europa (Bologna, Il Mulino, 2003). Oggi l’economista francese si fa poche illusioni sulla capacità del vecchio continente di liberarsi dai vecchi dogmi e recuperare spazi di democrazia e di dibattito.
In La neolingua dell’economia Fitoussi ha perso l’ottimismo del passato. In primo luogo constata che ormai il dibattito sulla politica economica è condotto in termini che impoveriscono, semplificano e in ultima istanza banalizzano la discussione. Esattamente come preconizzato da Orwell in 1984, citato da Fitoussi fin dalle prime pagine del suo saggio, le élite hanno creato una neolingua che elimina o rende priva di significato ogni espressione che potrebbe servire ad instaurare il dubbio che esistano alternative alle teorie e alle politiche dominanti:
Il procedimento è questo: inventiamo un linguaggio basato su una teoria immaginaria (che può anche essere una vera teoria, ma non capita spesso) e ce ne serviamo per piegare la realtà ai nostri bisogni, per limitare la nostra comprensione al frammento più improbabile del reale (La neolingua dell’economia, p. xii)
Il saggio è disseminato di esempi, e ne prenderemo solo uno, quello di riforme strutturali. Nel dibattito pubblico degli ultimi trent’anni con quest’espressione si è designato l’insieme delle politiche volte a rendere flessibili i mercati e a ridurre il ruolo dello Stato nell’economia. In primo luogo, le riforme del mercato del lavoro volte a ridurre la protezione dell’impiego e a rendere flessibili i salari; ma anche le privatizzazioni, la liberalizzazione dei servizi, il ritiro dello Stato da settori essenziali come l’istruzione e la sanità (e abbiamo visto di recente come questo abbia avuto un costo insostenibile quando la pandemia del COVID ci ha colti impreparati). In realtà, riforme strutturali sono anche la costruzione del welfare state, che come nota Fitoussi ha radicalmente trasformato le nostre società; ma anche, per fare esempi specifici di casa nostra, lo Statuto dei lavoratori, il sistema delle partecipazioni statali e via di seguito. L’influenza della neolingua è pervasiva, anche tra chi si pone criticamente rispetto al mainstream in economia. In un articolo recente sulla crisi e sul debito (Between Scylla and Charybdis: Income Distribution, Consumer Credit, and Business Cycles, in «Economic Inquiry», vol. 57, n. 2, 2019, pp. 953-971.), Alberto Cardaci e io concludevamo che per evitare l’instabilità finanziaria fosse necessario un ritorno ad una tassazione più progressiva sentendoci molto trasgressivi quando presentavamo la proposta come una «vera riforma strutturale». E trasgressivi effettivamente eravamo, perché riforma, nella neolingua europea, significava privatizzazioni e liberalizzazioni, nient’altro. Qualunque altra politica di struttura, così si è trovata marginalizzata già solo per il fatto di non avere un’espressione che la definisse. Ma gli esempi di concetti banalizzati o semplicemente eliminati dal discorso, e quindi dalla tavolozza delle politiche possibili sono moltissimi, dal concetto di domanda a quello di disoccupazione, dall’efficacia della politica di bilancio al ruolo della Banca centrale, dalla globalizzazione senza regole alla politica industriale.
Insomma, la neolingua dell’economia ha fatto collassare l’insieme delle scelte possibili in un solo insieme di politiche, le politiche neoliberali. Ripetiamolo ancora: se esiste solo una politica ottimale, la sfera politica non deve compiere scelte, e può demandare la gestione dell’economia al tecnocrate che meglio di chiunque altro è capace di facilitare la convergenza verso il migliore dei mondi possibili. There is no Alternative, appunto. Per questo, rendendo inutile la politica, la neolingua ha giocato un ruolo fondamentale nel restringere lo spazio della democrazia e alimentato il risentimento verso le élite che hanno incarnato queste politiche, le hanno imposte come sola opzione e si sono appropriate di gran parte dei benefici. Di fatto, nota Fitoussi, i cosiddetti «poteri forti» sono sempre esistiti; ma proprio imponendo un pensiero unico e svuotando gli spazi democratici all’interno dei quali si sarebbero naturalmente organizzati i contropoteri, in questa fase storica essi sono riusciti a disinnescare qualunque resistenza alla loro capacità di appropriarsi di parti sempre più grandi della torta (come argomentato estensivamente da ri cercatori come Thomas Piketty, Tony Atkinson, Branko Milanovic). Pur senza simpatizzare con i movimenti populisti (altra parola il cui uso nella neolingua attira le ire di Fitoussi: dopotutto, cosa dovrebbe fare un buon politico, se non gli interessi del popolo?), l’economista francese non può fare a meno di notare che è solo tra le loro fila che si allineano coloro che tentano di sparigliare, di opporsi al pensiero unico e di tornare alla centralità della politica.
Dalla lettura di La neolingua dell’economia emergono altre due considerazioni che mi stanno a cuore. La prima, relativamente marginale nel saggio, riguarda il ruolo dell’intellettuale nel dibattito pubblico. Fitoussi si lamenta del fatto che prima delle sue apparizioni mediatiche gli viene quasi sempre raccomandato di «parlare semplice», rivendicando invece il diritto del pubblico ad avere informazione di qualità e ad essere reso edotto della complessità delle scelte di politica economica. È un messaggio importante in quest’epoca di economisti da talk show, che parlano semplice ma non informano, finendo per essere inutili quanto i criptici abitanti delle torri d’avorio accademiche, ma molto più dannosi. L’economista che decide di partecipare al dibattito pubblico, soprattutto in quest’epoca in cui l’informazione è di continuo amplificata e distorta dai mille «canali social», ha la responsabilità di non cadere mai nella semplificazione fine a se stessa, i cui effetti sulla qualità della democrazia sono così ben descritti da La neolingua dell’economia.
La seconda considerazione, collegata alla prima, riguarda l’effetto del dogmatismo in economia. A Francesca Pierantozzi che lo definisce keynesiano, Fitoussi risponde di non essere «credente», ma solo alla ricerca di una teoria che lo aiuti ad offrire soluzioni per i problemi delle nostre società. Per poi affermare poco oltre che:
L’immaginazione in economia – e forse non solo in economia – significa non essere prigionieri di nessuna dottrina, altrimenti tutto è già scritto, è la negazione del libero arbitrio. L’immaginazione significa mantenere una parte di spirito libero capace di vedere quello che è possibile. Se si è prigionieri del passato non c’è posto per l’immaginazione (La neolingua dell’economia, p. 71).
È una riflessione che mi tiene particolarmente a cuore. In La scienza inutile (Roma, LUISS University Press, 2018) ho recentemente descritto come nel corso del ventesimo secolo le scuole neoclassica e keynesiana abbiano assunto alternativamente il ruolo di paradigma dominante, ognuna emergendo dalla crisi dell’altra. Ho anche mostrato che la deriva autoreferenziale dei paradigmi di volta in volta dominanti ha comportato, inevitabilmente, l’incapacità di cogliere la complessità dei problemi economici; un sistema complesso e a volte contraddittorio veniva di volta in volta costretto a forza nella gabbia interpretativa del paradigma, ignorando, o peggio occultando, ogni elemento che non fosse conforme. Questo richiede, concludevo, di tornare a studiare la storia economica e la storia del pensiero, che a lungo hanno proprio avuto la funzione di evitare il tranello della semplificazione. Credo che Fitoussi condividerebbe questa riflessione.
Il quadro che Fitoussi dipinge è fosco, come quello che descrive Orwell in 1984. Se negli anni ’90 era forte la speranza che il progetto europeo potesse essere la chiave per liberarsi dalla presa del pensiero unico, oggi l’Ue e al suo interno la moneta unica sono invece un ulteriore veicolo di restrizione degli spazi democratici. In primo luogo, perché le élite tecnocratiche di Bruxelles e Francoforte sono allineate con quelle nazionali (e come potrebbe essere altrimenti?); in secondo luogo perché la creazione di istituzioni di tipo federale come la BCE e il conseguente trasferimento di parte della sovranità al livello sovranazionale ha delegittimato i Governi nazionali (soli responsabili di fronte agli elettori) e a volte consentito loro di scaricare la responsabilità di scelte impopolari su non meglio definiti burocrati europei.
Vorrei però concludere su di una nota di ottimismo. Mi piace pensare che il Fitoussi degli anni ’90 abbia ancora qualcosa da dire, e che ci siano margini per tornare ad aprire spazi di democrazia e di dibattito nella gestione dell’economia europea. La crisi finanziaria globale ha avviato una salutare discussione tra i macroeconomisti, e cose dieci anni fa impensabili, come un Fondo Monetario Internazionale che spinge per piani di investimenti pubblici senza curarsi del debito, sono ormai parte del dibattito di politica economica, ulteriormente scompaginato dalla crisi del COVID-19. Anche l’Europa si muove, infine, con grandi piani di sostegno all’economia, politiche monetarie aggressive e con il Fondo per la Ripresa, per la prima volta nella sua storia, una sia pure parziale e temporanea mutualizzazione del debito e un programma di investimenti ambizioso.
Non è sicuro che questa situazione di «fluidità» teorica porti ad un definitivo abbandono dei vecchi dogmi e della neolingua. Ma mi piace sperare che se la conversazione tra Fitoussi e Pierantozzi avvenisse ora, ci troveremmo qualche elemento di ottimismo in più.
di Francesco Saraceno


