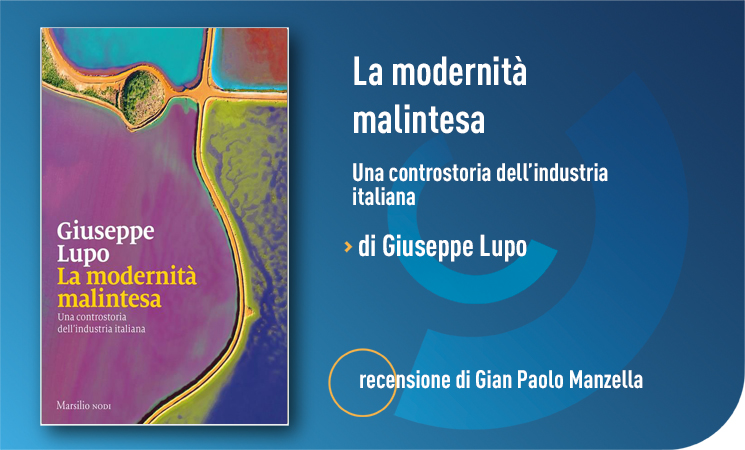
Il volume di Giuseppe Lupo è un libro importante per chi si occupa di industria come fa l’Associazione che promuove questa rivista. Il libro è, infatti, una lunga cavalcata nella letteratura ‘industriale’ italiana del ‘900 e di questo scorcio di nuovo millennio. Ma non è, quella di Lupo, una cavalcata ‘a briglia sciolte’. Tutt’altro. Pur in un volume che è per molti versi caleidoscopico, la direzione che l’autore imprime alla sua riflessione è precisa e ruota, lungo tutte le sue pagine, attorno ad alcune domande, tanto affilate quanto centrali, e che, lo si capisce, appassionano e inquietano Lupo: professore alla Cattolica di Milano, collaboratore del Sole 24 ore e, con tutta probabilità, il maggior esperto italiano di letteratura industriale.
Il punto attorno al quale ruotano le riflessioni dello studioso lucano è, infatti, di qualche rilevanza: la nostra letteratura ha effettivamente capito la modernità legata allo sviluppo industriale? È riuscita a guardare a quello che le accadeva attorno senza cadere in prese di posizione ideologiche, senza cedere alla tentazione di utilizzare lenti tanto rassicuranti quanto poco adatte a capire un ‘Mondo nuovo’? La risposta di Lupo, e la sua tesi, sono altrettanto chiare. Il panorama letterario italiano si divide, secondo l’autore, tra chi questa modernità non ha capito e la ha osservata legandola a doppio nodo con temi come l’abbandono della cultura contadina, l’alienazione dell’individuo, la perdita delle radici dei singoli, e chi, invece, ha colto nella ‘fabbrica’ quegli elementi di vitalità e di libertà che erano propri del nuovo contesto. Le squadre in campo sono di diverso calibro. Quella dei ‘nostalgici’ schiera personalità come Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Paolo Volponi, Luciano Bianciardi, Edoardo Sanguineti, Umberto Eco. La seconda, quella di chi guarda la modernità da una diversa prospettiva, è fatta di autori come Ottiero Ottieri, Carlo Emilio Gadda e, soprattutto, Leonardo Sinisgalli, che ambisce alla sfida più significativa, quella del dialogo tra cultura scientifica e umanistica, ed a cui Lupo dedica alcune tra le pagine più belle del suo lavoro.
Le due ‘squadre’ sono quindi evidentemente sbilanciate, a testimonianza che il tarlo che muove il libro, e cioè il dominare nel Novecento italiano di una narrazione antimoderna, ha effettivamente roso la percezione della complessità del moderno italiano e contribuito ad un complessivo ritardo nel racconto della nostra “grande trasformazione” del secolo scorso: quella da paese agricolo a paese industriale.
Questa tesi di una sostanziale distanza degli intellettuali dall’economia e dall’industria – con la sola eccezione della vicenda umana, politica ed industriale di Adriano Olivetti, talent scout e valorizzatore delle migliori energie intellettuali del suo tempo – è esplorata guardando alla vicenda da diverse prospettive: quella delle grandi famiglie, e qui Lupo mette in rilievo l’assenza di un grande romanzo italiano della borghesia; quella degli operai e delle loro rivendicazioni, raccontati, tra gli altri, da scrittori come Antonio Tabucchi e Alberto Bellocchio; quella degli intellettuali, di cui si pone in rilievo il rapporto complesso con la committenza: sia quella politica, sia quella del mondo dell’economia. E, ancora, prendendo la prospettiva delle grandi imprese, ci si interroga sulle ragioni del fiorire, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, delle riviste aziendali ‘in mano ai letterati’: da “Pirelli” a “Gatto selvatico”, da “Rivista Italsider” a “Civiltà delle Macchine”, la più nota e la più longeva di tutte. Ed è proprio qui, in questo incontro tra le regole degli house organ e lo sguardo degli intellettuali, il tentativo sicuramente più importante, originale ed ‘italiano’ di quel tempo: quello di suscitare un dialogo vero tra umanisti e uomini di tecnologia, quello di replicare nella letteratura ciò che negli stessi anni stava facendo quel design capace di portare insieme tecnica e valori artigiani e che diveniva “vetta del migliore Novecento” (p. 129).
Ma sono solo alcune delle linee di lettura di un volume che è una rassegna completissima di lavori, di autori, di iniziative e che ognuno e ognuna colloca in una specifica posizione: quella dei grandi della letteratura dal Novecento – ai nomi che si sono già menzionati vanno aggiunti, tra gli altri, quelli di Elio Vittorini, di Goffredo Parise, di Primo Levi; quella degli scrittori operai, come Luigi Davì e Tommaso di Ciaula; gli scrittori di oggi (da Michela Murgia a Silvia Avallone) che riprendono ad interessarsi del lavoro e dei suoi luoghi ma che non smarriscono, secondo Lupo, la vena antimoderna di chi li aveva preceduti; quella, ancora, dei viaggi in fabbrica dei poeti (Vittorio Sereni) e dei letterati (Alberto Moravia) o le raccolte di racconti di chi in fabbrica lavorava, come quelli confluiti nel volume a più voci Meccanoscritto o i Gettoni industriali dedicati da Einaudi proprio alla narrativa legata alla modernità industriale.
Di particolare interesse per i nostri lettori la sezione del libro dedicata al Mezzogiorno (Tutto comincia e finisce al Sud, p. 185). Per paradossale che possa apparire, ma non lo è, la parabola della letteratura industriale italiana inizia e finisce a Sud; più in particolare a Bagnoli, il luogo in cui sono ambientati sia uno dei primi libri di questo genere – “Tre operai” di Carlo Bernari del 1934 – sia uno dei suoi epigoni – “La dismissione” di Ermanno Rea, del 1992. Due opere che raccontano la vita e la morte di quello che è stato forse il più emblematico tentativo di portare l’industria nel Sud, quello dell’acciaieria Ilva, chiamata a portare la cultura dell’impresa nei vicoli di Napoli. Un tentativo malinconico a giudicare dalle erbacce che oggi circondano ‘Ferropoli’, ma che avuto momenti di futuro quando, ancora sotto l’impulso della legislazione Nittiana, Napoli fu effettivamente tra le capitali industriali italiane. Ma altrettanto significativa, per lo sguardo del meridionalista, anche la letteratura operaia, che in alcuni anni – da Balestrini a Fofi, passando per Di Ciaula – si soffermò a raccontare cosa fosse la vita degli operai meridionali nelle città del Nord, quali fossero forme e motivazioni della loro protesta, in che modo si inverava, in loro, il passaggio dalla cultura contadina a quella industriale.
Proprio rispetto al Sud è possibile chiudere con una linea di speranza che è anche un’indicazione di lavoro. Se il volume muove dal confronto tra l’architettura industriale di Via Sarca a Milano – dove emerge e si delinea una modernità reinventata – e quella di una Bagnoli da decenni abbandonata, invece, tra le colline e il mare ad un suo destino burocratico, si scorge, alzando lo sguardo, una possibilità diversa. Basta osservare come l’Università Federico II ha trasformato lo stabilimento Cirio a San Giovanni a Teduccio in un centro di ricerca, didattica ed incubazione di startup, o visitare imprese – la Kineton, ad esempio – che si sono insediate in antichi edifici della Napoli industriale trasformandoli in open space in cui lavorano ingegneri ed esperti di digitale in dialogo con il mondo. Indicazioni, molto concrete, della possibilità di un altro Sud.
In conclusione di questo libro ricchissimo, e da cui si esce con coordinate chiare sulla letteratura industriale italiana, c’è un compito ben preciso per scrittori e poeti. Ed è quello di raccontare con maggior attenzione i cambiamenti e le trasformazioni che toccano oggi il mondo dell’impresa e del lavoro: sempre più fatto di contaminazione di linguaggi e di culture; di ricerca e di competizione; di precariato e di ingresso dirompente della tecnologia nella quotidianità; di un rapporto diverso dei lavoratori con un mondo ‘di fuori’ sempre più aperto e conosciuto; della nuova vita di edifici e di rinnovate centralità cittadine; di impresa innovativa proiettata nel futuro insieme a scheletri industriali abbandonati e che richiamano ad altre vite ed altri tempi. Tutti elementi che hanno la potenzialità di essere le basi per un racconto italiano pienamente immerso nella modernità, libero di descriverla nella sua realtà e crudezza, senza cessioni a nostalgie ed ideologie: oramai fuori tempo e solo foriere di confusioni ed errori di prospettiva. È un compito importante: per la letteratura e per la società nel suo complesso. Perché è essenziale se vogliamo squarciare quel velo di diffidenza tra cultura e impresa, tra politica e mondo imprenditoriale, che, come antico riflesso, periodicamente riemerge nel dibattito politico e che tanto pesa sull’identità più profonda del nostro Paese.
di Gian Paolo Manzella


