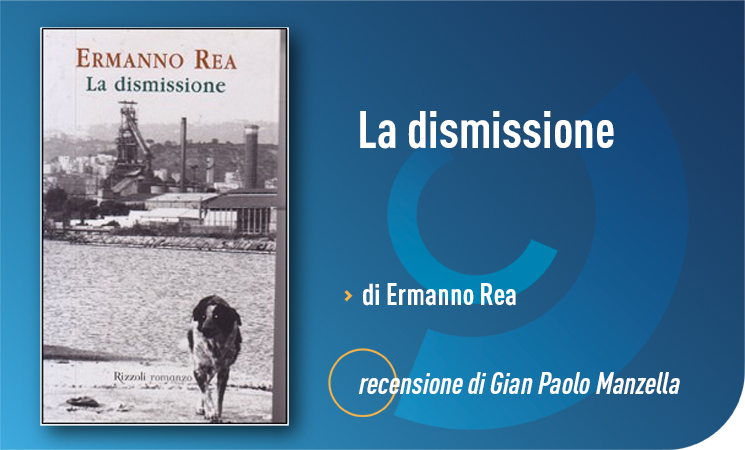
È l’8 luglio del 1904, in piena era Giolittiana, quando si approva la legge n. 385 sul “Risorgimento economico di Napoli”: una normativa con cui si vuole sostenere l’industrializzazione del capoluogo campano destinato, nell’intenzione dei suoi promotori, a diventare volano economico dell’intero Mezzogiorno. È una legge, come noto, che porta la firma di Francesco Saverio Nitti e che segna, in qualche modo, un momento di passaggio per l’Italia, che passa da un’impostazione di politica economica liberista ad una, invece, di carattere più spiccatamente interventista.
È proprio qui, in qualche modo, il punto di partenza del bellissimo libro di Ermanno Rea – La dismissione – di cui tra qualche mese si celebrano i vent’anni. Perché è proprio sulla base degli incentivi previsti dalla Legge per Napoli che la società Ilva, basata a Genova, decide di impiantare a Bagnoli uno stabilimento per la produzione dell’acciaio, che vedrà la luce nel 1910. Uno stabilimento che per anni cresce, entra nell’orbita IRI, che durante la seconda guerra mondiale si ingrandisce con un secondo altoforno e che diventa in qualche modo il simbolo dell’industrialismo meridionale, di una vocazione ‘inaspettata’ di questa città.
L’obiettivo era, come si dice in questo romanzo, “portare l’Ilva nei vicoli”, permearli di cultura del lavoro, dell’organizzazione, della legalità. Ed effettivamente per molti anni attorno all’Ilva nasce una vera cultura operaia napoletana: fatta di puntualità, serietà, qualità delle produzioni.
Il volume di Rea ricorda la fine di tutto questo. Il momento in cui, sulla base di un combinarsi di ragioni – dal mercato internazionale alla rivalutazione del dollaro, dai problemi di management dell’industria ad un clima politico-sindacale molto difficile – si prende la decisione di dismettere lo stabilimento e si procede al suo smantellamento. Il libro di Rea è il racconto puntuale e tecnico della dismissione di questo gigantesco stabilimento – dall’inventario alle cariche di dinamite con cui lo si demolisce sino all’imbarco sulle navi dei pezzi più pregiati venduti (o svenduti) in tutto il mondo.
Una dismissione che è, a sua volta, simbolica di ben altre dismissioni: a ben guardare ancora più gravi. Quella di Napoli come città industriale, testimoniata dai dati che portano il crollo dell’industria della città avviato all’inizio degli anni ’70, della “cultura industriale napoletana” che aveva riempito le vite di un’intera comunità di lavoratori e delle loro famiglie. Quella dell’intervento pubblico nell’economia, perché la vicenda Ilva si colloca all’avvio del lungo periodo delle privatizzazioni, che ha ridisegnato il capitalismo italiano. E, insieme, anche la ‘dismissione’ di tutta una serie di persone legate all’Ilva.
La scelta di un romanzo a due voci in cui l’autore dialoga con, è un nome di fantasia, Vincenzo Buonocore – uno degli impiegati più autorevoli dell’Ilva, incaricato della delicatissima fase dell’inventario – ci lascia, infatti, la possibilità di ‘entrare’ nella comunità operaia e incontrare una serie di persone che vedono in questa dimissione la fine del loro mondo, dell’esperienza umana che aveva ‘vertebrato’ le loro vite. Innanzitutto, lo stesso Buonocore, che con inevitabili contrasti interiori guida il processo di distruzione di quello che aveva costruito nella sua vita; Carlo Martinez, il sindacalista che è in qualche modo il mentore di Buonocore e che sente dissolversi il mondo dei suoi idealismi; la giovane Marcella, figlia di uno dei migliori colleghi di Buonocore, che si perde nelle tentazioni della ‘Nuova Napoli’ dimentica della cultura operaia; sino a Fang Chu, l’inviato dell’industria di Stato cinese chiamato a capire bene come utilizzare lo stabilimento appena acquistato per rilocalizzarlo in Cina e che piano piano si apre a Buonocore mostrandogli il suo profilo più melanconico; quello di uomo superato dal tempo e dai cambiamenti che il suo Paese si avvia ad intraprendere.
È il ritratto di una comunità che, senza più punti di riferimento, si sfalda: a livello macro e micro. Sino allo stesso matrimonio di Buonocore, che regge con sempre più evidenti difficoltà al carico di tensione legato a tutto quello che accade intorno. Sullo sfondo – ma neanche tanto – tutti i livelli amministrativi: il Comune di Napoli, la Regione, il Governo italiano (sono gli anni della famosa assemblea all’ILVA dell’allora ministro De Michelis), sino alla Commissione europea (è il tornante della vita della Comunità in cui si elabora il Piano Davignon per l’acciaio).
E, ancora, il libro apre uno sguardo sui fenomeni di globalizzazione, perché i ‘pezzi’ della acciaieria arrivano in Cina e in India, in un esito che in qualche modo anticipa molti dei temi che abbiamo avuto di fronte negli ultimi anni.
È quindi un romanzo ‘corale’, che tiene insieme dalle scelte macro sino alle ripercussioni che queste scelte hanno nella comunità napoletana, nelle famiglie, nelle psicologie dei singoli. Ed è per molti versi proprio questo che ci dice il romanzo. Tutto è sempre più interconnesso ed è proprio perché tutto è legato che è necessaria una politica che sia effettivamente ‘olistica’, capace, cioè, di tenere insieme tutti i diversi profili legati ad una singola vicenda.
È una prospettiva che suggerisce allo studioso e all’operatore dell’economia del Mezzogiorno che è necessario ripartire proprio dall’elemento culturale. Perché quello che colpisce della vicenda umana di Vincenzo Buonocore è proprio la nostalgia di questo universo valoriale dal quale si sente d’improvviso estromesso. Un universo fatto di principi, appunto, fondati sul lavoro e sul fatto di essere parte di una comunità che attorno a quei valori di modernità e innovazione si costruisce.
Chiunque conosca Napoli e il suo ambiente imprenditoriale e quello accademico sa che queste capacità, questo potenziale di capitale umano ci sono e sono pronte ad essere messe all’opera in un programma di sviluppo in questa direzione.
Il libro di Rea, pur nella malinconia del racconto della fine di un’epoca che lo avvolge, è in questo senso un lavoro che vent’anni dopo ha la sua profonda attualità: quella di indicare una precisa direzione di marcia – quella, appunto, del lavoro culturale – verso cui andare.
di Gian Paolo Manzella


