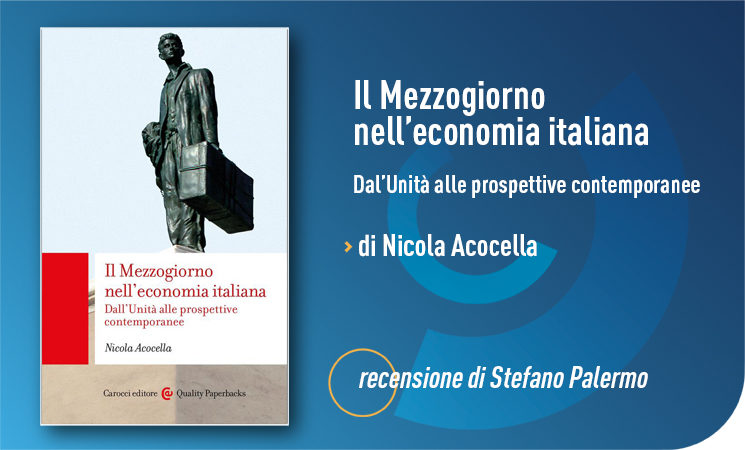
Dai primi anni Ottanta è stata abbandonata – e non è stata più recuperata – quella logica di lungo periodo che è tipica delle politiche attive dello sviluppo. Questo richiede di associare l’azione ordinaria di politica economica agli interventi straordinari e di insistere non soltanto sulle politiche della domanda, ma anche e soprattutto su quelle dell’offerta […], puntando a un accrescimento delle dimensioni di impresa, con la riduzione dello spazio di quelle aventi minori dimensioni […]. Indubbiamente questi suggerimenti specifici rappresenterebbero un avanzamento rispetto al presente. Si tratterebbe però di un avanzamento non decisivo […]. I miglioramenti non saranno mai decisivi fino a quando non si aggredirà il problema meridionale in tutte le sue componenti, che non sono solo economiche (N. Acocella, Il Mezzogiorno nell’economia italiana. Dall’Unità alle prospettive contemporanee, Roma, Carocci, 2021, pp. 130-131).
Queste considerazioni, inserite nella parte finale dell’ultimo volume di Nicola Acocella, riassumono il senso dell’operazione culturale che l’Autore compie con una pubblicazione snella, ma densa di dati e interpretazioni. Un libro in grado di restituire al lettore anche meno avveduto una fotografia a trecentosessanta gradi della questione meridionale, inserendola all’interno della più generale evoluzione della società italiana ed evidenziando quegli elementi che possono aiutare a comprendere il collegamento tra le dinamiche del passato, le criticità del presente e le prospettive future.
Il testo muove da due fattori principali che ‒ insieme ad altri ovviamente ‒ ne sorreggono l’impianto complessivo: il primo riguarda la necessità di considerare la questione meridionale in una logica sistemica e di lungo periodo; il secondo afferisce alla necessità di rileggere le ragioni del divario ‒ e della sua persistenza nel tempo ‒ attraverso un modello di analisi che tenga insieme diversi piani ed elementi per assumerne in pieno la complessità e le diverse angolature. Un approccio inquadrato sin dalle pagine introduttive, quando Acocella sottolinea che:
Questo libro vuole fare il punto sul problema del Mezzogiorno, non soltanto indagando sull’evoluzione della sua economia e società dal dominio borbonico ai nostri giorni attraverso il consueto indicatore del reddito […], ma anche tenendo conto di quelle grandezze che vanno aggiunte al reddito per configurare l’indice di sviluppo umano […]. In questo modo si vogliono individuare le tappe del percorso che ha portato alla situazione attuale, influenzando i vari aspetti dello sviluppo meridionale in comparazione con quello nazionale (Ivi, p. 11).
Il richiamo all’indice di sviluppo umano, agli indicatori delle Nazioni Unite e «ai conetti ispirati al pensiero di Amartya Sen» (Ivi, p. 11) si traduce nella scelta di coniugare l’analisi cronologica con quella diacronica, andando a leggere accanto ai dati economici, quelle tematiche o direttrici che hanno segnato la questione meridionale, rintracciandone i fattori di continuità e discontinuità nelle tre fasi principali individuate: l’Italia pre-unitaria; il periodo compreso tra l’Unità e la Seconda guerra mondiale; dal secondo Novecento alla nuova globalizzazione. Un percorso lungo oltre centocinquant’anni nel quale le variazioni dei dati economici sono considerate sempre come elementi interni di una lettura complessiva della società italiana e meridionale. In questo senso si collocano i richiami, che si susseguono nelle diverse parti del volume, al tema demografico, alle dinamiche del contesto sociale (dalla criminalità al sistema formativo) o alcuni elementi su cui l’Autore torna ‒ e a ragione ‒ con particolare insistenza come il capitale umano, quello sociale, le modificazioni del tessuto produttivo, il ruolo delle istituzioni e delle classi dirigenti, il rapporto tra il contesto nazionale e i mutamenti dello scenario globale. A ben vedere, si tratta di una periodizzazione e di una scelta di temi in grado di legare l’analisi della questione meridionale e dell’evoluzione del sistema Italia alle più recenti riletture sulle dinamiche dello sviluppo economico moderno e sulle caratteristiche dell’attuale riorganizzazione dei modelli produttivi e degli equilibri geoeconomici internazionali.
Una rivisitazione della storia della questione meridionale, dunque, scritta con la “cassetta degli attrezzi” di un economista capace di tenere insieme piani anche molto differenti, in un approccio multidisciplinare sempre ricondotto a unità interpretativa. Questo è possibile anche grazie alla capacità dell’Autore di riuscire ad accompagnare il lettore nella amplissima bibliografia utilizzata sui diversi argomenti affrontati; l’opera ‒ questo un ulteriore punto di forza del volume ‒ ha il merito di cogliere con attenzione il valore di tanti percorsi interpretativi e del dibattito che, anche muovendo da approcci e filoni di ricerca spesso non omogenei, si è sviluppato nel tempo tra storici, storici dell’economia ed economisti.
I primi tre Capitoli del libro, dedicati al Mezzogiorno preunitario e all’Italia liberale, offrono uno spaccato importante sulle caratteristiche socioeconomiche del divario, sulla stagione delle origini e su alcuni elementi che contribuiranno a segnare anche le epoche successive. Acocella si muove in una vasta letteratura sulla fase post-unitaria che, fin dal primo meridionalismo e poi ancora nel Novecento, è stata caratterizzata da proposte, visioni, interpretazioni che richiamano alle peculiarità (variamente declinate) del Mezzogiorno; molti sono i richiami a modelli di analisi che hanno segnato ‒ e in parte ancora segnano ‒ una stagione storiografica, evidenziando l’Autore i punti di forza di ogni tesi, come anche i punti di contatto (in questo senso si muove ad esempio Acocella nella descrizione delle analisi di Daniele e Malanima o, ancora, nell’utilizzo del concetto di “modernizzazione passiva” richiamandosi alle prime tesi di Cafagna o riprendendo gli studi di Felice e Vasta4). L’Autore non si limita, tuttavia, a descrivere dati e modelli, ma sceglie di intervenire richiamando sempre l’attenzione alla complessità del fenomeno:
Anzitutto, il riferimento al solo dato del reddito pro-capite della media delle regioni nelle due circoscrizioni può in realtà essere fuorviante. Altri e più disaggregati indicatori dell’economia e della struttura sociale potrebbero essere altrettanto, o più, illuminanti […] (Ivi, p. 50).
Da qui la proposta di Acocella per un modello di analisi ancorato alla ricostruzione dei dati e funzionale a una lettura non schematica della questione meridionale:
Occorre quindi una analisi il più possibile spassionata sia dei chiaroscuri preesistenti sia dei vantaggi e degli svantaggi che scaturiscono dall’unificazione. […] Cercheremo di vedere in particolare come le indubbie tare preesistenti non abbiano resistito all’impatto delle politiche unitarie, in assenza di politiche specifiche per il Mezzogiorno come quelle che saranno adottate successivamente alla seconda guerra mondiale (Ivi, p. 52).
La seconda parte del volume affronta proprio le tematiche che dal dopoguerra arrivano sino al tempo presente. Anche in questo caso, l’analisi del dato economico è accompagnata dalla presentazione dei mutamenti del contesto sociale di riferimento, inteso nella sua accezione più ampia. Il punto di partenza ‒ oramai consolidato in letteratura ‒ è l’individuazione nella fase della golden age quale unico momento di significativa convergenza tra le due aree del Paese. La cesura, rispetto alla fase precedente è innanzitutto nelle scelte delle classi dirigenti (non a caso il Capitolo si apre con una rapida ma efficace rassegna delle principali elaborazioni sulla questione del sottosviluppo meridionale all’indomani del conflitto). Il dato demografico e quello infrastrutturale sono utilizzati per spiegare le caratteristiche della lunga fase di catching up cominciata negli anni Cinquanta e interrottasi, sostanzialmente, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta. Acocella sposa la centralità delle politiche attive dell’offerta della prima fase dell’intervento straordinario ‒ richiamandosi all’impostazione di Saraceno e all’elaborazione di Lepore su quello che si manifestò come un modello peculiare di “keynesismo dell’offerta” ‒ per spiegare la crescita dell’economia meridionale; una strategia nata prima con la riforma agraria e poi implementata con il varo dell’intervento straordinario e con gli investimenti delle imprese pubbliche su cui ha scritto pagine molto rilevanti De Benedetti7. Si tratta, come noto, di un passaggio centrale non solo della storia del Mezzogiorno ma della ricostruzione di tutto il Paese nel secondo dopoguerra, in grado di definirne logiche e direttrici di lungo periodo. Lo è sul piano internazionale, in virtù dei legami che si creano sulle due sponde dell’Atlantico tra Banca Mondiale e la struttura tecnico-politica alla guida della Cassa per il Mezzogiorno; lo è sul piano interno, nel momento in cui la neonata Repubblica assume con il varo dell’intervento straordinario la centralità della questione meridionale. Un passaggio frutto di un percorso molto articolato ‒ come ha recentemente ricordato Magliulo8 analizzando il rapporto tra meridionalismo, regionalismo e Costituente ‒ ma al temine del quale le politiche di inclusione territoriale diventano, sotto alcuni punti di vista, una delle chiavi con cui la Repubblica si adopera per coniugare per la prima volta nella storia unitaria ‒ come scriveva Pietro Scoppola ‒ diritti sociali, politici e civili.
Se sotto il profilo della convergenza dei redditi e del miglioramento delle condizioni sociali i risultati conseguiti nella golden age sono per molti aspetti indiscutibili, Acocella è al contempo attento a delineare le contraddizioni delle politiche attuate, in grado di incidere sulle dinamiche della fase successiva. In questo senso, ad esempio, l’Autore segnala i limiti della riforma agraria che non sarebbe riuscita ad assicurare un «aumento della produttività della terra», mentre anche nei decenni Sessanta e Settanta, pure in presenza di una crescita dell’impresa capitalistica di media estensione e della meccanizzazione «permane la struttura fondiaria parcellizzata e frammentata» (Ivi, p. 72). Allo stesso modo, il ruolo della grande impresa pubblica, pure ampiamente valorizzato (essenziale in questo senso la funzione dell’IRI), viene riconsiderato muovendo dall’idea che «la gran parte delle produzioni che esse realizzano è nel settore dei beni intermedi e non riesce a procurare vantaggi in termini di esportazioni, se non indirettamente» (Ivi, p. 78).
Un modello di analisi, dunque, attento a definire i diversi momenti, più efficaci o meno positivi, delle forme di intervento per il Mezzogiorno, valutandoli per la loro effettiva declinazione e collocazione. In questa direzione si muove anche il giudizio sulla vicenda della Cassa, la cui centralità viene a ragione sottolineata sia sotto il profilo del sostegno allo sviluppo infrastrutturale (e delle ricadute sociali da questo prodotte), sia nella spinta fornita al processo di industrializzazione ben sottolineato dai lavori di Lepore10 ai quali ancora una volta si richiama Acocella. Negli anni del miracolo economico, gli incentivi all’industria meridionale consentono in parte di bilanciare lo slancio registrato nella stessa golden age da un Nord che, impegnato a ricostruire il suo apparato produttivo, vede dagli anni Sessanta «un aumento della produzione industriale che tende ad accrescere in maniera consistente» (Ivi, p. 70). Il tema, e qui Acocella coglie uno dei punti centrali, è la capacità dimostrata dalla Cassa nel corso del tempo di mantenere un’analisi di efficacia sulla qualità degli investimenti prodotti; una questione che si accompagna ‒ si potrebbe aggiungere ‒ a un altro punto su cui la ricerca storica deve essere ancora pienamente sviluppata e inerente alle eredità lasciate dalla Cassa stessa nel tessuto produttivo meridionale che si affaccia alla globalizzazione degli anni Novanta, un’analisi cui potrebbero certamente giovare le nuove fonti digitali sugli impieghi dell’Ente recentemente ricostruite.
La successiva interruzione della convergenza coincide, nella visione di Acocella, con il cambio di paradigma che si registra negli anni della silver age:
Dagli anni Ottanta cambia nel Mezzogiorno la strategia di sviluppo e si passa a un modello che dovrebbe essere autopropulsivo, ma risulta essere prevalentemente “domandista-assistenziale”, non più basato tanto o soltanto sullo stimolo dell’offerta, ma su quello della domanda (Ivi, p. 83).
I numeri sono molto chiari. Richiamando le analisi della SVIMEZ sui 150 anni dell’Unità d’Italia, Acocella mostra il valore della ripresa del gap tra Nord e Sud. Il contesto più generale è segnato dal passaggio dalle politiche attive dell’offerta a quelle della domanda; una scelta che produce effetti immediati nella tenuta della coesione sociale, ma che nel lungo periodo determina, secondo l’Autore, un progressivo ritorno «alla divergenza iniziale». Comincia così, infatti, un riassetto degli indici del divario destinato a segnare i decenni successivi, in cui hanno giocato un ruolo non marginale la questione dell’illegalità e l’ulteriore diffusione delle logiche clientelari favorite proprio dallo spostamento verso le politiche della domanda. Riprendendo gli studi di Giannola, Petraglia e Scalera, Acocella evidenzia che «le famiglie in povertà al Sud passano dal 32,8% del 1971 al 9,2% del 2008, il che è indubbiamente un progresso, ma comparativamente esse si riducono molto di più, dal 14,4% al 2,2% al Centro-Nord» (Ivi, p. 84). Si tratta di un passaggio rilevante perché nell’analisi di Acocella non è soltanto il dato quantitativo (seppure ovviamente significativo) a definire la ripresa del divario, ma la qualità e le caratteristiche della fase che si va ad aprire. Non a caso l’Autore riprende in questa parte del volume la tesi di De Cecco14 sui vincoli allo sviluppo economico italiano legati ai bassi investimenti in progresso tecnico e capitale umano; si introduce così la riflessione sul calo di competitività che complessivamente coinvolge il Sistema- Italia e con esso il Mezzogiorno dagli anni Ottanta a oggi e che l’Autore affronta nella parte finale del volume proponendo spunti particolarmente significativi.
Ancora una volta il dato economico può essere spiegato solo affrontando pienamente le dinamiche del contesto ed evidenziando le direttrici principali che concorrono a definirlo. Sul fronte esterno, il mutamento del quadro internazionale, con la nascita dell’Unione monetaria e l’ingresso nella nuova globalizzazione che ridefiniscono la struttura dei mercati e gli equilibri tra i vari sistemi produttivi. Sul fronte interno, oltre alle ragioni di instabilità politica e sociale, l’Autore sottolinea il ruolo (in negativo) delle privatizzazioni, criticandone gli effetti ancora una volta non a partire da un dato ideologico, ma in virtù di due elementi: le procedure con cui sono state portate avanti, «che mostrano una serie importante di criticità (ad esempio, elevato livello dei costi sostenuti, scarsa trasparenza di alcune procedure utilizzate)» (Ivi, p. 90); gli effetti per la capacità di definire politiche di sviluppo, considerando che con le privatizzazioni
passa, invece, in secondo piano ogni disegno di politica industriale, in termini sia di possibile liberalizzazione dei settori protetti dalla concorrenza in cui operano le imprese pubbliche, sia, soprattutto, di mancata considerazione della scarsa dinamicità delle grandi imprese private italiane e del possibile ulteriore depauperamento del nostro apparato produttivo (Ivi, p. 91).
Si tratta di un argomento complesso, che vede ipotesi interpretative anche differenti, e che Acocella utilizza anche per collegarvi il tema della “qualità” di pezzi del capitalismo italiano:
Nel corso delle privatizzazioni, molte imprese italiane preferiscono rifugiarsi nei settori protetti della concorrenza interna e internazionale come editoria, aeroporti, autostrade, telecomunicazioni, ristorazione. Gli spazi lasciati vuoti dagli investitori italiani sono rapidamente occupati da acquirenti stranieri quasi nella metà del numero dei casi, pari a circa 1/3 del totale degli incassi (Ivi, p. 91).
In ultimo, sottolinea l’Autore, è mancata una ristrutturazione in senso competitivo dell’apparato produttivo privatizzato. In questo contesto risulta particolarmente penalizzato proprio il Mezzogiorno:
Le partecipazioni statali erano state strumenti importanti della strategia pubblica finalizzata alla convergenza fra il Nord e il Sud d’Italia. Così la loro privatizzazione implica il venire meno dell’obbligo di investire almeno il 40% nel Mezzogiorno e quindi una perdita secca per esso. Per il Mezzogiorno non resta altro che la programmazione negoziata”, strumento comune anche alle altre regioni del Paese (Ivi, p. 91).
La critica alle privatizzazioni si sposa così con il richiamo alla fine di una strategia di policy per il sistema-Paese e per il Mezzogiorno in particolare che ha caratterizzato la fase apertasi negli anni Novanta. Del resto, i limiti e le lacune (in particolare sul Mezzogiorno) della “programmazione negoziata”, del passaggio allo sviluppo locale o della nuova programmazione sono stati oggetto di un confronto diffuso (si pensi, per rimanere alle ultime sintesi, ai lavori di Coco e De Vincenti15 o, per altri versi, alle analisi proposte da Accetturo e De Blasio). Le contraddizioni di quell’impostazione emergono pienamente quando gli effetti della crisi del 2008 impongono di riflettere sulle ragioni della riapertura del divario e sulla necessità di implementare nuove politiche pubbliche a supporto dello sviluppo, come in parte è avvenuto a partire dalla metà degli anni Dieci.
Anche la ricostruzione delle dinamiche dell’ultimo ventennio fatta da Acocella muove da una visione complessiva e dall’incrocio di piani differenti. Le eredità di lungo periodo derivanti dalle scelte fatte tra la fine del Novecento e i primi anni Duemila si sono sommate con gli effetti della crisi del 2008, il cui impatto e la cui onda lunga hanno determinato, come spesso ricorda la SVIMEZ, l’avvio di una doppia divergenza: da un lato, una netta perdita di competitività del Sistema Italia rispetto agli altri grandi paesi europei, dall’altro, la riapertura del divario del Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord che si è tradotto in una ripresa delle emigrazioni e in un ritorno molto significativo delle diseguaglianze socio-territoriali, legate cioè ex ante al territorio di nascita o appartenenza. Difficoltà legate, secondo Acocella tanto agli errori o alle mancate scelte del decisore pubblico, quanto alle criticità dell’iniziativa privata. Sono tematiche molto attuali, su cui sono tornati recentemente anche Giannola e Lopes analizzando il cambio di fase attraversato dal Paese tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta con i nuovi scenari europei e globali, e come questo abbia inciso sul rapporto tra politiche economiche, debito pubblico e squilibri territoriali con la fine dell’intervento straordinario.
Tra gli elementi essenziali, per Acocella, vi è la caduta della spesa pubblica (soprattutto dopo il 2007) e in particolare di quella in conto capitale che costituisce per l’Autore «un vulnus esiziale per il Sud» (Ivi, p. 93). Questa situazione porta, progressivamente, ad aggravare alcune delle ragioni di lungo periodo del divario: dalla sotto dotazione infrastrutturale del Meridione allo svantaggio nella formazione e negli investimenti in Ricerca e Sviluppo; dalla minore efficienza dei servizi pubblici alla ripresa di una questione sociale sfociata, come hanno recentemente ricordato Bianchi e Fraschilla18, in un nuovo divario di cittadinanza. Economia sommersa e nuova questione salariale sono anche il frutto di un complessivo riassestamento verso il basso di tutto il sistema.
La mancanza ‒ ricordata da Acocella ‒ di una politica di sviluppo ha portato quindi a una ridefinizione degli assetti imprenditoriali del Sud, descritti dall’Autore nella parte dedicata alle specializzazioni produttive. Emerge un quadro articolato. Criticità di lungo periodo si sommano alle conseguenze della crisi del 2008 che, come evidenziato da un recente volume curato da Prezioso e Caravella, ha imposto importanti pressioni sulla capacità di tenuta del sistema imprenditoriale del Mezzogiorno, spingendo verso una riorganizzazione dagli esiti non ancora prevedibili in virtù anche dell’arrivo della crisi da Covid-19. Un tessuto produttivo nel quale tuttavia, ricorda Acocella, si segnala la presenza di poli e settori più innovativi (tra questi l’aeronautico, l’automobilistico, l’agroalimentare, l’abbigliamento moda, il biofarmaceutico) non a caso maggiormente in grado di reggere la concorrenza internazionale contribuendo al valore delle esportazioni. In questo contesto, le cause della diversa capacità di resilienza delle imprese meridionali e settentrionali sono, secondo l’Autore, molteplici. Dal lato della domanda, la caduta della componente estera che ha interessato l’intero Paese è stata accompagnata nel Sud da un calo dei consumi finali interni (anche questo un tema persistente, segnalato a più riprese dalla SVIMEZ nei suoi Rapporti annuali). Dal lato dell’offerta, l’Autore ricorda il diverso andamento del settore agricolo tra Nord e Sud mentre ancora più nella manifattura emerge una strutturale differenziazione nella capacità di ripresa se si considera che nel decennio successivo allo scoppio della crisi il valore aggiunto del settore è sceso del -22,3% al Sud, a fronte del -2,9% del Centro-Nord.
Caduta dei redditi, invecchiamento demografico, aumento delle povertà e delle diseguaglianze di cittadinanza sono dunque per Acocella le tessere di un unico mosaico nel quale gioca un ruolo centrale la perdita o la dequalificazione del capitale umano. Quest’ultimo appare un tema essenziale: l’Autore sottolinea non solo le diseguaglianze territoriali importanti nei percorsi formativi (ad esempio in termini di numero di laureati e di tassi di abbandono scolastici), ma anche la scarsa offerta di buone opportunità per coloro che pure riescono a concludere il ciclo di studi terziario nel Meridione:
Per trattenere al Sud questa parte rilevante del capitale umano e impiegarla utilmente per la rinascita dell’area sorge la necessità di accrescere le attività innovative con varie iniziative connesse innanzitutto con la localizzazione di produzioni qualificate (Ivi, p. 120).
Da qui l’innesco di una spirale negativa che porta, accanto alla presenza di poli e settori anche di eccellenza, a una dequalificazione di una larga parte del tessuto produttivo che, come ricordato nel Rapporto SVIMEZ 202120, ha conosciuto anche durante la breve fase di ripresa degli anni 2014-2018 uno spostamento verso attività Low Technology a differenza di un Centro-Nord dove orientato maggiormente verso produzioni Medium High Technology.
Il volume si conclude con un richiamo alle possibili proposte di policy. Il primo punto da cui muovere è, secondo Acocella, il riconoscimento della necessità di tornare a definire politiche di sviluppo, coniugando gli interventi straordinari con quelli ordinari, essendo «necessarie sia politiche specifiche per il Sud sia politiche generali conformi alle prime» (Ivi, p. 81). Accanto a questo, il libro richiama l’attenzione sulla compresenza di errori e pecche registratesi negli anni sia dal lato del pubblico sia da quello privato. Infine, è utile considerare che se oggi le condizioni economiche e sociali del Mezzogiorno non sono certo paragonabili a quelle del secondo dopoguerra, l’obiettivo futuro deve essere quello di affrontare lacune e problematiche che ancora rimangono e che spiegano la persistenza del divario:
Passi da gigante sono stati compiuto dal Mezzogiorno, ma restano ancora molte lacune, che possono e vanno colmate aggredendo i problemi rimanenti da vari punti di vista, non soltanto economico (da parte di soggetti sia pubblici che privati), ma anche demografico e sociale (Ivi, p. 122).
Tra i problemi aperti, Acocella richiama proprio quei temi trasversali da lui indicati nelle pagine precedenti del volume come l’istruzione, la sanità, il capitale sociale, il ruolo del sistema finanziario. Altrettanto rilevanti sono, da un lato, la scarsa efficacia degli aiuti alle aziende e, dall’altro, la scarsa integrazione del tessuto imprenditoriale meridionale, dove le imprese faticano a “fare sistema”. A questi fattori si legano altri due elementi fondamentali come la bassa produttività del lavoro e lo scarso livello di innovazione tecnologica. Essenziale è poi la capacità di migliorare la qualità della azione offerta dalla Pubblica amministrazione, una questione che riguarda l’insieme del Paese ma che trova oggi nel Mezzogiorno una valenza particolare, sia sotto il profilo della dotazione di personale rispetto alla popolazione, sia per la sua età media e qualificazione professionale.
È quest’ultimo un tema attorno al quale si giocherà un pezzo rilevante della capacità attuativa del «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza». Una questione al centro del confronto attuale, se si considera che una parte estremamente rilevante delle risorse sarà veicolata tramite progetti promossi o proposti dalle Amministrazioni regionali e territoriali. Una minore efficienza della P.A. meridionale rischia così di vanificare in parte le potenzialità del PNRR a meno di interventi che nel medio periodo favoriscano una riqualificazione del comparto e nell’immediato forniscano strumenti e modelli di supporto alla capacità di progettazione degli Enti locali. Più in generale, il tema del PNRR si aggancia bene a quella visione di insieme proposta da Acocella e alla questione della complementarità tra interventi straordinari e ordinari. È indubbio, infatti, che siamo in presenza di un piano di investimenti senza precedenti, in grado potenzialmente di contribuire al riposizionamento competitivo del sistema Italia e del Mezzogiorno. Le direttrici del PNRR sono state declinate in ambiti e settori che, sia a livello verticale che orizzontale, sono in grado potenzialmente di intervenire in tutti i principali elementi di criticità rilevati da Acocella. Allo stesso tempo, come ricordato nel Rapporto SVIMEZ 2021, l’impatto del PNRR ‒ qualora fosse pienamente utilizzata la quota del 40% riservata al Sud del Paese ‒ potrà certamente contribuire alla ripartenza del PIL del Mezzogiorno e ad arrestare la ripresa del divario registrata negli ultimi anni, tuttavia, per rendere questi interventi in grado di produrre risultati strutturali e significativi, anche oltre l’orizzonte del 2026, è necessario affiancare alle misure del PNRR interventi e riforme di accompagnamento in grado di incidere sul contesto socioeconomico21. Acocella, con il suo volume, fornisce un quadro molto chiaro di quali siano quegli elementi di maggiore criticità che nei decenni passati hanno contribuito a segnare la questione meridionale e che è quanto mai necessario aggredire. Il rischio, altrimenti, è di perdere le potenzialità che si stanno già aprendo in questi mesi così come tra la metà degli anni Novanta e i primi anni Duemila il Paese e il Mezzogiorno hanno perso le occasioni, che pure in un contesto inedito e complicato, erano state all’epoca offerte dalla ripresa del ciclo economico internazionale.
di Stefano Palermo


