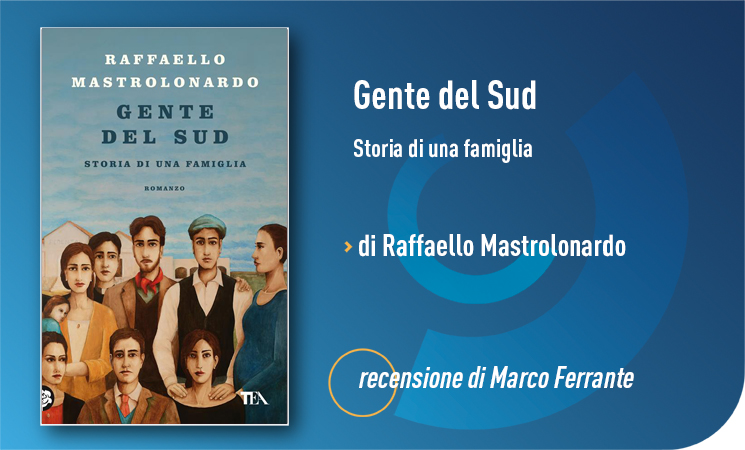
La prima sorpresa piacevole sono i nomi, credibili, quelli veri come Checchina Parlante, prototipo di trisavola agraria armata di pistola, e quelli inventati o presi a prestito come il Morrone, nome di masseria salentina trapiantata in un contesto più duro e aspro, la Murgia.
Sui toponimi letterari il ‘900 ha molto discusso e molto insegnato. Combray e Martinville sono toponimi bellissimi e non sono veri, Sogliano Cavour– per restare in Puglia – è bellissimo nonostante sia vero. Nel romanzo di Raffaello Mastrolonardo l’equilibrio su cui si reggono i nomi di luoghi e persone è molto delicato e, per esplicita dichiarazione dell’autore, autobiografico e quasi esistenziale.
Questo equilibrio apre un piccolo, provinciale & popolare, sipario narrativo che tiene per 800 pagine. Da qui, la seconda sorpresa piacevole: leggere un libro, e vivere in un solo week-end in un mondo concluso, finito, circoscritto, infantile, schematico, e uscirne soddisfatti (comprese molte lacrime) come nelle letture dell’adolescenza, è una rarità. E qui, senza giudizi, se non quello relativo all’estrema scorrevole leggibilità, si chiude la parte della recensione che incoraggia l’intrattenimento e se ne apre un’altra. I romanzi – e oggi le serie televisive – restano, a prescindere dalla letterarietà, lo strumento più efficace per raccontare i sommovimenti delle società, i cambiamenti, le sfumature che sfuggono alle scienze sociali.
Mastrolonardo riesce a descrivere due fenomeni complessi che hanno determinato l’evoluzione della struttura sociale del Mezzogiorno nei cento anni successivi all’Unità d’Italia.
Il primo riguarda la natura diseguale, multipla, incoerente del ceto agrario: aristocrazia in fase di arretramento, amministratori di campagna, commercianti di derrate alimentari (quello che più a nord, nel Lazio, sarebbe diventato il generone, ceto di origine settecentesca), piccola aristocrazia di provincia, borghesia delle professioni liberali, contadini che, soprattutto attraverso i contratti di enfiteusi e mezzadria, avanzano. Tra la fine dell’800 e l’inizio della seconda guerra mondiale, questo composita classe si agita in un mischione sociale in cui i privilegi aristocratici scoloriscono, e tutto si contamina in una indeterminatezza meridionale molto interessante. Emulazione, nuove parentele, nuovi mestieri, simbologie e responsabilità politiche. I grandi romanzi siciliani – così simili, così drammatici e così grotteschi – descrivono soprattutto la caduta dei residui feudali post settecentisti. Ma il ceto di mezzo – che in De Roberto spunta timido e macchiettistico nel cognato Giulente e in Lampedusa nella maschera di Sedara (Visconti lo fissa in un gigantesco Paolo Stoppa) – non è realmente rappresentato. Per farsi un’idea della natura selvatica e aspirazionale del galantomismo meridionale, bisognerà aspettare Raffaele Nigro e i Fuochi del Basento. Famiglie sospese tra il brigantismo (e la lotta al brigantismo) e la proprietà. Mastrolonardo sposta il fuoco 80-100 chilometri a est, in un luogo centrale del Mezzogiorno, forse il più intrinsecamente mediterraneo, sicuramente uno tra i due o tre più pugliesi degli infiniti quadranti che la Puglia inscrive in se stessa: la Murgia che declina verso l’Adriatico diomedeo (è Diomede il fondatore della civiltà adriatica). Il centro dell’azione è una invenzione, il piccolo centro di Balsignano, che sintetizza Altamura che si ribellò a Ruffo, Modugno che fu inclusa nel primato barese, e Andria semper fidelis come volle Federico, il quale alla vista della città destinò l’unica
trifora di Castel del Monte – il più bello dei paesaggi viventi inquadrati dalle finestre del castello.
Il secondo fenomeno descritto da Mastrolonardo riguarda un fatto successivo e alquanto inesplorato dall’autocoscienza meridionale. Il rimescolìo di rapporti che fu innescato dalla fine della guerra e che si avvertì con una decina di anni di ritardo – come la vista degli aerei supersonici che ne segue il rombo. Arriva la democratizzazione della società portata dalla scolarizzazione e in generale dal welfare, per esempio il ruolo dei medici condotti e del sindacato. Questo cambiamento modifica i rapporti di forza dentro la società, e li rende più fluidi, mutevoli, più rapidi e stretti nella cronologia delle vite
famigliari. I Parlante, protagonisti di questa saga, prima contadini arricchiti e un po’ briganti, poi padroncini con la prima fuga nelle professioni liberali, diventano imprenditori agrari – sul modello dell’azienda integrata dei Pavoncelli, mito pugliese novecentesco – e industrializzano il prodotto commerciale, in questo caso le lenticchie: dalla produzione alla confezione in scatola. L’industrializzazione sarà uno speedball di modernità che travolgerà la famiglia, perché la coglierà impreparata. La ricchezza è una responsabilità complicata, una specie di inatteso impegno vitale che come tutte le trasformazioni richiede abitudine.
Ma non sempre c’è abbastanza tempo per abituarsi a quello che siamo diventati. L’ultima generazione Parlante sceglie una professione intellettuale, ripiego decadente del sé borghese almeno a partire da Veermer. Non più fare soldi, produrre ricchezza per sé e per gli altri e guidare una comunità, ma semplicemente raccontare com’era bello quando – direbbe Checchina – comandavamo noi.
di Marco Ferrante


