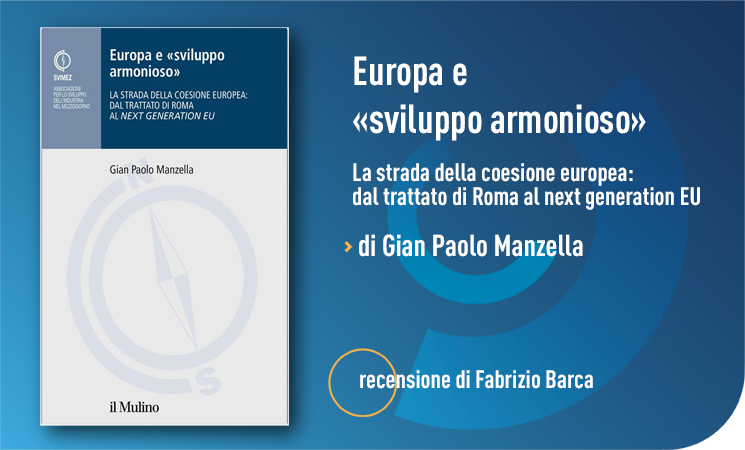
Solo Gian Paolo Manzella poteva convincermi a “tornare sul luogo del delitto”. Troppo forti il coinvolgimento e le responsabilità in tema di politica di coesione, troppe le speranze inseguite, le battaglie, le vittorie e le sconfitte, per avere il distacco di parlarne a ragion veduta. Ma Gian Paolo Manzella è stato parte di questo percorso. Come si legge nella pagina introduttiva “Background research and acknowledgements” del Rapporto “An Agenda for a Reform of Cohesion Policy” commissionato dalla Commissione europea e uscito nel 2009, Gian Paolo è stato uno degli studiosi che a quel Rapporto contribuì. Lo fece in primo luogo proprio ricostruendo la storia della politica di coesione, le sue esitazioni e progressi. Dando respiro al nostro ragionare. Ora che torna su questo tema con meticolosità e vivacità, non potevo mancare.
Chi leggerà “Europa e sviluppo armonioso. La strada della coesione europea dal Trattato di Roma al Next Generation EU” (Collana Studi e Ricerche SVIMEZ, Il Mulino, pp. 220) troverà le motivazioni e lo sviluppo politico e tecnico di questa peculiare leva della politica europea. Una politica regionale, certo, come esiste in molte altre parti del mondo, ma sin dall’inizio legata ad un’aspirazione di rango “costituzionale” tutta europea e presto dettata da un particolare disegno della governance democratica. Vediamo.
Il principio di riferimento tutto europeo è lo “sviluppo armonioso” e la “coesione” che gli si affianca. Compaiono sin dai primi Trattati. E costituiscono in sé, avrebbe detto Piero Calamandrei, un programma politico. Infatti, al primo rigo del libro, Manzella scrive che in Europa “lo sviluppo non è armonioso”, ossia non è inclusivo e solidale, apre disuguaglianze. E dunque quei principi sono, di nuovo con Calamandrei, una critica alla situazione esistente. Un’indicazione sul che fare.
“Una Comunità – scrive nel 1973 George Thomson, Commissario britannico-scozzese, uno dei personaggi del libro di Manzella, riferendosi alla Comunità europea – non può sopravvivere né avere un senso per chi vi appartiene se vi sono persone con diverse qualità della vita e se esse hanno ragione di dubitare della volontà comune di aiutare ogni Stato membro a migliorare le condizioni del proprio popolo”.
“Coesione – scrivemmo nel Rapporto – ossia adattarsi le une persone alle altre, è lo strumento con cui perseguire lo sviluppo armonioso … creando relazioni economiche a un tempo dense e fluide e relazioni sociali aperte e partecipative e tenendo in conto le specificità territoriali” (le tre dimensioni della coesione nel Trattato). E ancora: “Prendendo a prestito l’espressione usata da Freud in una lettera a Einstein del 1932, si può sostenere che questo è il processo di costruzione di una «nuova identificazione» “di persone appartenenti a Stati diversi le une nelle altre, requisito di pace. (Di questi principi, così presenti nei primi programmi di coesione rivolti nel 1989 a Polonia e Ungheria − PHARE, Poland and Hungary: Assistance for Resctructuring their Economy −, quanto è rimasto nel successivo processo di allargamento? Ma questa è un’altra storia).
E poi c’è il disegno di una governance democratica. Nel libro vediamo emergere questa visione gradualmente, a partire dai primi atti nel 1969, indotti, ci mostra Manzella, dal profilarsi già allora della prospettiva di un’unione monetaria, ma anche dalla crescente consapevolezza dei divari territoriali e pure − interessante leggerlo − della congestione urbana (saggezza persa nel delirio metropolitano-centrico di questo secolo). A ogni nuova adesione all’Unione cresce la spinta a dare davvero attuazione al programma politico dello sviluppo armonioso. Ma un contributo forte viene proprio dall’Italia. Prima, ci ricorda Manzella, da Antonio Giolitti, che rigetta l’idea di politiche regionali difensive e compensative e mira ad agire in modo pro-attivo, per “contrastare l’emergere di nuove fratture” e per farlo persegue, con il contrasto di Francia e Germania, un ruolo di indirizzo strategico della Commissione. Poi, nel solco determinante e alto di Jacques Delors – “le politiche strutturali si devono attaccare al terreno”, scrive − ecco il contributo di Tommaso Padoa Schioppa: la politica regionale converge finalmente in una politica di coesione economica e sociale, e diventa ancor più esplicita la sua funzione redistributiva.
Sull’incontro e ruolo di Delors e Padoa Schioppa è doveroso fermarsi un attimo. E notare come la forza di due culture robuste, cristiano-sociale e liberale, costituiscano un argine al credo neoliberista che in quegli stessi anni – siamo a fine anni ’80 – narra di disuguaglianze inevitabili, temporaneo frutto dell’innovazione, e professa politiche “cieche ai luoghi” (leggi: disegnate per i luoghi da dove viene la classe dirigente). E invece proprio in quel momento, anche grazie a loro, l’Europa porta i fondi della coesione verso un quarto e poi quasi un terzo del bilancio e, soprattutto, disegna una governance democratica del suo impiego, con un trasferimento – la dico qui in modo semplificato – del potere degli Stati membri verso l’alto, alla Commissione europea, e verso il basso, Regioni e Comuni, in dialogo con lavoro e cittadinanza.
Ma il neoliberismo non molla, anzi ne cresce via via l’egemonia. Nel suo impianto concettuale le politiche regionali servono – sembrerà strano, ma si legga bene il Geography Report della Banca Mondiale del 2008 – ma solo come un mezzo di compensazione della rabbia sociale: soldi trasferiti per infrastrutture, formazione, assistenze tecniche, che diventano salari, profitti e rendite per scongiurare le proteste e la contestazione prodotte dagli effetti delle politiche cieche ai luoghi. Sul piano teorico, non lo ammetteranno; anzi disprezzeranno questo uso, che anche usando i loro professati parametri di efficienza sono insulse. Ma sul piano politico servono. È il modo con cui negli USA un economista come Larry Summers intende “place-based”: politica che trasferisce soldi ai luoghi. Questa impostazione piano piano penetra nella testa di chi disegna e attua la politica di coesione. E la avvilisce. La rende sempre più un mero strumento compensativo. Spesso usato – si pensi al nostro Mezzogiorno – per costruire catene di obbedienza fra classi dirigenti nazionali e locali. È ciò che una socialdemocratica polacca di valore, Danuta Hubner, divenuta Commissaria, comprende, anche guardando a dove va il proprio Paese. Questa è la ragione del Rapporto di cui mi affida la cura: bisogna invertire rotta. Manzella ne parla, ha parole fin troppo buone per me, ma non ne restituisce appieno l’effetto di rottura e il successivo parziale tradimento. Approfitto per farlo qui.
In quel Rapporto vengono disegnati i tratti di una vera politica place-based, ovvero sensibile alle persone nei luoghi: una strategia volta a ridurre la sottoutilizzazione del potenziale dei luoghi e l’ingiustizia sociale, attraverso l’offerta integrata di beni e servizi collettivi frutto dell’incontro in un pubblico dibattito − Sen lo qualifica: confronto acceso, aperto, informato e ragionevole − fra saperi di frontiera e saperi incorporati nei territori, con un governo multilivello che combina missioni e indirizzi dei livelli alti e discrezionalità dei livelli bassi, monitorata e accompagnata. È il frutto della convergenza fra riflessioni teoriche diverse, dallo sperimentalismo democratico di John Dewey reinventato da Chuck Sabel, alla teoria delle capacitazioni e della giustizia sociale di Amartya Sen, al pensiero della parte più innovativa degli studi regionali e urbani – a cui il nostro Paese ha dato notevoli contributi – alle analisi di Anthony Atkinson sull’origine e il contrasto delle disuguaglianze. Ma è il frutto anche di molteplici, concrete esperienze sul campo, di sviluppo locale e di uscita da trappole della marginalizzazione territoriale, dall’Austria al Galles, dai paesi scandinavi all’Italia, dall’Olanda agli USA (esperienze che si erano spesso incontrate nel Comitato politiche territoriali dell’OCSE). Sono i saperi della ricerca e del fare che si confrontano, carte, dati e articoli alla mano, in quasi due anni di workshops fra accademici, amministratori e rappresentanti sociali.
Operativamente, il Rapporto propone fra l’altro di: tradurre la relazione fra Commissione e Stati membri in veri e propri “accordi contrattuali” mirati a risultati verificabili (non alla spesa); fissare condizionalità istituzionali a cui subordinare il trasferimento; assicurare un ruolo strategico del partenariato sociale; promuovere processi di apprendimento fondati su una valutazione degli effetti e dei processi che li producono “disegnata sin dal momento del progetto, così da avere un effetto disciplinare”. Quanto alle missioni strategiche generali, indica alla Commissione alcune ipotesi, fra cui Innovazione e Cambiamento climatico, Inclusione sociale – “per mirare a garantire in tutta Europa alcuni condivisi standard di servizio in dimensioni prioritarie di vita” – Giovani e Invecchiamento, e fornendo spunti tecnici per ognuno di questi ambiti. Il Rapporto esce, è bene ricordarlo, nonostante la forza della tesi avversaria neoliberista appoggiata dalla Banca Mondiale con il suo Geography Report.
Nel 2013, descrive con precisione Manzella, una parte considerevole di queste proposte viene incorporata nel nuovo Regolamento. Ma poi, ecco ciò che avrei voluto anche leggere, l’attuazione politica di quelle forte innovazioni è assai limitata. Non sono il solo a pensarlo se nel luglio 2017, conoscendo bene le mie valutazioni, vengo chiamato dalla Commissione europea a effettuare la keynote speech al settimo Forum della Coesione. Ecco il succo della mia analisi di allora:
È in atto una lenta transizione verso una programmazione dove strategia e risultati attesi vengono prima dei progetti e dove indicatori di risultato affiancano quelli di mera realizzazione finanziaria e fisica, ma si procede senza adeguata spinta politica. Le nuove regole hanno promosso una maggiore responsabilità dei Comuni nel realizzare programmi integrati, ma solo il 9% della spesa è così organizzata. La Commissione non è stata rafforzata per svolgere l’indispensabile ruolo di accompagnamento, specie dove le cose non marciano. Il nuovo Codice di Condotta del Partenariato ha rafforzato in via di principio il ruolo delle organizzazioni sociali, ma non se ne vedono gli effetti. Il sistema delle condizionalità sta dando notevoli risultati, ma non è usato per far sì che l’intervento addizionale dei fondi UE attivi una permanente sensibilità ai luoghi delle singole politiche settoriali ordinarie. Quanto ai contenuti, lo spostamento di risorse a favore dell’inclusione sociale, nonostante la suggestiva lista degli obiettivi, non sembra produrre gli effetti immaginati.
Su queste basi avanzo alla Commissione tre proposte operative:
Primo, trasferire ogni sua funzione di controllo su legalità e regolarità nell’uso dei fondi a un Sistema Europeo di Controllo, disegnato come il Sistema Europeo delle Banche Centrali articolato in Agenzie nazionali, così da ridurre l’inutile moltiplicazione dei controlli e liberare risorse umane per fini di valutazione e di accompagnamento delle amministrazioni nazionali/regionali più deboli. Secondo, unificare in un unico Direttorato la gestione di tutti i fondi, favorendo così il loro governo integrato. Terzo, consentire davvero alla Commissione il necessario ruolo pro-attivo di accompagnamento sui territori, reclutando allo scopo una nuova leva di 500 giovani esperti, in molteplici campi disciplinari e con competenze adatte al governo degli spazi di confronto e alla mediazione sociale.
Che nessuna delle tre proposte sia stata accolta non è il problema primario, anche se è utile rimarcarlo. Ed è, certo, solo un caso che il testo della mia presentazione, originariamente caricato sulla piattaforma della Commissione, risulti oggi (cliccando i link dell’epoca) “not found”. Ciò che conta è che da allora non vi sono stati significativi progressi. E che il metodo “place-based” – quello vero – non goda a Bruxelles di particolare buona salute. Lo dimostra il fatto che poco assai ne ritroviamo in quel Dispositivo di Ripresa e Resilienza che pure Manzella discute alla fine del lavoro e che peraltro, opportunamente, lega il grande e necessario intervento una tantum con la politica di coesione. A mostrarcelo è un lavoro meticoloso svolto da Giovanni Carrosio, Gloria Cicerone, Alessandra Faggian e Giulia Urso (How place-sensitive are the National Recovery and Resilience Plans?): esaminando l’impianto – non ancora l’attuazione (in Italia assai difficile da seguire per via del pessimo sistema di monitoraggio varato dal Governo Draghi) – del dispositivo in Italia, Spagna e Portogallo, emerge un’assai modesta soddisfazione dei requisiti base di questo metodo di politica economica sensibile alle persone nei luoghi.
Gian Paolo Manzella nota giustamente, nell’aprire il volume, che l’evoluzione delle politiche economiche in giro per il mondo mostra una crescente consapevolezza che solo un simile metodo può correggere gli attuali gravi squilibri. È la conclusione che troviamo anche nel potente libro “Fixing the Climate” di Charles Sabel e David Victor, in merito alla strada per accelerare la transizione energetica. Giusto. Proprio per questo l’Unione europea dovrebbe oggi riprendere il filo migliore che Manzella illustra nel libro e aggiustare la propria rotta. Mi auguro, ci auguriamo nel Forum Disuguaglianze Diversità, che anche su questo tema si giochi il confronto imminente per le elezioni Europee del 2024.
di Fabrizio Barca


