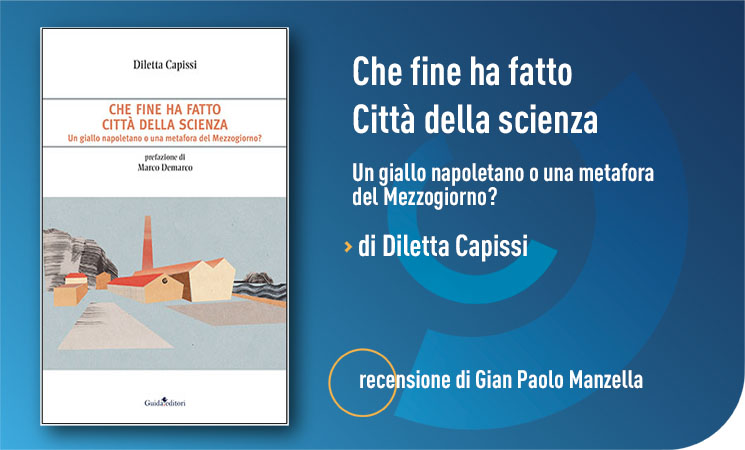
Già il titolo di questo libro e il suo sottotitolo sono rivelatori. Ci sono, nella sostanza, tre interrogativi che si susseguono. Il primo è un interrogativo di senso comune, riflette quello che potrebbe essere il commento del cittadino medio. Gli altri due, invece, sono interrogativi più complessi, che chiedono un’analisi più approfondita. Ci domandano, infatti, se quello di “Città della Scienza” sia un giallo napoletano, come un noir fitto di misteri e di vicoli, oppure sia una metafora del Mezzogiorno, una rappresentazione in qualche modo emblematica di una serie di problemi che aggrediscono il concetto stesso di realizzazione, lasciandola senza scampo dopo averla, in una prima fase, innalzata a simbolo di rinascita. Come se a Napoli (e più in generale nel Mezzogiorno) ci fosse una vera e propria ‘maledizione del fare’.
Sono tre interrogativi pertinenti e, come molti interrogativi pertinenti, sono per molti versi aperti. Perché nella storia raccontata da Diletta Capissi – con una puntualità a tratti sorprendente, una vera e propria indagine, appunto, da noir, – ci sono veramente tanti elementi di questa ‘maledizione meridionale’: c’è la disattenzione della politica; c’è la solitudine dei promotori dopo il momento convulso delle presentazioni, della comunicazione, della folla; c’è il groviglio amministrativo; ci sono scontri personali ed istituzionali violentissimi; ci sono cose inspiegabili e inspiegate; ci sono addirittura vere e proprie tragedie, come l’incendio del 2013. Ma, soprattutto, c’è il senso, intriso di malinconia, di un’occasione mancata, di un tentativo per molti versi pioneristico che si infrange contro gli scogli della realtà.
Sì perché la “Città della Scienza”, specialmente all’epoca in cui essa si avvia – e, prima ancora, si immagina – era veramente all’avanguardia. Oggi, per molti versi, l’importanza della scienza, la sua centralità nella società, la necessità di un dialogo tra discipline scientifiche e discipline umanistiche sono pienamente affermati. C’è una vera e propria competizione tra le città per attrarre investitori legati alla scienza; si consolida una urbanistica dell’innovazione; c’è la consolidata affermazione delle Università e dei centri di ricerca come motori dello sviluppo locale; c’è il riconoscimento di multidisciplinarietà e, quindi, multifunzionalità degli spazi come leve dei processi di crescita. E, di conseguenza, le città più dinamiche hanno al loro interno luoghi simili a quello pensato alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, da Silvestrini: e non fa eccezione, tra l’altro la stessa Napoli, con il Centro di San Giovanni a Teduccio.
Non era così, però, ai tempi in cui la Città della Scienza era stata pensata da una piccola élite di intellettuali e operatori della ricerca. Si trattava, in quei tempi, di un progetto per molti versi avveniristico, che ebbe la fortuna di trovare un ambiente culturale favorevole al cambiamento – quello lasciato in eredità dall’esperienza di governo della Giunta guidata da Maurizio Valenzi – e spalle politiche forti su cui poggiare – quelle del “Rinascimento Napoletano” di Antonio Bassolino Sindaco sul piano locale, quelle di Antonio Ruberti, uno scienziato diventato Ministro, a livello nazionale.
Ma, come spesso accade, al periodo eroico degli inizi non doveva corrispondere una analoga attenzione negli anni successivi. Ed è così che ‘la Città’ entra suo malgrado, in un processo di ‘Dismissione’. E proprio come – secondo Ermanno Rea – la mentalità dei vicoli era entrata all’interno dell’Italsider così, anche in questo caso può dirsi che ‘i vicoli sono entrati nella Città della Scienza’, chiamata, per le ironie della storia, proprio a dare una nuova prospettiva a Bagnoli successivamente alla dismissione dell’impianto siderurgico. Certo si tratta di una mentalità di vicoli diversi, se si vuole, ma sempre di vicoli. Sono i ‘vicoli’ dei labirinti burocratici rispetto agli spazi di libertà della ricerca; delle imperfezioni e delle facilonerie del mondo politico-amministrativo confrontate alla precisione richiesta nel lavoro scientifico; le incapacità di vedere oltre l’immediato, rispetto agli anni che si richiesti dai progetti di ricerca; l’individualismo rispetto al lavoro di squadra che caratterizza il lavoro dietro le scoperte scientifiche.
Ecco, è questa la sensazione che lascia questo libro. Una sensazione negativa, quindi, dietro la quale ci sono, però, chiare indicazioni, su cui lavorare: quella rappresentata dalla presenza nella città di un’élite scientifica e tecnologica, spesso nascosta e che può rappresentare la base per uno sviluppo futuro in questa direzione; quella costituita dal fatto che questa realizzazione abbia comunque prodotto una classe di amministratori con valori condivisi, legati alla città e ad una dimensione più ampia, di respiro internazionale. Insomma, se oggi Napoli è in testa alle classifiche nazionali per le startup, se ha costruito un ecosistema digitale considerato di grande interesse dagli investitori, se alla sua guida c’è l’ex rettore di una facoltà scientifica, se ha avuto delle realizzazioni guardate con grande attenzione anche fuori dai confini italiani, come è appunto il caso del centro di San Giovanni a Teduccio: ecco questi frutti sono anche quelli della storia tormentata raccontata dal libro di Diletta Capissi.
Una storia che parla – ed è un altro punto rilevante – anche del legame della città e della sua popolazione con la scienza, dell’orgoglio e del senso di comunità creato dalla ‘Città’, nel volgere tutto sommato di pochi anni, tra la popolazione. Solo così è possibile spiegare il successo del crowdfunding avviato per la sua ricostruzione dopo l’incendio. Utilizzando categorie forse ormai datate, la società civile ha dimostrato in quella occasione di essere più avanti della società politico-amministrativa: avanti nel pensare il futuro della città, avanti nel capire l’importanza della istituzione e del suo potenziale, avanti nel partecipare al processo di ricostruzione.
Legittima, quindi, la domanda “Che fine ha fatto la Città della scienza”, perché si chiede che fine ha fatto un progetto che in qualche modo, e per un lungo tratto, si è sentito parte integrante della città. Ed è un messaggio importante, specialmente in un momento in cui il PNRR può dare una vera e propria svolta su questo punto a questa vocazione territoriale di Napoli, quando la città campana è al centro di progetti che vanno sotto il nome di Digital Innovation Hub, di Ecosistemi dell’innovazione, di poli nazionali per il settore agritech. Tutti nomi ed attività che, in fondo, hanno un loro preciso punto di genesi o, comunque, di influenza: quello, appunto, della Città della Scienza.
di Diletta Capissi


