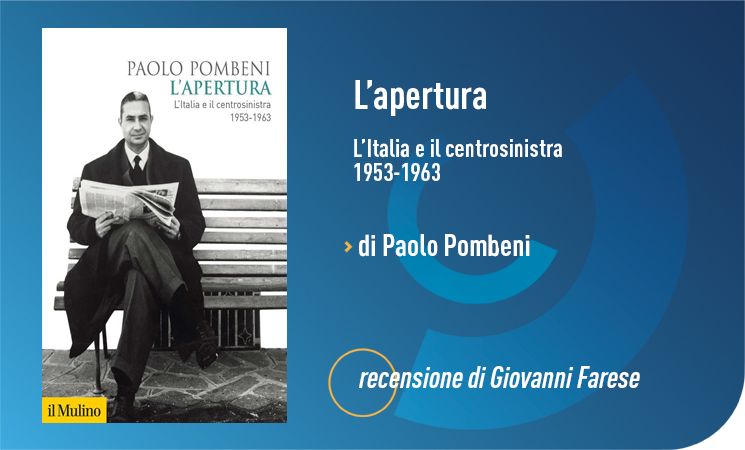
Perché riandiamo di frequente al 1962-1963 come a un punto di svolta economico-politico nella storia dell’Italia repubblicana? Perché sembrò allora che, raggiunto un certo grado di benessere, il Paese potesse trovare un approdo alla modernità in un accezione più ampia e completa; che alla crescita impetuosa degli anni Cinquanta potesse seguire, nel decennio successivo, un più ordinato sviluppo, anche eventualmente avvalendosi, come si auspicava nel 1960 nel gruppo del Mulino, di quelle forze di mobilitazione con le quali “Roosevelt ha avviato il New Deal (…) i laburisti hanno gettato le basi di un nuovo equilibrio nella società inglese (…) le socialdemocrazie scandinave hanno creato il welfare state” (p. 144). L’economia aveva fatto la sua parte. Ci si attendeva che la politica (se pure la separazione dei due termini ha senso, non potendo l’una sussistere senza l’altra) facesse la sua. In questo scollamento tra dinamica economica e dinamica politica stava appunto il problema, anche perché l’avvio del centrosinistra coincideva con la fine del miracolo del 1958-1962.
Alla preparazione – le aperture, gli indizi, i segnali – e all’avvio del centrosinistra nelle sue varie formulazioni – a lungo solo vagheggiato, poi “pulito” senza PSI, poi “programmatico” con appoggio esterno, infine “organico” – Paolo Pombeni, professore emerito nell’Università di Bologna, dedica questo libro dai contenuti densi e di piana scrittura, sorretto da un impianto bibliografico solido e dall’indispensabile Indice dei nomi, in cui spiccano i nomi di Amintore Fanfani, Aldo Moro e Pietro Nenni, in particolare nelle relazioni binarie Fanfani-Nenni, i “dioscuri del centrosinistra”, e Fanfani- Moro, i quali, nelle parole di Ettore Bernabei, “uniti sono una forza considerevole, men- tre divisi rischiano di cadere uno dopo l’altro sotto l’azione dei dorotei” (p. 217). Il libro – in un andirivieni di dichiarazioni pubbliche e ricezioni private – fa abbondante uso dei diari di Nenni e Fanfani, apparsi a distanza di trent’anni gli uni dagli altri (nel 1981 i primi, nel 2011 i secondi), oltre che quelli, di più recente rinvenimento (2021), di Bernabei, che riservano improvvise e talora sommarie illuminazioni. Sorprende, ma solo fino a un certo punto, che i rapporti tra leader di partiti diversi fossero improntati a maggiore comprensione e fiducia rispetto a quelli tra personalità dello stesso partito (si veda la lettera di Nenni a Fanfani sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica, p. 211), sintomo, come scrive sempre Bernabei a proposito della DC (l’osservazione può essere generalizzata), di “gruppi dirigenti frazionati al loro interno in una serie innumerevole di frazioni e casi personali” (p. 126). La Malfa, Malagodi, Saragat, Togliatti sono presenti, ma restano perlopiù sullo sfondo della ricostruzione.
Il libro offre una lettura del “difficile contesto in cui operò una classe politica che volle farsi carico della profonda trasformazione che stava interessando l’Italia” e che “si scontrò con una componente conservatrice che operò nell’ottica di tenere tutto fermo” (p. 10). Quanto al cambiamento, basti qui ricordare le migrazioni interne ed esterne e la transizione da economia prevalentemente agricola a industriale: mutavano le attese, i comportamenti, i consumi. Quanto alla conservazione, occorre ricordare che essa riceveva spinte soprattutto dall’interno (dalla destra DC, ma anche da liberali, monarchici, missini) e dall’esterno: spinte delle gerarchie ecclesiastiche (cardinali Siri e Tardini su tutti), continue – pure nell’articolata e disomogenea composizione della sua geografia – proteiformi e ricorrenti nei contatti, nelle lettere, negli articoli su quotidiani e riviste, che l’Autore segue con l’acribia dello storico, con differenze e passaggi tra i pontificati – come nel caso della distinzione tra “errore” ed “errante” nell’enciclica Mater et Magistra del 1961 – giacché nel tempo stretto di un decennio si susseguono ben tre pontefici, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI; spinte dagli Stati Uniti volte ad arginare il pericolo comunista, ma anche qui con distinzioni tra le amministrazioni Eisenhower, Kennedy, Johnson, senza tacere che le sollecitazioni a spingere provenivano talora dal seno della DC, come scrive papa Roncalli a proposito delle prime e come emerge a più riprese dalla sollecitudine del presidente Segni per le seconde (p. 237). Altri freni provenivano da sinistra: da dentro (dalla sinistra del PSI, oltre che dal PCI) e da fuori (da Mosca).
Ai primi piani – in cui non mancano quelli dei presidenti della Repubblica Gronchi, visto da Nenni come una prima vittoria dell’apertura a sinistra, e Segni, visto da Moro come un contrappeso a quella stessa apertura – il libro affianca le foto di gruppo e i campi lunghi: dall’aspro e vivace dibattito delle idee – colto nei convegni (da quelli di San Pellegrino a quelli dell’Istituto Gramsci), nei quotidiani (dall’Avanti, al Popolo, all’Osservatore Romano), nelle riviste più influenti (dalla Civiltà Cattolica, al Mondo, al Mulino, con particolare attenzione alla prima e soprattutto alla terza in funzione di controcanto e preveggente coro) – fino alla politica internazionale, dai fatti d’Ungheria del 1956 al congresso di Bad Godesberg della SPD del 1959 (“da partito di classe a partito di popolo”, giacché la modernizzazione imponeva di andare oltre gli schematismi degli anni Trenta e Quaranta, p. 137), dalla crisi di Berlino del 1961 (costruzione del muro) alla crisi di Cuba del 1962. Tutto concorre alla costruzione di un mosaico in cui si affacciano anche fenomeni generazionali (i giovani) e sociali, di consumo e costume, incluse le prime trasmissioni televisive (il 23 maggio del 1956 Nenni registrava compiaciuto nei suoi diari il successo di un suo comizio a Venezia, nonostante si svolgesse in contemporanea con “Lascia o Raddoppia”? in onda dal novembre del 1955, nota 20 p. 262).
Il libro si articola in cinque capitoli, più una Introduzione e una Conclusione che guardano al periodo successivo. Il primo capitolo (pp. 13-40) sugli anni 1953-1954, ha i suoi due poli da una parte nel lungo intervento di De Gasperi al Congresso di Napoli del 1954, secondo cui la “partecipazione dei socialisti al governo è certo questione senza dubbio importante, questione che dovrà un giorno essere risolta (…) Ma deve affrontarsi in pieno come problema integrale di politica interna e internazionale esaminando principi, riserve e rischi” (p. 33-34), e, dall’altra, nell’“imbarazzo storico di rompere l’unità della classe operaia” da parte di Nenni (p. 39). Il secondo capitolo (pp. 41-78), sugli anni 1955-1957, guarda alle elaborazioni dei partiti e ai loro tormenti (alla distinzione, per esempio, di Riccardo Lombardi sulle pagine del Mondo su via socialdemocratica e via propriamente socialista, p. 63), ma anche ai riflessi interni di eventi e fatti internazionali, dal XX Congresso del PCUS alla firma dei Trattati di Roma (i socialisti votarono a favore del trattato sull’Euratom).
Il terzo capitolo (pp. 79-138), con gli anni 1958-1960, è per certi aspetti il centro del libro. Si forma il governo Fanfani II, in cui si propongono cose da fare, come una serie di leggi legate al piano scuola, per lo statista aretino “il piano più importante che tengo a battesimo in questo decennio” dopo il “suo” piano-casa di fine anni Quaranta (p.94), o da impostare, come “un apposito ente di tutte le partecipazioni statali di ricerca, produzione e distribuzione di energia di qualsiasi specie” (p. 93), una sorta di CNEN, più ENI, più futura ENEL. Emerge la figura di Moro, il giovane segretario DC che pensava che la trasformazione economico-sociale dovesse trovare una nuova forma di equilibrio politico (p. 112) e la cui pedagogia postulava (sono parole di Moro) che “questo mondo è in cammino con ritmo veloce ed inarrestabile, che questo è segno di civiltà, che questo moto non dev’essere contrastato, ma accompagnato, condizionato dal di dentro, arricchito da ragioni morali (p. 115) e che lo Stato (sempre parole sue) dovesse assumere “la piena responsabilità del processo di sviluppo” (p. 118) (“ed è per l’accettazione di questa responsabilità – concludeva – che una posizione democratica si distingue nettamente sul terreno economico da una posizione conservatrice per quanto illuminata voglia essere”). Nenni, a sua volta, a Milano incontrava compagni “con gusti e abitudini da ceti medi” e in un pranzo con gli operai a Sesto San Giovanni registrava una “psicologia del tutto nuova con esigenze nuove” (pp. 124-125). Il fallimento del governo Tambroni (1960) apriva, come è noto, il passaggio verso l’apertura a sinistra. “Diveniva evidente – scrive sul punto Pombeni – che contrastarla a fondo significava mettere a rischio la stabilità della democrazia italiana e privarsi di un contesto politico capace di confrontarsi con lo sviluppo sociale ed economico del paese” (pp. 136-137). Non venivano comunque meno i freni e le resistenze, per non dire le condanne più o meno ufficiali.
Il quarto capitolo (pp. 139-180), sugli anni 1960-1962, si concentra sulle “convergenze parallele” (e sull’origine di questa formula) e ampiamente sul terzo governo Fanfani, di cui Bernabei in una bella pagina puntualmente registra la “maturazione” per- sonale e politica (p. 141). E’ anche la stagione dei convegni: di San Pellegrino (settembre 1961, p. 163), dell’Istituto Gramsci (marzo 1962, p. 183, già nel territorio del quinto capitolo), che, registrano fatti e idee nuove. Su tutte si stagliano quelle di Moro al Congresso di Napoli del 1962, la cui novità fu colta da Nenni: “ha motivato la svolta non come uno stato di necessità dato da contingenze parlamentari, ma come stato di condizionamento della evoluzione della società” (p. 177). Il quinto capitolo (pp. 181-246), sugli anni 1962-1963, si apre con la politica ecclesiastica di Moro, che prende corpo an- che in un lungo documento-lettera ai vescovi chiedendo almeno per il momento di “sospendere il giudizio” e prosegue con il passaggio al centrosinistra programmatico con la nazionalizzazione dell’energia elettrica e la riforma della scuola media, il tutto nel con- testo rinnovato dato dai “segni dei tempi” del Concilio Vaticano II (p. 204).
Il libro contiene insegnamenti e moniti sulla politica italiana: una distinzione tra demagogia e populismo (nota 3, p. 260), quest’ultimo visto come fattore non contingente; il continuo tutto rifluire “nel calderone della ormai avviata campagna elettorale” (p. 213); l’emergere dei “leader” di partito giacché, come nelle parole di Leopoldo Elia al terzo convegno di San Pellegrino, “la vita politica moderna, con i mezzi di comunica- zione di massa, tende alla personalizzazione” (p. 232); la difficoltà a conciliare breve e lungo termine, tattica e strategia, destini personali e destino del Paese; l’uso partitico e parlamentare della politica estera (p. 94, crisi in Libano nel 1958); l’eterogenesi dei fini; l’utilizzo del “pericolo rosso” per dare corda e fiato al colpo di mano conservatore e re- azionario. Pombeni riconosce all’onda lunga della generale espansione postbellica la spinta profonda alla trasformazione. Ma nell’agitarsi delle alchimie personali e di partito l’economia resta perlopiù sullo sfondo (la Cassa per il Mezzogiorno è citata en passant, p. 51, come l’ENI, che finanzia il PSI per sganciarlo dal PCI, p. 89, e l’IRI, con riferimento al distacco delle sue aziende dalla Confindustria, a p. 82), con qualche eccezione come nel caso della costituzione dell’ENEL (al cui vertice Ugo La Malfa avrebbe voluto una personalità qualificata e sopra le parti come Donato Menichella, che aveva lascia- to l’istituto di emissione nel 1960), il cui vertice fu invece oggetto di una spartizione tra DC e PSI, ratificando la fine, già annunciata, di un modello di intervento pubblico à la Beneduce.
Resta il fatto che, pur tra accennate aperture, “cauti connubii”, timide sortite e ben 14 governi solo nelle prime tre legislature (11 nel periodo qui considerato), impor- tanti decisioni di fondo vennero nel corso degli anni Cinquanta prese per l’economia del paese, per la sua collocazione europea e internazionale (dal cui contatto derivavano an- che percezioni di ritardo e aspirazioni allo sviluppo), per il suo definitivo cambiamento strutturale: la liberalizzazione degli scambi voluta da La Malfa (1951), la legge per il credito all’esportazione ispirata da Carli e firmata da Bresciani Turroni (1953), la legge sugli investimenti diretti esteri impostata da Vanoni (1956), la convertibilità esterna del- la lira perseguita da Menichella (1958). Ne furono attori e registi singoli ministri e personalità con elevata competenza e con colleganze internazionali, capaci di porsi in ascolto, in dialogo (e talora al anche vertice) di strutture complesse – Banca d’Italia, la Banca mondiale, il FMI, l’OECE, l’Unione europea dei pagamenti, la SVIMEZ – e assumere al momento opportuno conseguenti decisioni politiche. Dinamica economica e dinamica politica sembravano ed in certa misura erano piani paralleli con convergenze che trovavano uno sbocco perlopiù occasionale, per coincidenza di tempo e di luogo nonché di coabitazione e di consonanza nelle posizioni di comando e di governo di certe persone più che di altre, oltre che per effetto delle grandi scelte atlantiste ed europeiste degasperiane che continuavano a sprigionare impulsi vitali in cui le imprese italiane si inserivano efficacemente.
É una storia parallela, in parte diversa e separata da quella narrata da Pombeni, ma che a più riprese vi fa capolino insieme ai nomi di alcuni protagonisti (da Carli a Saraceno, da Mattioli a Menichella). Per esempio nella consapevolezza, espressa ancora una volta da parte del gruppo del Mulino, che “il benessere dipende oggi dalla nostra economia neo-capitalista” (p. 220), dai suoi concreti meccanismi e funzionamenti, individuando una possibile soluzione nella possibilità di poter agire e programmare a più lunga scadenza; così come nella spia che trapela dalla attenta e riverente lettura (paragonabile forse solo a quella riservata alle Considerazioni finale del Governatore della Banca d’Italia Carli) che i leader di partito facevano delle relazioni di Mattioli all’Assemblea della Banca commerciale italiana (p. 206); oppure ancora nelle parole vergate da Nenni nel suo diario il 27 dicembre del 1962 proposito dello sviluppo italiano: “É un progresso minato alle fondamenta dalla insufficienza dei servizi civili e sociali e dagli squilibri Nord-Sud e città-campagna (…) La riorganizzazione dello Stato e la pianificazione della produzione e dei consumi, più dei miracoli economici, condiziona- no l’avvenire della nazione in un’opera che chiede molti anni” (p. 245).
Si trattava di questioni che i due maggiori documenti di indirizzo sulla politica economica dell’epoca, legati da un robusto filo rosso non invisibile nel libro di Pombeni- lo Schema Vanoni del 1954 da una parte e la Nota aggiuntiva di La Malfa del 1962 dall’altra – avevano correttamente impostato in termini di sviluppo dell’occupazione e del reddito, e in particolare quest’ultimo in ordine alla necessità di discernere e scegliere (che significava in alcuni casi rinunciare) tra consumi privati e investimenti pubblici. La crisi del 1963-1964 – come avrebbe scritto Mattioli nella Relazione del 1966 – avrebbe infine fatto balenare l’idea che, più che a causa della “medusea congiuntura” (secondo una delle icastiche formule del banchiere), le difficoltà derivassero dal venir in superficie delle increspature della crescita e via via dall’arenarsi di problemi strutturali: l’inurbamento, l’istruzione, la pubblica amministrazione, i servizi pubblici. Erano problemi che, allora come oggi, avrebbero richiesto, oltre che un inquadramento di respiro almeno europeo, un governo non gravato da costante intermittenza e da diffusa capacità di neutralizzazione amministrativa; un governo, cioè, in grado di “decidere e mettere in atto con continuità strumenti mezzi per dare un indirizzo al paese” (p. 250). Siamo alle questioni di oggi, sulle quali pure il libro offre più di uno spunto di meditazione.
di Giovanni Farese


