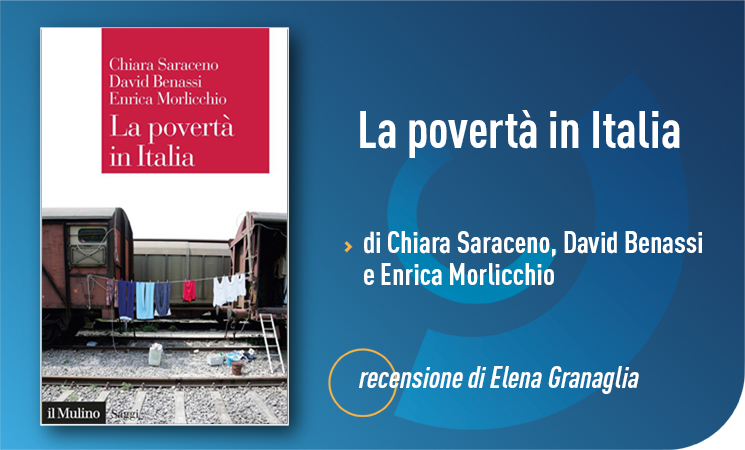
“La povertà è l’esito delle forme di regolazione dei processi sociali che definiscono i pacchetti di risorse a disposizione delle persone e le relative condizioni di uso, esponendo individui e famiglie a diversi rischi di povertà. Più della sfortuna individuale, sono i modelli di famiglia e di solidarietà collettiva, i sistemi di protezione sociale, le norme e le rappresentazioni sociali che in parte sono il prodotto di quei modelli e sistemi e in parte ne costituiscono la base di legittimazione, le tendenze demografiche e del mercato del lavoro, e il modo in cui tali fattori interagiscono tra loro a definire i gruppi sociali che corrono i maggiori rischi di ritrovarsi in povertà.”. Questo è l’incipit del libro di Saraceno, Benassi e Morlicchio appena uscito presso il Mulino, con alcuni aggiornamenti rispetto alla precedente versione inglese, Poverty in Italy. Features and Drivers in a European Perspective, Bristol University Press, 2020.
È un incipit potente. Si consideri la discussione pubblica sulla povertà oggi prevalente nel nostro paese. L’attenzione è concentrata sulla conta dei poveri, non sull’origine della povertà. Quando l’origine è presa in considerazione, il focus è sulle carenze individuali dei poveri, riguardino esse la bassa moralità (la propensione al free rider, imbrogliando, crogiolandosi nella pigrizia e avanzando pretese, anziché dandosi da fare), oppure, anche a prescindere dalla responsabilità dei poveri, carenze di capitale umano e nella capacità di accedere al mercato del lavoro. A ciò si accompagna la più ampia retorica dell’individualizzazione dei rischi sociali.
Il libro ribalta questa prospettiva, obbligandoci a vedere la povertà come un problema di origine strutturale, derivante dalle diverse combinazioni di opportunità e vincoli prodotti dalle strutture familiari, dai sistemi di welfare e del mercato del lavoro, formale e informale, e dalle soggiacenti condizioni dell’economia. A seconda delle specificazioni di queste combinazioni, avremo diversi regimi di povertà. Certo, istruzione e politiche attive del lavoro contano. Il libro è netto su questo. Certo, Saraceno, Benassi e Morlicchio non sono gli unici a difendere l’approccio strutturale, come peraltro ben riconoscono, richiamando diversi autori che questo approccio hanno indagato e seguito. Ciò nondimeno, l’origine strutturale della povertà è oggi trascurata e grande merito di La Povertà in Italia è quello di riportarla alla ribalta.
Fra le condizioni strutturali, il libro attribuisce un ruolo centrale alla domanda di lavoro e in particolare alla natura di questa domanda. Essere disoccupati incide, è ovvio, sui rischi di povertà. Ma neppure avere un lavoro è sufficiente. Conta il tipo di contratto di lavoro, se è part-time oppure a tempo pieno; se è a tempo determinato o a tempo indefinito; se è regolare o irregolare. Se è a tempo determinato, conta poi il numero di giorni lavorati. E conta il settore economico in cui si è occupati, se a bassa o a alta produttività. A quest’ultimo riguardo, restano assai utili le riflessioni di Cipollone (2001, p. 1) quando afferma “se i bassi salari di alcuni lavoratori dipendessero dalla loro carenza di capitale umano, politiche finalizzate a innalzarne il livello potrebbero essere un valido rimedio. Questa strategia risulta poco efficace se la produttività è una caratteristica dei posti di lavoro, piuttosto che dei lavoratori; in questo caso, il problema è costituito dall’esistenza di “cattivi lavori” con basse retribuzioni, scarsa sicurezza del posto di lavoro e poche possibilità di carriera”.
Un’altra causa fondamentale è costituita dalla divisione delle responsabilità di cura fra famiglia e collettività e all’interno della famiglia. Maggiore la defamilizzazione della cura e più equa è la ripartizione dei compiti di cura dentro la famiglia minori sono i rischi di povertà e viceversa. A quest’ultimo riguardo, è interessante ricordare un dato riportato nel libro, ossia che la presenza di un secondo percettore di reddito riduce di 2/3 la povertà dei minori, sia essa definita in termini assoluti o relativi.
Aggiungerei la qualità del contesto/dei luoghi in cui si vive. Il libro la riconosce, ma darei ancora più rilievo a tale variabile. Ricordo, al riguardo, due lavori recenti di Chetty. Il primo, con Hendren (Chetty, Hendren, 2018a e b) analizza un ampio programma di sussidi realizzato negli Stati Uniti a favore delle famiglie povere che volessero cambiare luogo di residenza. A parità di famiglia, i figli di chi si è spostato in aree con meno disuguaglianza, meno povertà e migliori servizi registrano un miglioramento nelle opportunità intergenerazionali, che è inversamente proporzionale all’età in cui è avvenuto il trasferimento (i miglioramenti sono tanto maggiori quanto minore è l’età). L’opposto vale per chi si è spostato in luoghi più svantaggiati. Il secondo, realizzato con l’aiuto di un gran numero di ricercatori (Chetty et al., 2022), sottolinea il ruolo del capitale sociale, inteso come rete di rapporti sociali e comunitari.
Il modo in cui le diverse condizioni strutturali si sono configurate e si configurano nel nostro paese permette sia di dare conto delle differenze territoriali sia di individuare i soggetti a maggiore rischio di povertà. Come ci invita a fare La povertà in Italia, si consideri, innanzitutto, il dualismo territoriale che ha caratterizzato l’incidenza della povertà in Italia. Ebbene, alla sua origine ritroviamo le debolezze, nel Mezzogiorno, sia della domanda di lavoro, con effetti negativi in termini di disoccupazione, inattività e lavoro irregolare, sia della fornitura dei servizi sociali, con la conseguenza dell’affidamento delle responsabilità di cura in prevalenza alla solidarietà familiare nonché della produzione di “una specie di familismo forzato, il quale esaspera la divisione di genere nella famiglia, soprattutto nelle famiglie più povere, spesso monoreddito”. La categorialità che fino a prima dell’assegno unico ha caratterizzato il sostegno monetario al costo dei figli ha aggiunto altre carenze. Data questa situazione, non dovrebbero stupire né la più elevata incidenza di povertà nel Mezzogiorno né il minore accesso alle politiche di sostegno al reddito di natura occupazionale (indennità di disoccupazione, pensioni di anzianità e, in passato, assegni familiari) e, contempo, il maggior uso dei trasferimenti assistenziali (pensioni sociali, in primis). Peraltro, la situazione è tanto più grave tanto più, allontanandosi dal dato medio, si entra nelle aree interne, quelle che, come il libro ricorda, Manlio Rossi Doria definiva l’”osso” del territorio.
Si considerino, altresì, i cambiamenti recenti che hanno generato una crescita più pronunciata della povertà nel Nord a danno soprattutto di chi ha in famiglia persone non nate in Italia seppure regolarmente residenti. Ebbene, anche in questo caso, sono dirimenti i cambiamenti strutturali, dall’estensione della precarietà dei rapporti di lavoro (con relative implicazioni negativi in termini di risorse proprie delle famiglie), all’indebolimento delle prestazioni di welfare (dati i vincoli di bilancio) e ai limiti ancor più forti di tali prestazioni per chi non è nato in Italia. E, ancora, con un occhio al recente presente, non si trascuri l’influenza di un altro fattore che non dipende dai singoli, ossia, l’andamento dei prezzi, in particolare dei beni alimentari e dei prodotti energetici.
Le osservazioni appena esposte permettono anche di individuare i soggetti più a rischio di povertà. Sono i lavoratori poveri, i giovani (sia che siano lavoratori poveri sia che siano senza lavoro), i migranti e i minori, figli di lavoratori poveri e migranti e spesso con madri nell’impossibilità di trovare lavoro (per carenze del mercato del lavoro, dei servizi e delle più complessive modalità di ripartizione della responsabilità di cura).
Riconoscere l’origine strutturale della povertà ha implicazioni non di poco conto per l’individuazione delle politiche. Se dipende dalla struttura sociale, la povertà ha per i singoli la medesima natura di rischio sociale che ha la disoccupazione per chi lavora[1]. Parafrasando Beveridge, come la “disoccupazione è un problema dell’industria”, così la povertà dipende dall’industria oltre che da altre cause strutturali. I trasferimenti contro la povertà, in primis, i redditi minimi e da noi il Reddito di Cittadinanza, devono pertanto abbandonare lo status di inferiorità a loro spesso assegnato, compresa l’appendice denigratoria di politiche assistenzialistiche. Possono essere migliorati nel disegno, ma non delegittimati, avendo lo stesso rango degli altri ammortizzatori sociali.
Il che non implica affermare che non esistano poveri imbroglioni o pigri. Esistono, è ovvio. Ma esistono esattamente come esistono ricchi imbroglioni e pigri. Truffa e pigrizia non sono privilegio di un dato gruppo sociale e la presenza di questi comportamenti non deve offuscare il peso delle cause strutturali della povertà (come della ricchezza). I poveri sono come tutti, sembra banale dirlo, ma troppa opinione pubblica non lo vede. Proprio per questo, non possiamo rivolgerci a loro come un gruppo di seconda classe, come i brutti e i cattivi affermano Saraceno Benassi e Morlicchio, parafrasando il titolo del film di Sergio Leone. Peraltro, tornando alla questione del disegno, quella che potrebbe apparire come pigrizia potrebbe addirittura essere una razionale risposta agli incentivi posti da politiche mal disegnate. Se fossimo poveri, saremmo disposti a lavorare perdendo per ogni euro guadagnato 80 centesimi di trasferimento, come avviene oggi con il Reddito di Cittadinanza?
Non solo. Se la povertà dipende dalla regolazione societaria, contrastare la povertà richiede anche di intervenire ex ante, modificando le forme di regolazione che ne sono all’origine. Ciò implica realizzare interventi che coinvolgono tutti noi, dalle politiche relative al modo in cui l’economia distribuisce il valore aggiunto a quelle grazie alle quali la società affronta la più complessiva ripartizione delle responsabilità di cura. Non bastano interventi residuali per i poveri.
La povertà in Italia offre anche molti altri apporti. Offre un’importante ricostruzione dei dati sulla povertà nel nostro paese; delle caratteristiche dei poveri e della “lunga e accidentata marcia delle misure di sostegno al reddito” nel nostro paese, nonché delle tante debolezze e frammentazioni nei meccanismi di governance dell’assistenza. Colloca, poi, il caso italiano nel più vasto quadro comparato europeo. Offre, altresì, un’utile riflessione sugli indicatori di povertà tipicamente utilizzati, i quali rischiano di trascurare aspetti importanti della povertà stessa.
Anche quest’ultimo punto è importante, data la convinzione diffusa secondo cui la povertà sia un fenomeno univocamente definibile (e, dunque, almeno in linea ipotetica, si possa dire di avere abolito la povertà). Al contrario, la povertà, come la disuguaglianza, si presta a una pluralità di definizioni e nessuna definizione sarà mai in grado di coglierne la totalità degli aspetti (Atkinson, 1970). Ciò riconosciuto, è possibile individuare indicatori più o meno attraenti. Come ben rilevano Saraceno, Benassi e Morlicchio l’indicatore europeo, ampiamente utilizzato, secondo cui è povero chi ha un reddito disponibile inferiore al 60% del reddito disponibile mediano equivalente, ha problemi particolarmente seri. Calcola l’equivalenza sulla base della scala Ocse modificata che pesa 1, il primo soggetto in famiglia, 0,5 tutti gli altri soggetti con età superiore a 14 anni e 0, 3 chi è di età inferiore. Questi pesi ignorano il ruolo di avere o non avere un’abitazione di proprietà e neppure tengono conto dei bisogni specifici dei minori.
Nonostante questi apporti, ho preferito focalizzarmi sul contributo offerto da Saraceno Benassi e Morlicchio per riportare al centro dell’attenzione i determinanti strutturali della povertà. Questa mossa è cruciale, anche nei mesi a venire, per contrastare i tanti limiti che oggi caratterizzano il discorso pubblico sui poveri e i rischi che ne derivano per le politiche contro la povertà.
di Elena Granaglia


