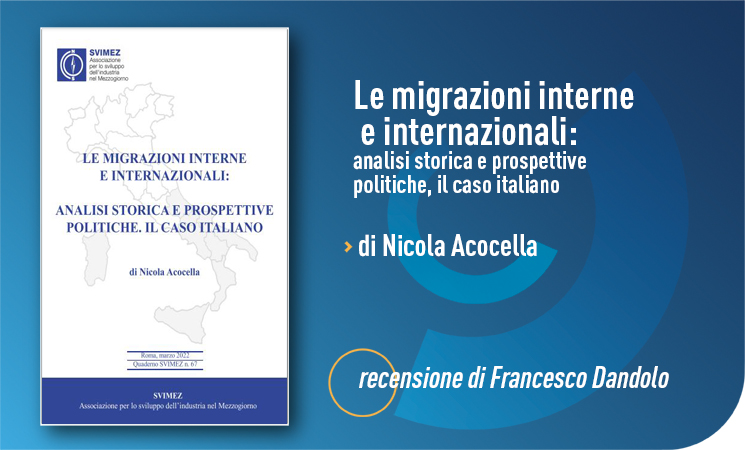
Si fa fatica in Italia a dipanare un dibattito sull’immigrazione capace di prendere le distanze da logiche emergenziali con cui si è abituati a trattare il tema. Come se la questione migratoria non meritasse di essere presa in considerazione indipendentemente dagli accadimenti che dominano la cronaca. Eventi che spesso determinano un notevole impatto nell’opinione pubblica per la forte carica di drammi e traumi, innanzitutto di carattere umanitario, di cui sono espressione, tali da far perdere di vista la dimensione storica e universale della problematica migratoria. Un aspetto eminente – quest’ultimo – che dovrebbe invece costituire la premessa di ogni ragionamento per chiunque si accinga a confrontarsi su questi argomenti. Tuttavia, buona parte delle difficoltà affinché questo metodo si affermi sono dovute a un’idea molto diffusa per cui un approccio culturale può mirare – in modo più o meno consapevole – a sminuire la portata del problema migratorio. In tal modo, si depotenzia la possibilità di contribuire a una riflessione assennata e pacata mentre hanno più facile presa toni allarmanti e spesso urlati, per lo più utilizzati intenzionalmente in modo strumentale, volti a rendere l’oggetto della discussione irrisolvibile e per giunta gravido di pericoli. Questo orientamento crea dunque una frattura tra un processo che nella quotidianità si svolge, pur a volte fra difficoltà e criticità, in modo ordinario e l’eccezionalità delle argomentazioni – spesso pretestuose e volutamente polemiche (si pensi solo all’abuso dei termini «invasione» e «clandestini») – con cui lo si affronta. Un comportamento in questo secondo caso ampiamente condiviso dai politici che rinunciano in modo deliberato a proporsi come salda guida di fronte alle trasformazioni epocali e ineluttabili della nostra epoca.
Il libro di Nicola Acocella ha il merito di contestualizzare le vicende migratorie nell’ambito di una visione globale in cui la longue durée, la categoria metodologica cara a Fernand Braudel e alla Scuola degli “Annales”, svolge un eminente ruolo per comprendere e interpretare gli esodi di massa che attraversano la Storia. Si tratta di una prospettiva evidenziata nell’Introduzione, segnatamente quando si afferma che «molti caratteri della realtà attuale devono essere illuminati dall’analisi storica» (p. 9). In effetti, l’analisi è ambientata in un arco cronologico molto ampio: prende spunto dalle prime testimonianze in fase preistorica che documentano gli spostamenti degli uomini nei vari continenti per poi esaminare le ondate migratorie realizzatesi con la diffusione dell’agricoltura e durante l’età del ferro. Si prosegue nell’evidenziare i trasferimenti di fenici e greci nell’area del Mediterraneo e i movimenti di persone all’interno del continente europeo e, anche quando nel Medioevo i flussi sembrano ridimensionarsi, in vari paesi del vecchio continente i viaggi assumono una più chiara periodicità e includono lavoratori agricoli, commercianti e artigiani, un aspetto destinato a perdurare nei secoli successivi. Con l’età moderna e contemporanea si delineano nuovi aspetti, che coinvolgono l’Asia e l’Europa, da un lato, il Nuovo Mondo, dall’altro. Le rotte dunque diventano molto più lunghe, i percorsi si fanno più complessi e meno scontati, implicano un grande allargamento di orizzonti grazie ai progressi dei mezzi di trasporto, si enfatizza il tratto cumulativo degli spostamenti, di cui però non è assodata in via definitiva la causa scatenante gli spostamenti, che invece va compresa e interpretata di volta in volta.
Appare di indubbio significato che l’ampia ricostruzione di cui sono succintamente tracciate le direttrici fondamentali sia realizzata da un economista, soprattutto in una fase come quella attuale in cui la scienza economica, almeno alcuni orientamenti di essa, tende a voler fare a meno del metodo storico privilegiando un approccio squisitamente tecnico. Con il ricorso alla Storia, invece, Acocella si discosta da chi intende schiacciare l’economia nel presente, o per meglio dire nella congiuntura, un distacco decisivo quando si ragiona di trasferimenti di persone che ambiscono a cambiare la propria condizione di povertà. In questa prospettiva, di fronte a un presente angusto e privo di slanci, il metodo storico ha la funzione di «indicare azioni politiche opportune anche sul piano dell’equità» (p. 9). L’approfondimento in sede storica, dunque, va ben oltre la mera consapevolezza per cui le vicende migratorie, in vari casi più articolate di quelle attuali, sono sempre esistite, ma diventa invece un presupposto irrinunciabile per promuovere politiche idonee alle sfide che si profilano all’orizzonte. E in effetti, a ben guardare, è proprio l’assenza di una solida cognizione storica a fare sì che nell’approccio italiano alla questione dell’immigrazione quasi sempre sia mancata e manchi tutt’oggi la buona politica, mentre ha preso il sopravvento la volontà di enfatizzare, e in vari casi di alimentare, le paure diffuse, strumentalizzandole per fini personali.
Se quindi le migrazioni sono sempre esistite, nel ricostruire i sentieri entro cui si muove il flusso di migranti con il trascorrere dei secoli, si possono identificare con chiarezza due tratti: il primo è la migrazione temporanea, detta circolare, molto diffusa dal Medioevo fino alla fine del diciannovesimo secolo, per cui i medesimi percorsi sono solcati più volte soprattutto in relazione ai tempi dell’economia agricola; la seconda caratteristica è che non sempre le migrazioni sono motivate da esigenze economiche. A ben guardare, sono due aspetti tutt’oggi largamente presenti nei flussi migratori: la migrazione temporanea dei lavoratori stagionali provenienti dai paesi dell’Europa orientale è divenuta un argomento di grande attualità nel corso della fase più dura della pandemia, quando a causa del blocco delle frontiere, non è stato possibile per i paesi più progrediti dell’Unione Europea usufruire dell’apporto determinante di persone delle aree più povere del vecchio continente. A tal proposito, si è opportunamente rilevato che la pandemia ha messo seriamente in discussione il modello agricolo dell’Unione europea ad alto valore aggiunto, basato su spostamenti di merci e di persone, e che fa scarso ricorso ai processi di automazione. L’altro aspetto relativo alle motivazioni non esclusivamente economiche che spingono le persone a migrare è posto in risalto dai rapporti redatti dai più qualificati organismi internazionali che si occupano di migrazioni. Basterebbe evidenziare che in larga parte i migranti non provengono dai paesi più poveri del mondo, ma spesso partono da paesi in cui si registrano forti sperequazioni economiche. E che in questi paesi rappresentano le classi elitarie più ambiziose, animate dal desiderio di migliorare radicalmente la propria condizione. Un esempio è la Nigeria, che con i suoi 190 milioni di abitanti è il paese più popoloso del continente africano, in cui però si riscontrano forti contraddizioni: è povero e allo stesso tempo in crescita economica, seppure con alti e bassi, un progresso garantito soprattutto dalla presenza di giacimenti di petrolio. Eppure, i nigeriani sono la nazionalità di sub-sahariani più numerosa in Italia, e tra coloro che emigrano la maggioranza proviene dalle zone più benestanti. Da questo punto di vista, è ampiamente condivisibile l’osservazione di Acocella secondo cui «la relazione fra livelli di reddito e livelli di emigrazione presenta una “gobba”: l’emigrazione cresce al crescere del reddito, fino a certi livelli di reddito, dopo di che si riduce quando il reddito aumenta ulteriormente» (p. 14). Un altro aspetto che nell’analisi di Acocella ha una particolare rilevanza nell’attualità delle dinamiche migratorie è riconducibile al ruolo delle catene familiari: è proprio questa tipologia di espansione delle vicende migratorie a sollecitare e indirizzare tutt’oggi buona parte dei flussi di ingresso in Italia, tanto da risultare la principale motivazione di rilascio dei permessi di soggiorno, in netto incremento rispetto ai motivi di protezione, studio e lavoro.
La frattura tra un prima e un dopo nelle vicende migratorie a livello mondiale è nell’impatto della prima globalizzazione che si colloca storicamente a partire dagli inizi degli anni Settanta dell’Ottocento. In questa fase segnata dalla crisi agraria che coinvolge principalmente l’Europa si determinano le condizioni per una sensibile accelerazione del movimento delle persone, sia per l’elevato numero dei migranti coinvolti, sia per l’allargamento degli spostamenti. In particolare, nell’ambito delle relazioni economiche internazionali, i migranti adempiono a due funzioni vitali: i rapporti di sostituibilità e complementarietà. È un duplice aspetto che affiora già con nettezza tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento – «il periodo, che forse non ha equivalenti nella storia contemporanea» (p. 30) – con cui l’Europa e l’Italia si rifiutano di fare i conti quando affrontano la situazione attuale: «Fino alla Seconda guerra mondiale – osserva Acocella – praticamente tutti i paesi europei sono fonti di emigrazione» (p. 29). Ed è un dato storico incontrovertibile che in questa fase il vecchio continente nel suo complesso trae grandi benefici dall’intensificarsi dei flussi migratori in uscita. E anche in questo caso si tratta di una lezione che oggi si preferisce dimenticare.
Si giunge così al Secondo dopoguerra, quando riprendono i flussi migratori dopo la stasi fra i due conflitti mondiali. Se all’indomani della guerra si assiste a una ripresa significativa dell’emigrazione degli europei, con un ruolo eminente degli italiani, questo andamento si arresta agli inizi degli anni Settanta, quando si ha un’inversione di tendenza con un incremento di arrivi e un ridimensionamento delle partenze nel vecchio continente. Questo mutamento, peraltro, si associa a una stabilizzazione dei flussi a livello globale: infatti, nei venticinque anni successivi al 1965 le migrazioni sono in rapporto quasi costante con lo stock della popolazione mondiale e, anzi, questo rapporto si riduce leggermente negli anni centrali del periodo considerato. Una stabilizzazione che non ferma i trasferimenti di persone da un paese all’altro nel vecchio continente, e che anzi progrediscono in sintonia con l’avanzare del processo di integrazione europeo. Negli ultimi venti anni, invece, su scala internazionale si è evidenziato che il numero assoluto degli emigranti non soltanto è cresciuto ma è anche aumentato, dal 2,8% al 3,5%, in rapporto con la popolazione mondiale. E in generale i conflitti e le violenze che continuano a essere presenti per l’intera fase che va dal Secondo dopoguerra a oggi provocano ondate di profughi, come è accaduto in questi mesi con la guerra russo-ucraina. Ma anche in questo caso i cambiamenti geopolitici, come nel caso della stagione della decolonizzazione e della caduta del muro di Berlino, determinano un significativo incremento del numero di migrazioni coatte, sebbene sia divenuto complesso fare distinzioni sull’origine dei motivi per cui si abbandona il paese dove si è nati. Appare dunque in questo caso confermata la tesi di Acocella per cui è difficile comprendere con chiarezza le cause che provocano le ondate migratorie. Una difficoltà che si constata principalmente in Africa in cui alle guerre endemiche si accompagna, con l’inoltrarsi del processo di seconda globalizzazione un’insofferenza crescente nell’accettare passivamente la marginalità in cui si è confinati. Si afferma in tal modo un nuovo paradigma migratorio in cui si riscontra un’inedita identificazione, nella medesima persona, fra migrante-rifugiato-profugo: un paradigma che si evidenzia tra i giovani africani giunti di recente in Europa, innanzitutto fra i minori stranieri non accompagnati, in cui si percepisce che tra le motivazioni che li spingono ad affrontare il «viaggio della speranza», oltre alle vessazioni, le minacce e lo stato di rischio per la propria incolumità – si pensi al dramma dei bambini-soldato – vi sono anche sogni, coraggio, voglia di normalità e di studiare, come si è evidenziato di recente in occasione del tragico rinvenimento della salma dell’adolescente di quattordici anni morto nel Mediterraneo con la pagella cucita in tasca. E ancora vi sono paesi di transito in cui la condizione di migrante si trasforma in quella di profugo: l’esempio più eclatante è la Libia, crocevia – come evidenzia Acocella – di impetuosi movimenti di persone in parte coatti, in parte di carattere economico, ma che con i suoi campi di detenzione trasforma centinaia di migliaia di migranti in profughi. Questo brusco mutamento di condizione di chi emigra è recepito e interpretato con difficoltà dal diritto nazionale e da quello internazionale, che anzi spesso si contrappone a quella nazionale con revisioni delle legislazioni in materia tali da rendere più severi e intricati i già complessi percorsi di stabilizzazione dei migranti nei paesi di arrivo. Non si tratta certo di un tema che riguarda soltanto l’Europa e l’Africa: come mostra Acocella vi sono vaste zone del pianeta attraversate da migrazioni coatte: nei fatti «Il numero di rifugiati dal 2010 in poi è cresciuto ad un tasso superiore all’8% ? ben superiore a quello di poco superiore al 2% degli immigranti di carattere economico ? in misura totale maggiore di quindici milioni e rappresenta circa un quarto dell’aumento complessivo degli emigranti internazionali del periodo» (p. 43). Tuttavia, è utile sempre ricordare che ben l’83% di essi vive nei paesi meno sviluppati (dati 2019).
Su questo tema l’Italia ha una sua specificità e non a caso l’Autore vi si sofferma dedicandovi tre Capitoli nella seconda parte del libro, pur essendovi vari richiami già nei precedenti Capitoli incentrati sull’analisi del fenomeno migratorio a livello mondiale. Vi si possono cogliere alcune caratteristiche che gettano nuova luce sulla realtà attuale del fenomeno migratorio. La prima è che fin dalle origini gli emigranti sono normalmente più istruiti ed intraprendenti dei connazionali che restano in patria, sebbene si sia comunque in presenza di un quadro generale di bassi livelli educativi effettivi. La seconda è che grazie a una vivace promozione di associazioni la loro presenza rimarca aspetti positivi per i paesi di approdo e per l’Italia. Grazie al loro apporto, si incrementano gli scambi commerciali, le rimesse, ma è forse negli stili di vita, nei consumi, nei valori in cui trovano ampio riscontro le contaminazioni. La terza è che con il trascorrere dei decenni, i luoghi di partenza dell’emigrazione italiana si concentrano nelle campagne del Mezzogiorno. Un aspetto che però è ampiamente smentito dall’evoluzione più recente; in primo luogo le zone di partenza sono con più frequenza rispetto al passato le città, e fra queste le grandi aree urbane: in secondo luogo le regioni con il più alto tasso di migrazione sono prevalentemente – ma non più esclusivamente – meridionali. Spicca ad esempio il dato della Lombardia, che è al terzo posto dopo la Sicilia e la Campania. Infine, a partire sono prevalentemente laureati e diplomati, sebbene nella comparazione con le prime generazioni di emigranti è sempre opportuno non sminuire la capacità di questi ultimi – pur in possesso di un tasso di istruzione molto inferiore – di proporsi come soggetti dinamici e intraprendenti nei paesi di arrivo.
Come è noto l’Italia, con grande evidenza durante il «miracolo economico» è attraversata dalle migrazioni interne. Solo in cinque anni, tra il 1958 e il 1963, si trasferiscono dall’Italia meridionale verso le regioni economicamente più progredite circa 1.300.000 persone. In tempi più recenti, invece, è decisamente aumentata la quota di immigrati giunti in Italia e che si trasferiscono da una regione all’altra della penisola. Da qui ne consegue che l’arrivo di persone da altri paesi è ormai un aspetto strutturale delle vicende migratorie italiane. Si può anzi affermare – senza timore di essere smentiti – che a partire dagli anni Settanta del Novecento in Italia si è snodata, via via con maggiore evidenza nei decenni successivi, una storia che sul fronte dei flussi migratori deve essere analizzata, sia per le partenze, sia per gli arrivi. È importante richiamare questa dimensione temporale quando si parla di immigrazione perché invece ancora oggi il tema è di continuo schiacciato nel presente, mentre si è in presenza di una questione che già da oltre cinquant’anni si è intrecciata con la storia italiana. E in effetti dalle pagine che Acocella dedica alla storia dell’immigrazione in Italia si percepisce con chiarezza il consolidamento di assetti e problematiche tipici dello svolgimento diacronico: l’affermarsi delle prime nazionalità, i benefici economici che l’Italia ha tratto dalla presenza di immigrati, i diversi itinerari compiuti dagli immigrati per entrare nel Paese, in particolare hanno un ruolo di rilievo quelli via mare sebbene non siano da trascurare, a causa della loro pericolosità, i percorsi via terra (si pensi alla frontiera nord-est presso cui giungono i profughi afghani, irakeni e siriani provenienti da estenuanti viaggi a piedi fatti nella penisola balcanica). Soprattutto la stabilizzazione frutto di un’evoluzione storica si percepisce dall’incremento di nuclei familiari e di minori nati in Italia: «La presenza di alunni stranieri nelle scuole italiane è cospicua ed in aumento – osserva Acocella – parallelamente all’aumento relativo del numero di immigrati presenti nel nostro Paese rispetto alla popolazione italiana» (p. 85). In questo senso appare davvero ingiustificabile come, di fronte a un incremento così marcato di bambini nati e cresciuti in Italia figli di immigrati, si debba ancora scontare una legge già inadeguata quando fu approvata (1992) e che ritarda l’accesso alla cittadinanza fino al diciottesimo anno di età. Un ostacolo che impedisce la piena appartenenza a una medesima comunità civile di centinaia di migliaia di minori residenti stabilmente in Italia, accrescendone il senso di marginalità e di frustrazione. Eppure, come dimostra Acocella nelle pagine conclusive del suo libro, l’Italia potrebbe trarre molti vantaggi nell’estendere i diritti di cittadinanza: «L’Italia rappresenta uno dei paesi con un maggiore e crescente invecchiamento e, al contempo, uno di quelli più colpiti dal calo delle nascite, aggravato dalla crescente precarietà dell’occupazione» (p. 95). Una situazione talmente compromessa per cui già oggi è evidente che qualora si favorissero gli accessi in Italia, le migrazioni non possono rappresentare la sola risposta ai problemi che la demografia pone alla società italiana. Appare invece urgente attuare un insieme di interventi in cui i flussi migratori possono svolgere un ruolo importante ma non certo unico, dovendo essere accompagnati in primo luogo da un aumento della fecondità /natalità. Senza dimenticare, peraltro, che le stesse famiglie di immigrati si stanno rapidamente adeguando al modello familiare italiano nella direzione di procrastinare o limitare la maternità a causa della disattenzione delle politiche pubbliche su questo tema. Più in generale, lo si rileva spesso, mancano chiare scelte su come governare l’immigrazione. Questo è un aspetto che riguarda buona parte dei paesi di immigrazione, ma in Italia lo si ravvisa nella causalità e nell’approssimazione con cui si definiscono strategie idonee a favorire l’integrazione. Un problema che si esaspera – come si è notato – con l’ottenimento della cittadinanza ma che rappresenta soltanto l’ultimo anello di una corsa a ostacoli, di cui però mancano molti tasselli affinché si possano tracciare, mediante opportune politiche pubbliche, ben definiti processi di integrazione in grado di assicurare alla società italiana compattezza, omogeneità e protezione senza alcuna forma di discriminazione. Se si guarda alla situazione attuale sembra un obiettivo lontano, eppure basterebbero nozioni basilari sulla storia dell’immigrazione per capire che non vi è alternativa. Infatti, come è evidente nel libro di Acocella, nel corso dei secoli i movimenti migratori non sono mai stati reversibili e neppure parzialmente arginabili ma solo interpretabili. Un’annotazione che nella sua essenzialità dovrebbe sollecitare la politica a progettare più che a opporsi sterilmente di fronte alle grandi correnti che attraversano la Storia. Anche perché la Storia non si ferma, meno che mai di fronte alle grandi migrazioni di uomini e donne che hanno cercato un avvenire migliore. Un desiderio – è bene ripeterlo – legittimo e incontestabile.
di Francesco Dandolo


