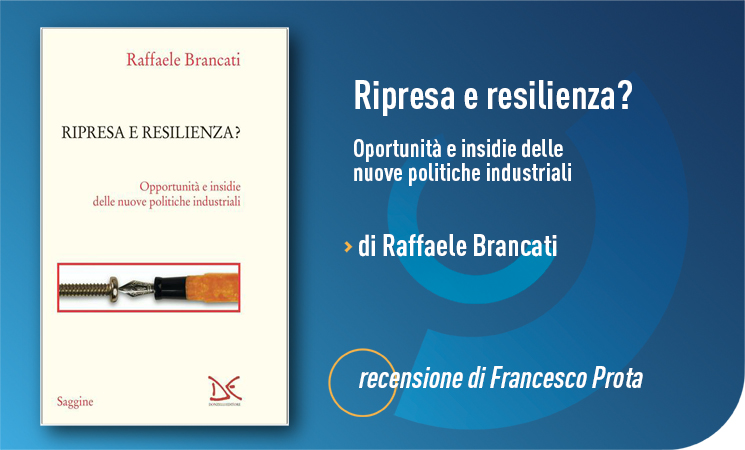
Il libro di Raffaele Brancati, Ripresa e resilienza? Opportunità e insidie delle nuove politiche industriali, offre una serie di interessanti spunti di riflessione intorno a due macro-temi: (i) l’andamento del sistema produttivo italiano negli anni delle crisi (prima, la crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008, e, poi, quella provocata dalla pandemia da Covid-19) e (ii) l’evoluzione recente delle politiche pubbliche attuate in Italia con, da ultimo, l’avvio del «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» (PNRR).
Con riferimento al primo macro-tema, l’Autore si concentra sull’analisi dei cambiamenti nei comportamenti delle imprese dal 2008 in poi, evidenziandone, in primis, l’eterogeneità in riferimento ad innovazione, attività di ricerca e sviluppo e presenza sui mercati internazionali e mostrando come, nonostante le note criticità interne al settore manifatturiero italiano, esista “un tessuto imprenditoriale in movimento” (p. 70) che ha attuato processi di upgrading strategico. L’eterogeneità dei processi evolutivi tra imprese e la volatilità delle performances a livello aziendale nell’industria manifatturiera italiana è del resto un dato consolidato nella letteratura economica. L’aspetto più originale risiede nella classificazione proposta che si basa sugli orientamenti strategici perseguiti dalle imprese, in particolare sulla presenza di quelli che l’Autore individua come driver della competitività, ovvero attività innovative, R&S ed esportazioni, e che ci permette di distinguere fra imprese “statiche”, “intermedie” ed “integrate” (p. 61). Da questo punto di vista il saggio fornisce interessanti informazioni per il disegno delle politiche pubbliche: è fondamentale che nella definizione delle misure di sostegno al sistema produttivo si tenga esplicitamente conto del fatto che una sua caratteristica peculiare è l’elevata eterogeneità e di come tale caratteristica possa impattare sull’efficacia degli strumenti messi in campo. È evidente, ad esempio, come l’approccio orizzontale basato su incentivi generici alle imprese possa risultare (e sia di fatto risultato) complessivamente poco efficace nel contesto italiano nell’innescare le necessarie modifiche strutturali, in particolare nelle aree più deboli del Paese.
A mio giudizio è con riferimento al secondo macro-tema ed alle riflessioni elaborate intorno al «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» che il libro propone le considerazioni più interessanti. Sulla genesi che ha portato alla scrittura del Piano e sulle criticità legate a quella fase, basti pensare al cambio di Governo (dal Governo Conte II al Governo Draghi) e alla quasi totale assenza di un dibattito pubblico con le rappresentanze politiche e le forze economiche e sociali, si è scritto. In tema di politiche industriali, l’Autore evidenzia come “per le piccole e anche per le medie imprese, le misure previste sembrano scollegate le une con le altre e […] propongono una sostanziale continuità rispetto al passato, sia pure con una dotazione finanziaria maggiore” (pp. 4-5).
Qui Raffaele Brancati coglie quello che è il limite principale del PNRR ovvero la mancanza di una visione strategica di lungo periodo: il Piano non disegna un percorso di trasformazione strutturale del Paese che, invece, sarebbe necessario per la ripresa di uno stabile percorso di crescita della nostra economia e per una riduzione delle ampie disparità territoriali che hanno visto un ampliamento nell’ultimo decennio. Questo limite si riflette nell’utilizzo prevalente di strumenti di politica industriale tradizionali, di tipo automatico (la principale linea di intervento per dotazione finanziaria è “Transizione 4.0”).
Nel Piano non trovano eco i più recenti sviluppi del dibattito accademico sul disegno di moderne politiche industriali in grado di rispondere alle sfide del XXI Secolo. Non è questa la sede per una discussione approfondita dei numerosi lavori teorici ed empirici sul tema, per cui mi limiterò a richiamare alcuni degli aspetti, a mio avviso, più rilevanti del dibattito e che sostengono le riflessioni di Raffaele Brancati. Il primo riguarda le motivazioni alla base della politica industriale: gli interventi non devono limitarsi a mitigare i fallimenti di mercato, ma devono affrontare le sfide sociali ed ambientali più rilevanti per la società. Il secondo riguarda l’ambito di applicazione che non può più essere limitato al settore manifatturiero ma, in economie in cui il peso occupazionale dell’industria è decrescente, deve includere il settore dei servizi e più in generale tutte le moderne attività economiche. Da questo punto di vista proprio il termine “politica industriale” può essere fuorviante nel momento in cui non rende chiaramente l’idea di una mission più ampia.
Il terzo riguarda la necessità di una politica industriale che coinvolga tutti gli attori rilevanti, vale a dire che stabilisca forme nuove di collaborazione fra pubblico e privato: un dialogo costante finalizzato all’individuazione di priorità condivise e alla scelta degli strumenti più adatti. Sempre maggiore attenzione deve essere dedicata alla definizione del setting istituzionale più funzionale alla collaborazione fra soggetti diversi e che possa stimolare l’emergere di una migliore “domanda” di politica industriale da parte dei potenziali beneficiari. Insita in questa concezione è l’idea della sperimentazione e, dunque, della necessità di un costante monitoraggio e valutazione degli interventi.
Per usare le parole di Raffaele Brancati, “[è] necessario […] che tutto l’impianto di policy sia sorretto da monitoraggi e valutazioni continue, che consentano di imparare dalle esperienze passate e dalle evoluzioni recenti di tutti gli operatori coinvolti. Si badi, non analisi meramente formali […] ma reali flussi di informazioni tempestive che, in una logica iterativa, siano in grado di aiutare il policy maker nel processo di aggiustamento e miglioramento delle politiche attive” (pp. 10-11). Il quarto attiene alle finalità della politica industriale che non può limitarsi a favorire la crescita della produttività o un generico cambiamento strutturale senza tenere in conto la direzione del cambiamento tecnologico. Ritengo che l’attuale tendenza del progresso tecnico verso pratiche labour saving possa e debba essere messa in discussione. Al contrario credo che un elemento chiave di una moderna politica industriale sia l’orientare il cambiamento tecnologico in una direzione più rispettosa del lavoro e dell’ambiente.
In sintesi, il volume di Raffaele Brancati, Ripresa e resilienza? Opportunità e insidie delle nuove politiche industriali, ci invita, correttamente, a guardare al PNRR in modo critico. È indubbio che il Piano contenga una lunga serie di interventi utili per l’economia e la società italiana, non propone, però, “un modello di azione coerente, integrato, multilivello e capace di confrontarsi con gli attori esistenti” (p. 131) e che affronti con la necessaria decisione i principali nodi strutturali che affliggono l’Italia: in primis, le disuguaglianze territoriali, generazionali e di genere, il lavoro povero e la debolezza del sistema dell’istruzione e della formazione.
di Francesco Prota


