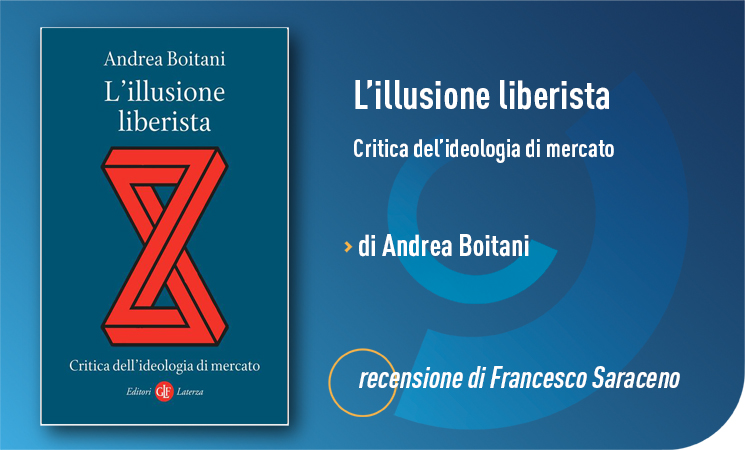
La natura eminentemente politica della “scienza” economica fa sì che ci sia una continua interazione tra questa e le evoluzioni politiche e sociali. Da un lato, l’alternarsi di diversi paradigmi in economia fornisce la base teorica per il susseguirsi di cicli politici; dall’altro, la politica sostiene, e contribuisce a rendere egemoni, le teorie economiche che di volta in volta possono essere funzionali all’agenda di chi è al potere. Si pensi ad esempio a come la rivoluzione conservatrice dell’inizio degli anni Ottanta abbia coinciso con la crisi della teoria keynesiana, e abbia contribuito ad aumentare l’influenza, anche nei circoli di policy, dei teorici delle aspettative razionali e dei cicli reali. Proprio a seguito di quel cambio di paradigma teorico, fin dalla metà degli anni Ottanta è stato egemone in macroeconomia un “Nuovo Consenso” incentrato sulla capacità dei mercati di coordinare in modo sostanzialmente ottimale i diversi agenti che operano nell’economia, tramite variazioni di prezzo capaci di veicolare tutte le informazioni necessarie. Se gli agenti sono razionali e cercano di massimizzare utilità o profitto, le variazioni di prezzo porteranno ad un equilibrio “naturale”, l’attrattore verso cui l’economia tenderà a convergere spontaneamente[1]. Inoltre, in assenza di rigidità e imperfezioni di vario genere (potere di monopolio, informazione asimmetrica e imperfetta, rigidità di prezzi e salari, etc.) che impediscano ai mercati di funzionare in modo fluido, l’equilibrio naturale coincide con quello ottimale, vale a dire con l’allocazione delle risorse che massimizza l’utilità dell’agente detto rappresentativo. Quante più imperfezioni e rigidità esistono, tanto più l’equilibrio naturale sarà distante dall’ottimo. Questo schema concettuale delimita in maniera drastica il campo della politica, che deve operare al servizio dei mercati rimuovendo quanto più possibile le rigidità (è questo il ruolo delle riforme strutturali), e consentendo quindi all’equilibrio naturale di avvicinarsi a quello ottimale. Insomma, la politica (economica) deve “lasciar fare” (laissez faire, appunto) i mercati dopo aver preliminarmente operato perché essi possano operare in modo fluido.
Una teoria inadatta a spiegare le dinamiche sociali
Essendo incentrato sulla razionalità degli agenti che interagiscono solo tramite i mercati e sul ruolo di attrattore dell’equilibrio naturale, il Nuovo Consenso ha molte difficoltà ad incorporare fenomeni come l’insorgere di crisi, il persistere dell’economia in equilibri subottimali (ad esempio caratterizzati da elevata disoccupazione) e così di seguito. Non è un caso quindi che la crisi finanziaria globale del 2008 abbia segnato la fine del dominio incontrastato del paradigma, e proposto (occorrerebbe forse dire riproposto, visto che per molti versi le controversie di oggi ricalcano quelle che negli anni Trenta seguirono alla crisi del 1929) un appassionante dibattito teorico. Un dibattito che certamente prende spunto dalla risposta delle autorità di politica economica alla crisi finanziaria per cercare di approdare ad una visione più equilibrata sul ruolo rispettivo di Stato e mercato nel garantire crescita e stabilità; ma che cerca anche, ed è forse più importante, di evidenziare come le ricette propugnate dal Nuovo Consenso abbiano contribuito a rendere l’economia mondiale più fragile e a rendere inevitabile la crisi stessa. Ripensare queste ricette e cercare di definire un paradigma alternativo al liberismo è quindi condizione necessaria per un’economia più resiliente, per utilizzare un termine molto in voga negli ultimi tempi.
Con L’illusione liberista Andrea Boitani contribuisce a portare a conoscenza del grande pubblico i termini di questo dibattito. Boitani ci ha abituati ad una scrittura fluida e comprensibile, capace di rendere accessibili concetti che a volte possono essere ostici anche per chi ha conoscenze di economia. Ma lo stile fluido, le invenzioni retoriche (in questo volume molti Capitoli iniziano con delle lettere di colleghi e amici cui l’Autore, in seguito, risponde confutandone gli argomenti) non vengono mai perseguiti sacrificando il rigore dell’argomentazione. E, altrettanto importante, non pretendendo mai che divulgazione voglia dire necessariamente neutralità. Boitani fin dal titolo (e dal sottotitolo: Critica dell’ideologia di mercato) chiarisce che in questo tentativo di divulgazione lui prende partito e auspica un superamento del paradigma liberista.
Boitani comincia nei primi Capitoli con il rimettere in questione le fondamenta del credo liberista, vale a dire che l’istituzione “mercato” sia l’unica necessaria, in una società moderna, per armonizzare i piani di agenti economici (imprese, consumatori) atomistici che interagiscono solo sui mercati, appunto, reagendo a variazioni dei prezzi; prezzi che sono in grado di veicolare tutta l’informazione necessaria agli agenti per formulare piani ottimali. Si tratta di una chiave di volta del risultato dell’ottimalità dei mercati, ovviamente, perché tanto più le interazioni sociali avvengono al di fuori del mercato, tanto più difficile è per questo allocare le risorse in modo ottimale. Boitani elenca tutti i casi di “fallimenti del mercato”, dai classici beni pubblici (per cui i mercati non sono in grado di evitare comportamenti opportunistici) al potere di mercato delle grandi aziende, passando per le asimmetrie informative, per le specificità di mercati come quello del lavoro e per i comportamenti non razionali. Le mille caratteristiche insopprimibili di una moderna economia, insomma, che rendono le allocazioni di mercato non ottimali. È particolarmente interessante il caso del mercato del lavoro (sul quale forse Boitani avrebbe forse potuto soffermarsi più a lungo), nel quale la relazione tra lavoratori e imprese è un complesso rapporto in cui la fiducia, il capitale intangibile, le competenze specifiche si intrecciano, e in nessun modo possono essere ridotte ad una transazione pecuniaria, la fornitura di servizi in cambio di un salario. È proprio in considerazione di queste caratteristiche del mercato del lavoro che quasi tutti i governi dei paesi avanzati, in risposta alla crisi del Covid (e diversamente da quanto avvenne nel 2008), hanno preferito estendere gli schemi di cassa integrazione piuttosto che rinforzare i sussidi di disoccupazione. Ci si è infatti resi conto che, a parità di spesa per lo Stato, fosse preferibile preservare quanto più possibile i rapporti di lavoro, le conoscenze implicite, i rapporti di fiducia e di consuetudine (quindi, indirettamente, il capitale umano dei lavoratori). Se, come postulato dalla teoria neoclassica, l’intera economia potesse essere ridotta a transazioni mediate dal mercato, la cassa integrazione e il sussidio di disoccupazione sarebbero stati equivalenti per il benessere collettivo.
L’uso politico della teoria economica
Le prescrizioni di politica economica del pensiero liberista, efficacemente contestate da Boitani, rappresentano uno dei casi più eclatanti dell’uso “politico” della teoria economica cui si faceva cenno prima. Il risultato neoclassico di ottimalità dei mercati era all’inizio del ventesimo secolo stato derivato come la descrizione di un idealtipo irraggiungibile nella vita reale, utile per fornire un riferimento in un mondo imperfetto; è così che lo intendeva ad esempio Ken Arrow, uno dei giganti della teoria dell’equilibrio generale. A partire dagli anni Settanta, invece, si è lentamente scivolati, come afferma Boitani, “dalla parabola al teorema”: la “società di mercato […] costituita quasi solo da relazioni di scambio volontario” (p. 8) descritta dai modelli neoclassici, in cui milioni di agenti vengono coordinati in modo efficiente in migliaia di mercati dalla mano invisibile, invece di un semplice riferimento normativo è diventata l’obiettivo da perseguire per uomini politici ed economisti. Ancora, la politicizzazione dell’efficienza dei mercati è evidente dalla posizione del pensiero liberista sui grandi monopoli, che teoricamente dovrebbero essere visti come il fumo degli occhi (e lo erano per i pensatori delle origini come Adam Smith) perché il potere di mercato è uno di quei canali attraverso i quali le rendite rendono le allocazioni di mercato non ottimali. Tuttavia, Stigler, Hayek, Friedman, negli anni Settanta sostennero che le norme antitrust facevano più danno che altro, perché tutelavano la concorrenza danneggiando il consumatore, cui i grandi monopoli consentivano invece consumi a prezzi bassi (lo stesso argomento avanzato oggi dai difensori di Amazon). Anche quando le condizioni per l’ottimalità non sono rispettate, insomma, i mercati sono comunque preferibili alle soluzioni pubbliche (norme antitrust o regolamentazione). La conclusione di Boitani è senza appello: “La libertà della (grande) impresa, per i liberisti teologici, val bene una messa. Usano il teorema della mano invisibile per dare dignità (via efficienza) al laissez-faire, per poi asserirne la superiorità anche quando le rarefatte condizioni per la validità di quel teorema non esistono e lasciar fare significa lasciare campo libero ai grandi predatori monopolisti. Tra laissez-faire e concorrenza scelgono il laissez-faire” (p. 24).
La disuguaglianza eccessiva riduce l’efficienza
Nei Capitoli successivi Boitani entra nei dettagli dell’”illusione liberista”, analizzando come il paradigma della società di mercato non fornisca gli strumenti analitici adatti a far fronte alle grandi sfide del nostro tempo. L’uguaglianza, la transizione ecologica e (aggiungiamo noi) la salute, sono beni comuni per i quali l’intervento pubblico è necessario a correggere allocazioni di mercato che sono lontane anni luce dalla massimizzazione del benessere sociale. Qui vorrei soffermarmi su un tema che mi sta particolarmente a cuore, quello della distribuzione del reddito. Nel quadro neoclassico in cui i mercati armonizzano i piani individuali, la remunerazione dei fattori di produzione (i salari ad esempio) è uguale alla loro produttività marginale, definita a grandi linee come il contributo del fattore in questione alla produzione del reddito. A ognuno secondo i propri meriti insomma. Ne consegue che la desiderabilità sociale della distribuzione dei redditi, il suo carattere più o meno equo, non è un problema dell’economista, che deve solo preoccuparsi dell’ottimalità (l’efficienza) dell’allocazione. Molti economisti d’ispirazione neoclassica si sono negli anni dichiarati contrari alle politiche redistributive proprio perché, a loro parere, avevano un impatto negativo sugli incentivi d’imprese e consumatori. Si riteneva al contrario che favorendo le classi più agiate si sarebbe incentivato il risparmio e l’investimento, e quindi indirettamente anche la crescita e la produttività. È questo il trickle-down: l’aumento della diseguaglianza aumentando la crescita porta a maggiore benessere per tutti, non solo per i ricchi. La ricerca recente mostra tuttavia, con sempre maggiore forza, che l’eccessiva disuguaglianza costituisce un freno alla crescita economica. Questo si spiega con il fatto che, contrariamente a quanto postulato dalla teoria, chi ha beneficiato della ridistribuzione nel corso degli ultimi decenni non lo ha fatto in relazione a una presunta maggiore produttività, o a fenomeni come la globalizzazione e il progresso tecnico; sono piuttosto i comportamenti predatori delle élite che spiegano la divaricazione tra i salari dei più ricchi (soprattutto ma non solo nella finanza) e la produttività marginale del loro lavoro, e quindi l’aumentata disuguaglianza. È per questo che, anche prima della pandemia, si sono moltiplicate le prese di posizione a favore di un ritorno ad una maggiore progressività della tassazione.
In conclusione, L’illusione liberista ci consegna una spietata analisi delle insufficienze del paradigma liberista e dell’uso strumentale che ne è stato fatto dalle élites economiche e politiche negli ultimi quarant’anni. A voler cercare il pelo nell’uovo, il lettore rimane con un sentimento di incompiutezza, perché alla pars destruens vorrebbe che Boitani facesse seguire una pars construens, disegnando almeno a grandi linee quello che secondo lui potrebbe essere un paradigma alternativo. Alcune idee in tal senso sono presenti nel suo lavoro di ricerca accademico; c’è da augurarsi che possano diventare l’oggetto del suo prossimo libro.
di Francesco Saraceno


