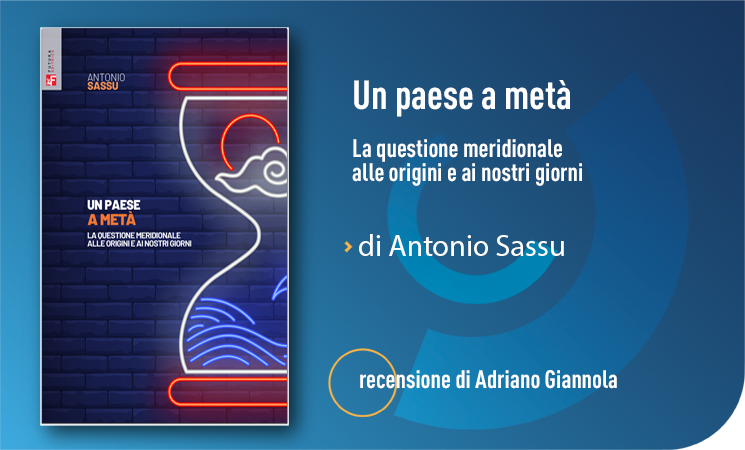
Un Paese a metà. La Questione Meridionale alle origini e ai nostri giorni di Antonio Sassu (Roma, Futura Editrice, 2022, pp. 254) è un libro importante, una riflessione a tutto tondo le cui conclusioni, laboriosamente articolate, giungono a valle di una attenta ricerca che dedica particolare attenzione all’analisi delle origini della Questione Meridionale e considera senza conformismi e timidezza i fattori istituzionali alla base del tremendo dualismo italiano.
Non si tratta dell’impegno squisitamente accademico che, con consumata sapiente eleganza, indagherebbe la metafisica – oggi alla moda – dello sviluppo guardando alle istituzioni, alla loro sperimentata e duratura scarsa performance fino, fatalmente, a convergere nella denuncia del ruolo deludente delle “classi dirigenti” locali e ricamare attorno alla scarsa dotazione di “capitale sociale”: ineffabile buco nero del nostro sottosviluppo endogeno. Non troviamo, in altri termini, i tratti tipici di una lettura cara agli (a)meridionalisti in servizio permanente effettivo che hanno ispirato, gestito e scommesso per più di trent’anni su fallimentari politiche di coesione riparametrando, di stagione in stagione, i motivi della delusione sul fallimento delle classi dirigenti locali; né si indugia sulla retorica della place based analysis prescrittiva di terapie ex ante votate al fallimento per l’assiomatica liquidazione di una seria analisi della patologica interdipendenza territoriale. Analisi che fedeli alla stucchevole impresa di “abolire” il Sud hanno alimentato le illusioni del Centro-Nord a perseverare nella lunga marcia verso il nulla.
Mettendo a fuoco il ruolo delle istituzioni, il libro, a mio avviso, offre argomenti cruciali per qualificare – nel caso di specie – la tautologica fragilità della tesi del “fallimento” delle istituzioni alla base del “fallimento delle nazioni” con una diagnosi problematica che non aderisce alla meccanica semplificazione del deus ex machina del carente “capitale sociale” del Sud – privo di uno “splendido medioevo” e perciò inadatto al “modello italiano” – da abolire – appunto – e al quale somministrare un “trattamento rieducativo obbligatorio” (la Nuova Programmazione Economica). Peccato che intanto le presunte virtù del “modello italiano” siano tramontate in un imbarazzato silenzio.
Sassu non batte quei sentieri nè tanto meno propone giudizi affrettati, sommari; invece con ostinata e insistente caparbietà argomenta, ordina le evidenze che legittimano conclusioni semplici e solide “per allora” che tornano molto utili “ora”. Egli affronta il tema da diversi fronti per verificare e ricostruire in densi capitoli una complessa rete logica-storica-analitica indispensabile premessa per procedere a interpretare e valutare gli eventi e gli effetti del lungo periodo post-unitario. Non si tratta di una analisi retrospettiva, bensì di fare chiarezza su “dove andiamo sapendo da dove veniamo”.
La miniera del meridionalismo classico
La miniera da coltivare e per attingere evidenze con metodo e rigore è l’enorme patrimonio del meridionalismo classico (da anni messo in soffitta) le cui analisi anticipano di un secolo l’economia e la sociologia dello sviluppo e del sottosviluppo. Ad essa l’Autore si volge con metodo e lucidità.
Ne esce a mio avviso una conferma che a poco serve nel caso italiano l’affascinante progetto del “fallimento delle nazioni”, popolato di suggestive tautologie: istituzioni “inclusive”, “estrattive”, spartitorie, predatorie utili solo a fornire cronachistiche suggestioni, nebulosi orientamenti a una sfuocata navigazione nella nebbia.
Il tema ripropone di fare il punto sulla persistenza più che secolare di come sviluppo e sottosviluppo possono interagire per “garantire” e “governare” in una nazione i meccanismi che alimentano alternarsi di disgregazione e ricomposizione sociale, economica e civile.
Va quindi colta l’originalità dell’approccio, centrato sul leit motiv del nesso istituzioni e sviluppo non come orpello accademico ma strumento necessario per chiarirne ruolo specifico, puntuale e indispensabile punto fermo dal quale partire. Ben diverso è l’approccio “contemporaneo” che molto si dilunga sul “metafisico” nesso tra formale e informale, laddove il caso Nazionale, narra come la storia inizia con l’imposizione in corpore vili ed ex abrupto (si fa per dire) non della negazione di una memoria ma del violento azzeramento di istituzioni tutt’altro che informali, cancellate con un violento colpo di spugna e sostituite con istituzioni “rinnovate” e consapevole discriminazione in danno della massa più povera dei “nuovi” sudditi. Dunque cosa ben diversa del conflitto psicanalitico tra presente e memoria, utile – forse – per indagare, elaborare, teorizzare lo stigma enigmatico del familismo amorale.
La genesi del rapporto Nord-Sud illustrato con drammatica concretezza, acquista una precisa cangiante dimensione che si riflette sull’oggi e porta a dire che la contraddizione vive tuttora in forme “civilizzate” e dove la speranza di riscattare le tenebre del passato è realizzare in concreto il progetto-miraggio della Costituzione repubblicana che, non a caso – tuttora – rappresenta la “Istituzione informale” per eccellenza.
Essa, nel 1948 per la prima volta nella storia unitaria – dopo il Referendum che cancella la “conquista regia” – esplicita e norma l’impegno a confrontarsi con una secolare evidenza. Come noto, dal 2001 il “progetto” è più che mai affidato alla superstite irrequietezza della costanza della ragione chiamata ad affrontare temi iper-contemporanei di quell’antico conflitto che si traducono in regionalismo, localismo, autonomia.
Sassu non tergiversa, utilizza una efficacissima strategia della memoria e percorre molti sentieri diversi e tutti convergenti, a fare il punto-nave con riferimenti ed analisi, utilizzando l’efficace scandaglio del meridionalismo classico. Il risultato riconduce, senza scampo, ai dati strutturali genetici della Questione. Appellarsi all’apparente formale discrasia tra istituzioni formali ed informali è, a mio avviso, una concessione al conformismo accademico relegato nella metafisica, laddove il mondo effettivo, i fatti, semplicemente, narrano la drammatica – per molti versi opportunistica e ottusa – strategia di transizione da un “vecchio” ad un “nuovo” regime: una transizione senza esito concluso, tuttora in essere.
La prima modernizzazione
È detto molto bene del carattere regressivo e traumatico del “nuovo” che si presenta in odore di modernizzazione a ridosso dell’Unità. Sono argomentate con opportuna analitica insistenza le lacerazioni che impattano sulla massa contadina del proletariato meridionale che – ostaggio di un sistema parafeudale – invece di beneficiare della “liberazione” subisce un’addizionale compressione delle sue fonti materiali di sussistenza. La “prima modernizzazione” (per la “seconda” si dovrà aspettare fino gli anni ’50 del Novecento) potenzialmente funzionale alla diffusione della piccola proprietà agraria fu invece scientemente governata – direttamente e per delega – dallo Stato centrale a vantaggio dei latifondisti, del proliferare di una piccola media borghesia di “galantuomini” e di intermediari cui vanno i benefici delle “eversioni”. L’acesso alle risorse “liberate” in violazione dei previsti criteri di ripartizione per quote, sottrae ai contadini sussistenze storiche, trasformate in rendite usurpate e legittimate in nome della difesa del diritto alla proprietà privata. In altri termini, invece di attenuarsi, la Questione Agraria del Sud, con l’ Unità diviene un esplosivo terreno di conflitto. Che ciò consenta o meno di evocare una guerra civile non impedisce di concludere che il nuovo contesto istituzionale si impone con brutale insipienza politica.
Gli effetti sociali dell’eversione dal feudalesimo e dalle proprietà ecclesiastiche per certi versi rinviano all’esperienza inglese delle enclosure. In quel caso il pauperismo dilagante, la “creazione” del proletariato fu una violenza funzionale al decollo della rivoluzione industriale e a imporre il potere travolgente del profitto-da-sfruttamento rispetto alla rendita. Al Sud, il tardo processo di enclosure, la compressione della sussistenza contadina, è funzionale a consolidare un’alleanza politica con la vecchia classe dominante e una borghesia entrambe beneficiarie dell’incremento della rendita parassitaria poco o nulla utile a “modernizzare” ma piuttosto a confermare e rafforzare con la conquista regia le patologie pregresse della struttura economica e sociale meridionale. L’emigrazione di massa sarà una risposta innovativa, visto che la forza lavoro espulsa dalla terra è inservibile al decollo di una manifattura che nel Sud viene invece sostanzialmente cancellata e che – laddove si avviava – attinge al proletariato settentrionale eccedente le opportunità di sfruttamento nell’industria tradizionale e nell’agricoltura capitalistica locale.
L’analisi, così, solidamente incardina il nesso conflittuale tra istituzioni e sviluppo e lo identifica immediatamente nel rapporto “politico” Nord-Sud, destabilizzante e che è pura apparenza ricondurre alla discrasia tra “istituzioni formali” e “informali”. Alla radice di un “Paese a metà” il traumatico impatto della conquista regia evolve e si trascina senza trovare soluzione: a ben vedere, oggi la surreale richiesta di autonomia rafforzata del Nord in crisi rivendica la legittimazione di un persistente privilegio che si riverbera a scala territoriale sui diritti di cittadinanza.
La “prima modernizzazione”, la violazione delle pur deboli garanzie formali previste, scientemente eluse (a partire dalla mancata quotizzazione degli usi civici ai contadini), se da un lato alimenta delusione, sfiducia, rancore e rifiuto anche violento dell’ordine imposto alle masse contadine del Sud dal nuovo potere costituito, d’altro lato, rappresenta il cemento – ben noto – del blocco storico italiano fino al secondo dopoguerra: un ritorno politico non da poco per una “rendita da Unità” concessa a poco prezzo, in spregio a regole vigenti.
Ordine nuovo, dualismo, intervento straordinario
Dalla metafisica della discrasia tra istituzioni formali e informali si approda alla traumatica realtà del passaggio dal “vecchio” al “nuovo Stato”.
Come noto, ai grandi proprietari, ai galantuomini, alla violenza -legale e non- garante della proprietà private, si contrappone violenza, sfiducia, pratiche informali di resistenza assurte a “missione” da movimenti illegali e/o criminali.
Insipienza del nuovo potere centrale- Pare proprio di no. Sassu ricorda l’invito alla prudenza e alla moderazione di Cavour che inopinatamente mancò pochi mesi dopo l’Unità, nè furono considerati i motivi di perplessità di osservatori qualificati .
È il trauma del trapasso istituzionale. Il “nuovo ordine” si impone con brutale concretezza quale solido epicentro delle alterne e contrastanti dinamiche post-unitarie. Le evidenze analitiche sedimentano e confortano non tanto la teoria del “perchè le nazioni falliscono” ma la storia esemplare di come e perchè le “nazioni esistono” e gestiscono in forma evolutiva drammatiche discrasie e contraddizioni.
Quanto all’accademico conflitto tra il formale e l’informale calza bene l’arguta osservazione di Keynes sui “geometri euclidei” che non mancano mai di prendersela con le parallele perchè esse non si incontrano.
A riflettere e valutare contribuisce la rassegna tematica che i capitoli sviluppano efficacemente dando spessore a una riflessione di lungo periodo che dal passato remoto evoca ed allude al presente. Un filo rosso che abilita il meridionalismo classico ad illustrare anche le vicende e l’evoluzione del secondo dopoguerra quando – fino agli anni ’70 – si impone la “fisiologia” dello sviluppo dipendente, poi progressivamente e sapientemente eterodiretto, invece, verso una crescente “patologia”. Si tratta di un fertile contributo che stimola a ripensare alla non effimera stagione dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno. Proprio per l’originalità operativa e di metodo esso avrebbe meritato un “posto al sole” di un’attenta considerazione visto che – come ci ricorda Sassu – ha rappresentato qualcosa di più di una felice parentesi per il Nord, per il Sud e per tutto il Paese.
La stagione dell”intervento straordinario affrontò la Questione in forme del tutto originali superando il prototipo della Tennessy Authority Valley, facendo da ponte tra meridionalismo classico e neomeridionalismo strategico e di azione. Nel merito, è a mio avviso particolarmente significativa la notazione “antemarcia” di Franchetti riportata da Sassu che mette a nudo un motivo decisivo del nostro dualismo. Commentando il caso Sicilia e la difficoltà in generale di efficaci interventi nel Mezzogiorno egli sottolinea che anche quando c’è la volontà di intervenire: “…medesimi elementi psicologici producono nelle diverse condizioni della società, atti diversi….La forza che trasformi in poco tempo le condizioni….deve dunque venire da fuori, cioè dal Governo….. fin tanto che il Governo si appoggerà sugli elementi locali…l’opera sua sarà miseramente inefficace, se non sarà nociva”. Chiara e cristallina diagnosi, oggi valida quanto ieri, da integrare con un monito ulteriore altrettanto valido per il quale se ci si affida agli interventi legislativi del Governo, i risultati sono deludenti: per ottenere la massima efficacia occorre che “la forza che trasformi…da fuori” non si limiti al Governo ma sia un’Entità dedicata, autonoma ed al preciso scopo dal Governo delegata. Così è stato quando – per onorare l’impegno assunto nel 1948 in Costituzione – fu varata nel 1950, con la Riforma agraria, la Cassa per gli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno. In un arco temporale poco più che ventennale essa ha affrontato con notevole successo l’impegno di ridurre il divario avviando una trasformazione strutturale del Sistema. Senza ombra di dubbio, fino all’avvento delle Regioni, la Cassa accoglie, fa tesoro ed emenda il monito di Franchetti inaugurando con l’“economia keynesiana dell’ offerta” un efficace ed operativo neomeridionalismo. A quella stagione – gli anni della Presidenza Pescatore – Sassu riconosce in un breve inciso il merito della notevole riduzione del divario economico e sociale.
La Cassa cessò nel 1984, sostituita nel 1986 dall’ Agensud, al servizio delle Regioni, le quali già dal 1974 avevano avocato poteri di programmazione e gestione dell’intervento. Segue nel 1993 l’abolizione dell’intervento straordinario e nel 1998 il decollo della cosidetta Nuova Programmazione Economica (NPE) che, con burocratica didascalica pedanteria, evoca un Sud autopropulsivo e prova a temperare la patologica “straordinarietà” regionale con la sterile stagione dei Patti Territoriali.
La Cassa consentì al Paese di guadagnare piena cittadinanza nell’Europa nata dal Trattato di Roma (1957): se, fino a pochi anni addietro, essa fu oggetto di forte contestazione, oggi l’impietoso confronto con la NPE e le politiche di coesione della Ue tendono a mitizzarla. Duole constatare il fatto che l’emergenza attuale non attinga lumi per orientare il confuso procedere del Piano Nazionale con il quale l’Ue nel chiedere di “cambiare rotta”, finanzia con più di 200 miliardi di euro il grande malato d’Europa.
Una considerazione preoccupante, particolarmente pertinente, in linea con l’osservazione più volte esplicitata da Sassu che all’Europa affida le residue speranze di riaprire in positivo la questione delle “due Italie”.
Approfondimenti, prospettive
Il prezioso e stimolante lavoro di Sassu sollecita l’interesse ad ulteriori approfondimenti. La relazione tra istituzioni e sviluppo privilegia un approccio macro e richiede il supporto di una dimensione microeconomicamente fondata che consideri il ruolo delle regole e dei valori degli operatori, tanto più rilevanti in situazioni peculiari come i sistemi dualistici e/o in ritardo di sviluppo. Affinchè non “falliscano le nazioni” la funzione delle istituzioni è di garantire l’operatività dei mercati e la fiducia dei soggetti che li animano e li utilizzano. Fiducia reciproca, necessaria per avere rapporti sani, solidi, prevedibili. È banale concludere che istituzioni “porose” esposte a instabilità comportamentali, come tali percepite dagli operatori, risultino meno efficaci ed efficienti rispetto a istituzioni “impermeabili” ad anomalie quali corruzione, traffico di influenze, voto di scambio, ecc.
Le valutazioni di prospettiva concernenti solidità e rischio di fallimenti comportamentali divengono quindi essenziali per l’operatività; così la condizione di reciprocità chiede cittadini adempienti e fedeli ad un “credo”, a un comune patrimonio di capitale sociale. In un’ottica comparativa ci si deve interrogare quanto intensamente la “buona salute” del rapporto tra istituzioni e cittadini risulti condizionata e retroagisca su fattori di dualismo strutturale. La presunzione di neutralità sarebbe illusoria. Basta fare riferimento al caso di mercati razionati, un tratto caratteristico del dualismo: quello del lavoro in primis; così come quello del credito e dei capitali. Fermandoci al lavoro, quale che sia l’ipotetica fedeltà a valori e la dotazione di capitale sociale individuale, non si può non predire un assetto progressivamente più instabile rispetto ad un sistema con minore grado di razionamento.
In altri termini, a forti vincoli sul mercato la risposta individuale al di là di una certa soglia induce ad eludere le regole e la fedeltà ai propri valori (il caso del Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord può essere un caso di scuola, facilmente verificabile). Tutto ciò avrà effetti diversificati sulla “qualità” delle istituzioni, determinando una corto circuito che potrà essere ridimensionato modificando stabilmente il tasso di razionamento: in altri termini, promuovendo lo sviluppo.
All’albore delle “due italie” l’inasprirsi del razionamento sulle già estreme condizioni di sussistenza – frutto della prima modernizzazione – fu determinante per alimentare un lungo, penoso conflitto: non solo tra Nord e Sud ma una vera e propria guerra civile al Sud. È a proposito utile riandare al dualismo decisionale hirschmaniano: le vicende di quella guerra ora dimenticata, ufficialmente negata, soffocarono con la forza la Voice, consolidarono una ben nota passività rassegnata e aprirono – con l’emigrazione – spazi imponenti all’Exit.
In queste circostanze le istituzioni sono pure sovrastrutture formali. Per recuperare un loro fisiologico ruolo si impone una lunga azione riparatrice, di “ricostruzione”. A più di settanta anni dalla Costituzione repubblicana, applicarla è la più credibile e prioritaria tra le scelte possibili: la migliore garanzia affinchè il Sistema non fallisca. A tal fine è a dir poco elusivo l’appello all’efficienza o la stucchevole retorica delle riforme. Decisive sono le azioni immediate per dare fiato alle aspettative di promuovere la convergenza del “contesto effettivo” verso il “progetto” che rimane tuttora ampiamente “virtuale”. Un esito non scontato pienamente colto nelle stringate e pregnanti note conclusive di Sassu che affidano all’Europa la missione che si è finora dimostrata per noi quasi impossibile.


