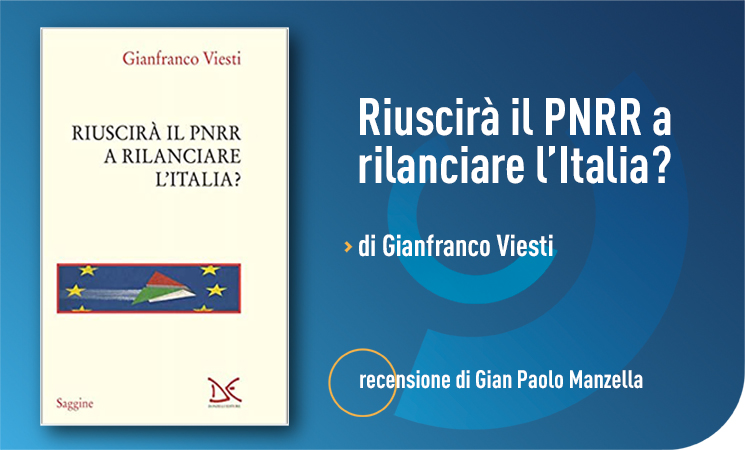
Il volume di Gianfranco Viesti arriva al momento giusto. Mentre si scrive – Maggio 2023 – le difficoltà della impostazione strategica del PNRR stanno emergendo con chiarezza; è in discussione con la Commissione europea la possibilità di una sua revisione; sul piano interno, la polemica politica vede in posizione sempre più centrale i ritardi nell’attuazione del programma di investimenti.
Bene, dunque, proprio in questo momento della ‘vita’ del PNRR, avere a disposizione uno scritto chiaro, aggiornato e che, per così dire, fa diverse cose insieme. Perché questo è e fa il libro di Gianfranco Viesti.
Innanzitutto, perché il lavoro dell’economista pugliese racconta l’origine del Piano, lo contestualizza nel momento storico e politico in cui viene adottato in attuazione del Next Generation EU: sia rispetto a quel che in quel momento faceva la Commissione, sia cogliendone il suo valore più profondo. Quello di segnare una cesura tra l’Europa della “austerità” e quella degli “investimenti”, con una centralità nuova di temi chiave per il futuro europeo, quali il contrasto alle diseguaglianze, la coesione territoriale, la doppia transizione, a partire da quella verde.
Lo scritto spiega, subito dopo, perché la posizione dell’Italia nel consesso europeo sia quella, delicatissima, di ‘osservata speciale’: alla luce della rilevanza delle risorse ricevute dal nostro Paese in base ai criteri individuati dalla Commissione per ripartire le risorse; della scelta italiana di ‘tirare’ tutte quelle a disposizione del nostro Paese, sia nella parte contributi, sia in quella dei prestiti; delle ‘storiche’ difficoltà nella spesa dei fondi europei e del loro possibile acuirsi di fronte ad un volume di investimenti molto più elevato. Il libro distingue, poi, con chiarezza, i meccanismi di funzionamento del PNRR da quelli dei Fondi strutturali, ponendo in rilievo le ‘specularità’ tra i due strumenti: l’uno fondato sul rapporto diretto tra Stati e Commissione e basato su obiettivi e performance, l’altro, invece, che poggia sul livello regionale e si caratterizza per il legame stretto con gli avanzamenti di spesa sul piano contabile, piuttosto che sui risultati raggiunti.
Questa lunga intro è seguita da un’analisi che precisa in dettaglio l’impostazione ed i capitoli del Piano Italia Domani.
Se ne pone in rilievo la dimensione ‘qualitativa’, fatta di 527 impegni attuativi – di cui 213 a prevalenza normativa e amministrativa e 314 legati alla concreta realizzazione di investimenti – a cui vanno aggiunti i 302 obiettivi del Piano complementare finanziato con risorse nazionali. Una complessità che si trova riflessa nell’organizzazione del Programma di intervento che vede 6 “missioni”, articolate in 16 componenti e 43 ambiti di intervento. Specifica attenzione è poi data ai temi ‘chiave’ delle infrastrutture, delle città, dell’istruzione, dei servizi ai cittadini, della competitività delle imprese, collocandola nell’ambito delle scelte di politica industriale: sino ad interrogarsi sulla effettiva capacità del PNRR di ‘cambiare le cose’, di “rilanciare”, appunto, l’Italia.
Ed è forse proprio alla luce della dimensione ‘storica’ e ‘valoriale’ in cui lo studioso barese colloca il Piano Italia Domani, che il risultato della sua analisi è severo: sotto diversi profili. A partire da quello della sua impostazione originaria, che si è concretizzata in un raggruppamento di progetti disponibili piuttosto che in un programma organico definito a partire dai bisogni; sino a quello delle scelte di governance, che hanno visto la sostanziale estromissione del livello regionale e la perdita di saperi ed esperienze stratificati in anni di politica di coesione, con il risultato di progetti che “cadono dall’alto” nei territori, senza tener conto delle loro specificità.
Su questi vizi originari di assetto si innestano quelli ‘dinamici’, che Viesti segnala e spiega con grande linearità: la complessiva debolezza attuativa, affidata ad amministrazioni impreparate in termini di capacità progettuale anche per una decennale politica di ‘tagli’ che hanno colpito con specifica intensità le amministrazioni del Mezzogiorno; quello di una declinazione meridionalista del PNRR che non è capace, per i meccanismi di allocazione delle risorse, di assicurare con certezza l’effettivo rispetto dei target di spesa destinata al Sud individuati dal legislatore; sino ad arrivare alla forte ‘politicizzazione’ della guida dell’esercizio finanziario, che ha visto il recente accentramento della sua regia presso la Presidenza del Consiglio e la sostituzione, al momento dell’avvicendamento tra il governo Draghi e l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, di diversi dei responsabili amministrativi che avevano guidato la fase di avvio.
Il risultato di questo mix di indicazioni, come scrive Viesti, è un PNRR che “non riuscirà a cambiare l’Italia”. Se questo è vero, si deve far di tutto, però, per non derubricarlo ad “occasione persa”. E per questo Viesti ci indica come coglierne, anche in questa fase avanzata, tutte le sue potenzialità. Innanzitutto prestando la massima attenzione alla sua completa e tempestiva realizzazione; assicurando, poi, il più stretto coordinamento con le altre risorse finanziarie disponibili – dal Piano complementare ai Fondi strutturali, da Repower EU, sino alle dotazioni del livello regionale – e, soprattutto, lavorando al riaprirsi di ogni possibile spazio di confronto, nelle istituzioni e nella società, rispetto alle opzioni di sviluppo possibili per il nostro Paese.
Ma è anche la prospettiva futura che, secondo Viesti, deve modificarsi a seguito di questo passaggio così rilevante per la ‘cultura’ dell’intervento pubblico italiano ed europeo. Il Piano Italia Domani – sin dal suo titolo geneticamente orientato al futuro – può, infatti, costituire una semplice “parentesi” ovvero segnare “l’avvio di un periodo differente”. Sta, quindi, tutta qui la sfida politica ed amministrativa che l’Italia ha di fronte nei prossimi anni: quella di far sì che “i processi di cambiamento” avviati con il PNRR si estendano e si consolidino. Ecco che osservato sotto questa angolatura il Piano Italia Domani va quindi tratto fuori da uno sguardo attento esclusivamente a risorse finanziarie, regole e riforme e portato, invece, anche su un altro piano: di ben maggiore ambizione. Quello del considerarlo per quello che esso effettivamente è: un programma di interventi che può e deve cambiare le cose e che – sia a questo stadio avanzato del suo iter, sia in prospettiva futura – deve essere posto in grado di dare al meglio il suo essenziale contributo alla dotazione italiana di beni pubblici, alla competitività della sua impresa, alla complessiva ‘sostenibilità’ del suo sviluppo. E, insieme, ritenerlo uno strumento essenziale per concorrere – dal punto di vista istituzionale, del rapporto pubblico-privato, della promozione di un’idea condivisa di sviluppo – alla ricostruzione di quello “spirito repubblicano” che solo può contribuire, nel profondo, ad un rilancio italiano.
di Gian Paolo Manzella


