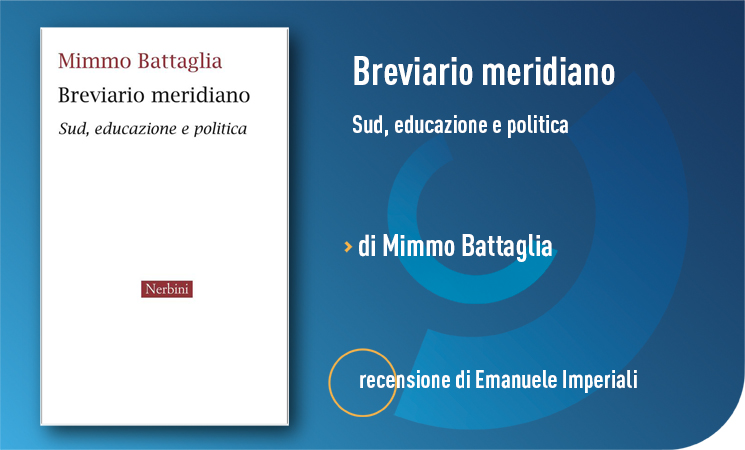
Il Manifesto per un Patto educativo rivolto all’Area metropolitana di Napoli, sulla scia del Patto educativo globale di Papa Francesco, ha rappresentato il primo atto forte e concreto del ministero pastorale del nuovo Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia. E quel Patto rappresenta il fil rouge del volume Breviario meridiano Sud, educazione e politica, da lui scritto. Perché l’educazione è tra le forme più alte della Politica, in quanto mira a creare una società più giusta ed equilibrata. Un esercito di maestri, auspicava Gaetano Salvemini. E Gesualdo Bufalino li riteneva indispensabili per contrastare le mafie. Appena nominato Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, profondo conoscitore della realtà meridionale, in quanto prima era stato nelle diocesi di Catanzaro e di Cerreto Sannita, lanciò il Patto allo scopo di sovvertire quella educazione alla violenza e quella cultura della sopraffazione che la camorra impone e che alligna in troppi vicoli della città, Già nelle prime pagine don Mimmo, come preferisce essere chiamato da tutti, spiega perché l’educare sia un fatto politico, per certi versi addirittura rivoluzionario. Chi educa, è il pensiero di Battaglia, si rivolge alla comunità, offre ai giovani una possibilità di riscatto, alternativa a quella educazione alla violenza che caratterizza le organizzazioni criminali. Che le mafie del Sud, tutte, siano il cancro del Paese può forse apparire tautologico. Ma serve al presule per illustrare la portata rivoluzionaria dell’educare.
Chi educa, infatti, ha una missione che travalica i confini della singola relazione per rivolgersi all’intera comunità, alla realtà sociale più vasta, alla situazione di incompiutezza nella quale la compagnia degli uomini e delle donne vive, chiedendo un di più di giustizia, di fraternità, di pace. Per questo l’educazione è un fatto politico. Significa innanzitutto non adattare i giovani al contesto, ma spingerli verso il cambiamento (pag. 7).
Evocativa è la storia che l’Autore racconta, mettendo in relazione due donne, Martina e Simona. La prima è una ragazzina, vive in periferia di una grande città del Centro Italia, abita in una casa popolare e ha appena 14 anni. Fa la prima media, l’ha ripetuta nientemeno che quattro volte, continuamente bocciata da una scuola che non riesce a integrarla e ad accoglierla. Martina ha un handicap, è nata con i piedi torti, ma ciò non attenua la sua straordinaria vivacità. È seguita dai servizi sociali a causa della sua continua evasione scolastica. Viene affidata a un’educatrice, Simona. Da quel momento si incontrano due storie, che appartengono a due mondi diversissimi tra loro. I primi tentativi dell’educatrice sono volti a far comprendere a Martina le regole della realtà esterna alla ragazzina, la scuola, le istituzioni, la società civile. Con la scuola che continua a tenerla ai margini, però, Simona si sente sola, in alcuni momenti viene anche colta dallo sconforto, prova con molta difficoltà a ricucire le trame della comunità. Per farlo comincia lei stessa a frequentare il mondo di Martina, ne comprende i sogni spezzati. La ragazzina ha un sogno, da grande vorrebbe fare la parrucchiera. L’educatrice allora capisce che solo facendosi compagna di strada di Martina potrà educarla. E pian piano la ragazzina comincia a credere in sé stessa. Grazie alla testardaggine di Simona, Martina riesce a superare la terza media, si iscrive così al primo anno della scuola professionale per acconciatrici. E solo allora Simona la lascia andare per la sua strada.
Il titolo del Patto educativo per l’Area metropolitana di Napoli che don Mimmo lanciò appena giunto a Napoli è significativamente “I figli sono di tutti”. Nell’appello, al quale sono giunte centinaia di adesioni, l’Arcivescovo sosteneva “A tutti dico: è vero, stanno uccidendo Napoli; ma camminando insieme ed unendo le nostre forze possiamo divenire protagonisti di una nuova stagione di riscatto, curando le ferite della nostra città e alimentando semi di bene” (cfr. Appello dell’Arcivescovo don Mimmo Battaglia per un Patto educativo per la Città Metropolitana di Napoli, I figli sono di tutti, 13 ottobre 2021). L’obiettivo è quello di creare un sistema di comunità generativo di vita e di speranza, alternativo alle logiche di morte e disperazione del sistema mafioso. Il senso del libro trova la sua genesi in questo Patto, perché solo le scintille del bene comune possono far voltare pagina. Se educare è politica, allora tornano alla mente le parole di Paolo VI che diceva “la sana politica è la più alta forma di carità”. E don Lorenzo Milani, dalla scuola di Barbiana, ricordava di aver “imparato che il
problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia”.
Come dire, il vuoto di educazione è vuoto della politica stessa, rende la vita più povera di opportunità, di diritti, di speranze, di sogni. Perché educare non è mai un fatto privato. In fondo cosa era la Polis di Platone se non un organismo educativo collettivo? Il poliedro di cui parla Papa Francesco nell’enciclica Evangelii Gaudium, è una figura geometrica che riflette la confluenza di tutte le parzialità. Un Capitolo del libro di don Mimmo ha un titolo che richiama un paradosso: Onnipotenza e impotenza educativa. La prima, puntando unicamente sull’educazione, finisce per pedagogizzare i problemi sociali e fornisce risposte parziali. La seconda scommette solo sulla repressione e sottovaluta la fase educativa. Sono entrambe risposte sbagliate, in quanto svalutano la complessità dell’uomo e della società che lo circonda. Per il presule, l’educazione è sì decisiva, ma il suo esito dipende dal rapporto che c’è con le altre variabili in campo. “Tecnica e politica sono le due anime del lavoro sociale, educativo, di cura. La prima è stata coltivata e approfondita, mentre la seconda si è un po’ smarrita e chiede di essere ritrovata” (pag. 85).
Un pomeriggio – racconta l’Arcivescovo – ho incontrato alcuni ragazzini che giocavano con delle pistole finte. Ciò che mi ha impressionato non è il gioco in sé, ma l’imitazione realistica del linguaggio e dello stile camorristico, tale da lasciar intravedere che quella cultura non era loro estranea, ma in qualche modo la respiravano, la assorbivano, probabilmente senza degli adulti capaci di essere per loro filtri sani (p. 37).
Nel nostro Paese, ormai senza distinzioni troppo significative tra Sud e Nord, le regole delle mafie impongono una pedagogia della violenza e dell’omertà e offrono ai giovani opportunità di apparente riscatto. Solo contrastando il modello educativo deviato delle mafie si può incentivare un vero cambiamento nelle comunità. La verità è che, di fronte al nichilismo, alla solitudine, alla fuga nel virtuale, alle droghe, c’è da chiedersi perché i giovani si rassegnino a questi disvalori mentre dovremmo aiutarli a riscoprire la umanità che c’è in loro.
Ecco perché – incalza don Mimmo – servono avamposti educativi nelle scuole, nelle strade, sul web, nelle famiglie. Allo scopo di dar loro un sogno alto, accompagnandoli in un percorso che sia capace di trasformare questo sogno in un segno. I giovani ce lo chiedono, pretendono che noi adulti mostriamo loro responsabilità e siamo testimoni della realtà alternativa che offriamo loro. E alla domanda perché un Vescovo si occupa di questi temi, la risposta del prelato è Perché un Vescovo non può non farlo (pag. 35).
Nella seconda parte del volume l’Arcivescovo è molto critico sulle politiche per il Sud. Il prelato fa un excursus degli strumenti che la Politica ha messo in campo per fronteggiare la crisi delle politiche meridionalistiche. Sul PNRR sostiene che manca la cosa più importante, lo sguardo fiducioso della gente che è stanca, la cultura della solidarietà, la politica fatta dal basso. Secondo don Mimmo, lo Stato ha dimenticato la preghiera laica della vicinanza ai più deboli. Solo i guerrieri della
quarta età sostengono, attraverso la rete del welfare familiare, figli e nipoti. Sono assenti i poveri in carne e ossa, che popolano le nostre città e facciamo finta di non vederli. E ciò postula serie politiche per il lavoro, di fronte a un capitalismo sempre più cinico e beffardo. Ma al tempo stesso invoca una rivalutazione del Terzo settore che non si limiti a fornire servizi, ma punti sul welfare di comunità. A proposito della tanto ricorrente centralità del Mediterraneo, commenta don Mimmo, bisogna riscoprire quel pensiero meridiano di tradizione mediterranea caro ad Albert Camus e poi a Franco Cassano.
L’Arcivescovo è preoccupato di una politica che, disgiunta dall’etica, si lascia logorare dalla corruzione dilagante e dall’incompetenza. Le nuove politiche di sviluppo, a parere del presule, debbono umanizzare la politica meridionalistica, perché senza giustizia sociale non c’è pace. E non si tratta dell’assistenzialismo, fa capire Domenico Battaglia, bensì di una strategia capace di riaccendere la fiamma della speranza. Quindi, speranza e fiducia, ripartendo dalle persone. Solo così la Politica diverrà la più elevata forma di carità.
di Emanuele Imperiali


