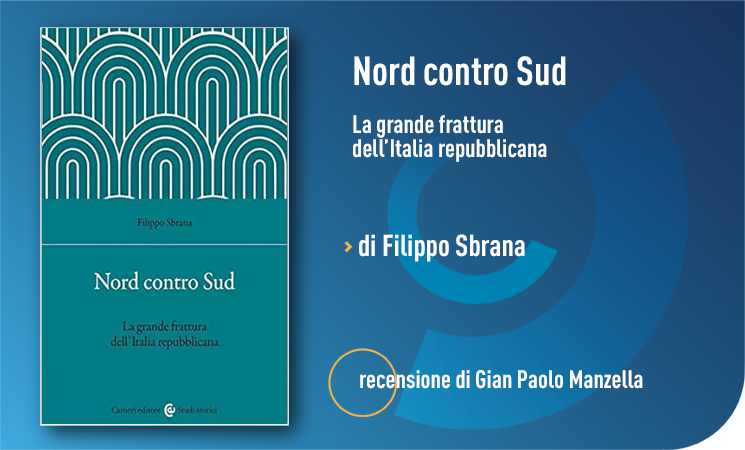
“Nord contro Sud” è il titolo, azzeccatissimo, di un bel libro che Filippo Sbrana ha appena pubblicato per i tipi di Carocci. Bel libro è, però, limitativo: perché quello di Sbrana è uno studio per molti versi cruciale per chi è interessato, oggi, al meridionalismo, Ma non è interessante solo per un “meridionalista moderno”. Lo studio del professore dell’Università per stranieri di Perugia è una lettura molto utile, infatti, per chi è interessato alla storia economica italiana degli ultimi cinquant’anni e per chi vuole capire come sono nate alcune delle idee che domina- no, spesso da anni, il nostro dibattito politico.
Sì, perché quello di Sbrana è, a ben guardarlo, un libro che sono più libri insieme.
Prima di tutto, è un testo che analizza il progressivo affiancarsi alla tradizionale “questione meridionale” di una nuova questione, quella “settentrionale”, nel dibattito pubblico italiano. D’altro verso è anche un pamphlet che racconta la trasformazione italiana tra gli anni Settanta e gli anni Novanta del secolo scorso dal punto di vista industriale, sociologico e culturale. E, ancora, è un libro che racconta l’azione della Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno, che svolge la funzione di vero e proprio “coro” nelle vicende che Sbrana racconta: con alla guida un corifeo influente e preveggente quale Pasquale Saraceno, di cui il libro fa emergere il profilo severo ed appassionato.
Queste tre storie si intrecciano tra loro e svelano, proprio in questo loro intrecciarsi, profili e piste di ricerca spesso inaspettate. Pensiamo all’impatto che ebbe la crisi degli anni Settanta su quello che sino ad allora era stato un consolidato discorso pubblico ‘solidaristico’ tra Nord e Sud del paese.
E così gli aspetti qualificanti di questa concezione dei rapporti tra le due aree del Paese che potevano scorgersi con chiarezza sino alla prima metà del decennio – dal riferimento alla questione meridionale come questione nazionale, presente in molti degli Statuti delle regioni del nord, sino all’imponente manifestazione sindacale a Reggio Calabria che vide migliaia di operai settentrionali marciare a sostegno di uno sviluppo italiano equilibrato – sono, infatti, completamente impensabili già alla fine degli anni Settanta. Le condizioni dell’economia di quel decennio avevano, infatti, cambiato le cose. La crisi aveva aumentato le preoccupazioni e l’incertezza di futuro e acuito così elementi egoistici; le esigenze finanziarie delle imprese del Nord si cominciavano a far sentire in opposizione a quelle del Sud; la perdita del legame di classe ‘orizzontale’ tra i lavoratori delle fabbriche veniva sostituita, come d’improvviso, da una nuova dimensione ‘verticale’, con il profilo dell’appartenenza territoriale che guadagnava progressiva importanza. Ben prima della politica era stato il sindacato a cogliere le crepe sempre più evidenti nell’afflato solidaristico che c’era stato dagli anni del dopoguerra: chi era più vicino ai lavorato- ri coglieva subito i segnali del cambiamento in corso.
Crepe che erano destinate ad aprirsi nel decennio successivo. Tutto, in quel passaggio, sembrava congiurare per un passaggio in secondo piano della “questione meridionale” ed un venire in avanti invece di quella “settentrionale”. I deludenti risultati degli investimenti al Sud presentavano il conto in termini di rapporto con la stampa e con l’opinione pubblica; il terremoto dell’Irpinia, dopo la fase della solidarietà, svelava lo spreco di risorse e una gestione contigua alla malavita che portava a coniare il termine Irpinagate, aprendo una voragine nel rapporto ‘senti- mentale’ con il Nord; il protagonismo economico della ‘terza Italia’, che vedeva nel Veneto il proprio terreno di elezione, era accompagnato da una sua sostanziale invisibilità politica, che portava ad una diffidenza verso il potere centrale e, d’altra parte, ribaltava l’attenzione sul livello di governo più vicino – la Regione – che proprio in quel passaggio stava vedendo una sua valorizzazione europea grazie alla politica di coesione. E, ancora, la progressiva crisi di partiti, sindacati e Chiesa delineava uno spazio politico aperto a discorsi a forte connotazione territoriale, slegati da una visione unitaria di Paese. Così come l’affermarsi di un racconto culturale, il ‘riflusso’, improntato all’individualismo, attaccava alle radici l’impostazione solidaristica sino ad allora prevalente, contribuiva a rompere il ‘nesso sentimentale’ tra le due parti del Paese.
È in questo brodo di cultura – in cui confluiscono anche i primi profili di invettiva antimeridionalista (pensiamo al “Forza Etna” che comincia a comparire sui muri delle città settentrionali) – che, dall’inizio degli anni ’90, si afferma politicamente la Lega sotto la guida di Umberto Bossi, abilissimo, nel generalizzato ritardo dei partiti tradizionali nel capire il cambio di atmosfera, a fiutare il vento e sintetizzare queste istanze in slogan politici, a partire da “Roma Ladrona”.
Il libro di Sbrana fa una ricostruzione puntuale di questo passaggio così qualificante della nostra storia politica recente. Ma non c’è solo la puntualità. Lo scritto di Sbrana è anche molto suggestivo. Frutto di un lungo lavoro di ricerca, esso si basa, infatti, su una pluralità di voci: atti normativi e interviste personali, documentazione giornalistica e archivi del sindacato sino ai discorsi dei protagonisti della politica, tra cui specifica attenzione è attribuita a quelli dei Presidenti della Re- pubblica. E, d’altronde, grande è l’attenzione al contesto culturale più ampio: basti pensare ai riferimenti ai lavori dei primi anni Novanta, quando Giorgio Bocca scrive “L’Inferno” proprio sulla condizione del Mezzogiorno ed è formulata la domanda – profonda e allarmante – di Enrico Rusconi: “Se cessiamo di essere nazione”.
Oggi siamo in un passaggio ulteriore di questa storia. Quando il “rumore del tempo” è cambiato e per molti versi si restringe lo spazio per ragionare per territori, ecco che l’atteggiamento di attaccamento alla dimensione regionale dal punto di vista politico appare in qualche modo fuori tempo massimo. Ed è, forse proprio per questo, che la pericolosità di iniziative come quella sull’autonomia differenziata appare ancora maggiore, perché sembra guardare indietro, piuttosto che avanti.
Rimangono, però, alcuni aspetti aperti in questa storia. E sono proprio quelli relativi all’esigenza di lavorare nel senso di ricostruire un “pensiero nazionale” attorno al Mezzogiorno, capace di collocarlo in una prospettiva Europea. C’è dunque l’esigenza, tutta politica, di pensare un nuovo “Mezzogiorno d’Europa”. Ed in questo senso, d’altra parte, il PNRR contiene parole molto chiare sulla connessione ‘stretta’ tra Mezzogiorno ed Europa; parole che forse acquistano un valore speciale proprio alla luce dello scritto di Sbrana che ci fa capire quanto, dopo questa storia lunga cinquant’anni, non siano affatto scontate.
Il punto è quindi chiaro, ed il volume di Sbrana non fa che ricordarcelo. È tenue il legame che tiene insieme Nord e Sud del Paese. Tanto più che è un rap- porto che ha appena vissuto una condizione traumatica e che va quindi gestito con cura. E questo vuole dire specifica attenzione politica sul punto, a partire dall’esigenza per il Mezzogiorno di modificare un racconto di sé oramai anacronistico e di percepirsi per quello che effettivamente è: nei suoi problemi e nelle sue potenzialità. Ci sono poi da affrontare le sfide complicate di questo tempo con un atteggiamento si potrebbe dire agonistico, capace di collocare il sud del Paese in una dimensione europea fatta di qualità amministrativa, di scelte industriali legate alle vocazioni di futuro, di sostegno a lavoratori che debbono reinventarsi. E, ancora, c’è da creare un contesto con uno spirito imprenditoriale forte, con un’azione che parta sin dalle scuole; c’è da mobilitare il sistema della ricerca e dell’Università per far sì che il Sud contribuisca a ridurre quell’Innovation divide che è tema di prima preoccupazione della Commissione; c’è da lavorare per ridurre un divario di cittadinanza che è ancora l’elemento più problematico per i cittadini del Mezzogiorno.
Aggredire, dunque, i nodi che Sbrana individua; con l’ambizione di pro- vare a ritornare al clima unitario e solidale che c’era, in Italia, sino all’inizio degli anni Settanta. L’unico in cui il Paese può veramente riconquistare protagonismo e dinamicità: economica, sociale, culturale.
di Gian Paolo Manzella


