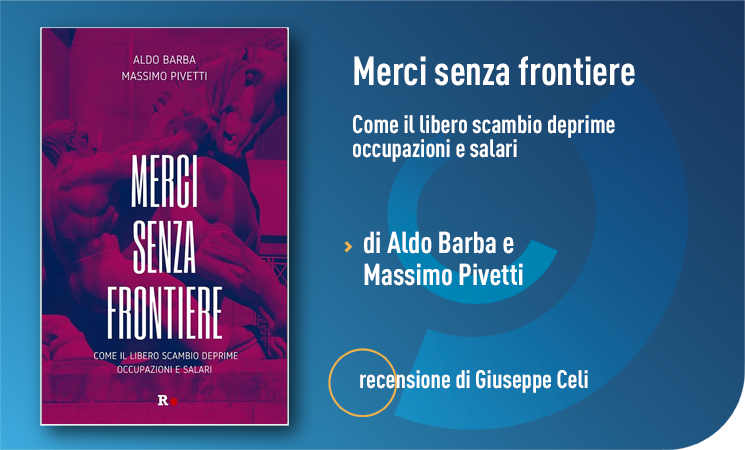
Il bel libro di Aldo Barba e Massimo Pivetti, Merci senza frontiere. Come il libero scambio deprime occupazione e salari (Roma, Rogas Edizioni, 2022, pp. 223), è il secondo di una trilogia che offre una mirata riflessione sulle tre dimensioni dei processi di internazionalizzazione: le migrazioni, gli scambi commerciali e i movimenti di capitale. Con riferimento a questo volume, che è quello dedicato al commercio internazionale, la tesi degli Autori è già anticipata nel titolo: la liberalizzazione degli scambi commerciali sul piano internazionale ha sfavorito pesantemente i lavoratori sia in termini occupazionali che dal punto di vista salariale. Ovviamente, questa affermazione va qualificata guardando alla prospettiva analitica da cui muovono gli Autori, che non è certo quella degli economisti mainstream che già agli inizi degli anni ‘90 del secolo scorso avevano esplorato gli effetti del commercio internazionale tra paesi avanzati e paesi emergenti sui mercati del lavoro, concentrandosi soprattutto sulle ripercussioni in termini di composizione dell’occupazione e di distribuzione del reddito tra lavoro qualificato/non qualificato, non abbandonando mai le ipotesi della teoria neoclassica (come, per esempio, quella di pieno impiego).
A fugare ogni dubbio, il primo Capitolo del libro presenta il punto di vista critico degli Autori rispetto alla teoria standard del commercio internazionale secondo la quale, come è noto, l’impiego delle risorse e la specializzazione dei paesi nelle produzioni in cui risultano più efficienti − e lo scambio di parte di queste produzioni con beni importati, che sarebbero disponibili in quantità minori se fossero prodotti internamente − sono sempre welfare-GDP-improving. La critica che Barba e Pivetti rivolgono a questo assunto generale sui vantaggi del commercio si articola su vari piani. In primo luogo, la dominanza della prospettiva da offerta (la legge di Say) non permette di tener conto dei possibili vincoli da domanda: un paese in free trade irrealisticamente viene assimilato ad una singola impresa operante in concorrenza perfetta che si trova a fronteggiare una domanda con elasticità infinita! (Ma un paese non è né un’impresa, né un individuo!). In secondo luogo, superando l’economia di baratto che è implicita nella visione dei libero- scambisti, e assumendo che un paese possa trovarsi in una situazione in cui le importazioni sopravanzano la sua capacità esportativa e, pertanto, inizi ad accumulare debito sull’estero, il processo di aggiustamento necessario per riequilibrare la bilancia dei pagamenti può costringere lo stesso paese a contrarre consumi e investimenti. Secondo Barba e Pivetti, perfino un meccanismo di aggiustamento del tipo gold standard (basato sulla teoria quantitativa della moneta e sulle variazione dei prezzi) avrebbe un impatto depressivo sul reddito via variazione delle ragioni di scambio, smentendo l’ipotesi che in ogni circostanza il libero scambio sia welfare-improving.
Ma è soprattutto con riferimento a Keynes che gli Autori iniziano a delineare una prospettiva in cui il vincolo esterno alla crescita di un paese che non vada in conflitto con la sua aspirazione al pieno impiego richieda di ripensare la sua dipendenza dall’estero. Al riguardo, il loro racconto della «conversione» di Keynes (libero-scambista negli anni ’20) al protezionismo (verso cui egli si orienta agli inizi degli anni ’30) è illuminante. In presenza di persistente disoccupazione, misure di controllo e sostituzione delle importazioni potrebbero accrescere la produzione e non limitarsi a cambiarne la sua composizione. Keynes, distaccandosi dalla sue posizioni favorevoli al free trade espresse nel decennio precedente, era sempre più convinto che una maggiore autosufficienza nazionale sarebbe stata la strada giusta per migliorare l’utilizzo della capacità produttiva del paese e la qualità di vita della sua popolazione. Questa soluzione veniva prospettata anche in ragione dell’evoluzione strutturale dell’economia: al crescere del reddito, il peso dei prodotti primari e dei manufatti declina progressivamente a favore della crescente incidenza di beni e servizi non-tradable. Pertanto, in questa prospettiva, il costo dell’autosufficienza nazionale legato ad un moderato aumento dei prezzi dei beni tradable poteva essere più che compensato dai vantaggi derivanti da maggiori livelli di occupazione e da un migliore tenore di vita.
Barba e Pivetti sono simpatetici con l’idea di Keynes di contenere la dipendenza dall’estero entro i limiti dettati dallo stato di necessità e di ricorrere in tutti gli altri casi alle produzioni (e alla finanza) nazionali. Del resto, i cosiddetti trent’anni gloriosi di crescita sostenuta che vanno dalla fine della seconda guerra mondiale ai primi anni ’70 rappresentano l’esemplificazione (purtroppo limitata nel tempo e probabilmente irripetibile) di quella idea. Come è noto, le circostanze fondamentali che hanno caratterizzato questa fase particolarmente espansiva dello sviluppo capitalista erano individuabili, in estrema sintesi, in una serie di fattori: 1) un ordine economico internazionale stabile garantito dall’architettura istituzionale di Bretton Woods, che prevedeva un sistema di cambi fissi (ma aggiustabili), convertibilità del conto corrente della bilancia dei pagamenti ma sostanziale controllo sui movimenti di capitale; 2) l’egemonia economica, tecnologica e militare degli Stati Uniti che, anche fornendo la liquidità necessaria per le transazioni internazionali, fungevano da garanti, nel bene e nel male, per il funzionamento e la tenuta del sistema; 3) la disponibilità di fonti energetiche a basso costo; 4) l’abbondanza di forza lavoro disoccupata impegnabile nella ricostruzione; 5) un meccanismo di sviluppo basato sull’interazione virtuosa tra i due motori della crescita, ovvero gli investimenti e le esportazioni: l’espansione della domanda interna e della capacità produttiva in tutti i paesi attivavano le importazioni (cioè le esportazioni dei partner commerciali) e, attraverso il dispiegarsi del moltiplicatore keynesiano in economia aperta, l’interconnessione tra investimenti ed esportazioni garantiva la crescita.
Con riferimento ai trent’anni gloriosi, Barba e Pivetti usano in modo efficace il termine «protezionismo temperato» per segnalare che, sotto l’egida delle istituzioni internazionali che nascono in questo periodo (IMF, WB e ITO, poi sostituito dal GATT), la controllata liberalizzazione degli scambi internazionali non è andata mai in contrasto con gli obiettivi nazionali di pieno impiego da perseguire attraverso politiche di gestione della domanda e, in taluni casi, non escludendo l’uso del controllo delle importazioni e delle politiche industriali. Inoltre, gli Autori offrono una chiave interpretativa di tipo politico per inquadrare le misure economiche eterodosse che vengono adottate nel periodo. Secondo Barba e Pivetti, le politiche di pieno impiego, il rafforzamento del welfare e il miglioramento delle condizioni dei lavoratori sarebbero state indotte anche dalla «paura del bolscevismo». Il successo del modello sovietico nel secondo dopoguerra (in termini di sviluppo economico, tecnologico e militare e di prestigio internazionale per aver sconfitto il nazismo) avrebbe rafforzato l’autodeterminazione del movimento dei
lavoratori nei paesi capitalisti, rendendo intollerabili per gli stessi lavoratori il permanere di condizioni di povertà, disoccupazione o sottooccupazione. Pertanto, le politiche di pieno impiego e di espansione del welfare sarebbero state finalizzate anche a scongiurare l’insorgere di conflitti sociali e la radicalizzazione (anche in senso rivoluzionario) del confronto politico. Barba e Pivetti, richiamandosi ad Hobsbawm, attribuiscono grande importanza all’influenza che ascesa e declino del sistema sovietico hanno esercitato sulle vicende delle economie capitaliste occidentali. Lo stesso emergere del controllo pubblico sulle attività industriali – dopo la crisi del ’29 negli USA e nel secondo dopoguerra nei paesi europei – avrebbe tratto ispirazione dalla pianificazione sovietica.
Con la crisi degli anni ‘70, le circostanze che avevano assicurato ai paesi capitalisti occidentali circa tre decenni di crescita economica sostenuta e stabile vengono meno. La supremazia economica degli Stati Uniti veniva progressivamente erosa in seguito all’inasprirsi della concorrenza internazionale: le imprese americane dovevano ora competere più duramente con quelle tedesche, francesi e giapponesi per contendersi le rispettive quote, in un mercato diventato ormai di sostituzione e non più in espansione, per effetto della saturazione della domanda per i beni di consumo di massa durevoli. Si era passati da un regime concorrenziale internazionale basato sul prezzo ad uno basato sulla differenziazione qualitativa e innovazione di prodotto. Inoltre, il meccanismo di sviluppo basato sull’espansione della domanda interna e sull’influenza reciproca di investimenti ed esportazioni iniziava ad incepparsi. Dei due motori della crescita, ne restava solo uno, le esportazioni, occasionalmente sostenute dai consumi privati che − data la stagnazione dei salari divenuta cronica negli anni successivi − venivano finanziati a debito e, pertanto, erano insostenibili nel lungo periodo. Gli investimenti e l’accumulazione di capitale, pertanto, smisero di avere un ruolo decisivo nella crescita e il loro arretramento apriva la strada alla finanziarizzazione dell’economia e alla frammentazione produttiva internazionale. Il processo di finanziarizzazione fu comunque preceduto dalla fase di inflazione, che era ancora la manifestazione di dinamiche economiche e sociali da inquadrare in un contesto di politica economica in cui sovranità monetaria e fiscale erano garantite. Se ancora a cavallo tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ’70 il progressivo assorbimento della disoccupazione incoraggiava sommovimenti della società per la distribuzione del reddito e per un modello socioeconomico più inclusivo alimentando l’inflazione come solvente dei conflitti sociali, dagli anni ‘80 in poi la discontinuità tra l’era keynesiana e quella della globalizzazione neoliberista diventava drammaticamente evidente determinando un cambiamento di paradigma nella conduzione della politica economica. Barba e Pivetti ricordano lo sciopero dei minatori nel Regno Unito e quello dei controllori di volo negli Stati Uniti come esempi emblematici di attacco frontale alle classi lavoratrici da perseguire con la deflazione e l’aumento della disoccupazione. Lo stesso processo di Europeizzazione (la via europea alla globalizzazione e all’integrazione monetaria) è interpretato dai due Autori come un progetto mirante a indebolire la forza contrattuale dei lavoratori salariati. La separazione tra Stato e moneta sancita dall’UME, ossia la centralizzazione monetaria coesistente con politiche fiscali nazionali sottoposte a vincoli stringenti, ha portato inevitabilmente alla deflazione. Lo stesso credo monetarista, più che forza ispiratrice innovativa basata sulle idee e la teoria, è stato un mezzo per giustificare ideologicamente ragioni di ordine pratico che, secondo Barba e Pivetti, sarebbero alla base del nuovo corso di politica economica. La deflazione, secondo i due Autori, si configurerebbe come la strategia di risposta al riesacerbarsi del conflitto distributivo (legato al permanere nel tempo di elevati livelli occupazionali), in presenza della fine della paura del comunismo (connessa al declino e all’implosione del sistema sovietico).
Si potrebbe aggiungere che ragioni pratiche sono alla base dello stesso percorso che ha portato alla costituzione dell’UME, che rimanda alla compenetrazione di due modelli: quello tedesco che, forte dei successi conseguiti dalla Germania nel contrastare la stagflazione, affermava la stabilità dei prezzi come strategia primaria per l’occupazione e la crescita; e quello americano che, legittimato dalla buona performance economica degli Stati Uniti nella prima metà degli anni ‘80, rivendicava la deregolamentazione e la liberalizzazione dei mercati (del lavoro, dei beni, dei capitali). In effetti, in un arco temporale relativamente breve, i paesi europei, in linea col modello americano, abolivano il controllo sui movimenti di capitale (1985-1990), eliminavano le barriere non tariffarie per la creazione del mercato unico (1993) e affidavano la regolazione della concorrenza ad un’entità sovranazionale. E, d’altra parte, in linea col modello tedesco, iniziavano a seguire una condotta di politica economica disinflazionistica basata prevalentemente su restrizioni monetarie. Come sostenuto da McNamara 2, il monetarismo non avrebbe avuto la stessa influenza in Europa se non si fosse considerata la Germania come un modello da seguire: l’economia tedesca aveva superato il test dei due shock petroliferi degli anni ’70 con una politica monetaria restrittiva e con livelli di disoccupazione ed inflazione molto più bassi rispetto agli altri paesi. Se vogliamo, in Europa, si andava affermando una versione «pragmatica» del monetarismo perché i «fatti» sembravano dare ragione al monetarismo accademico: il già menzionato successo della Germania, l’assenza di un trade-off tra inflazione e disoccupazione; l’apparente esistenza del NAIRU, ecc. Questa connotazione pragmatica del monetarismo, più che la sua forza di persuasione teorica, potrebbe spiegare perché anche economisti di orientamento progressista (non monetarista) avessero alla fine accettato politiche monetarie e fiscali restrittive di orientamento monetarista in Europa. In altri termini, l’integrazione europea, nonostante i suoi connotati neoliberisti, veniva accettata anche dai progressisti, in quanto portatrice del salvifico «vincolo esterno», il deus ex machina che avrebbe corretto i vizi nazionali: gli stessi movimenti di capitale liberalizzati avrebbero funzionato da frusta per punire i comportamenti «dissoluti».
Secondo Barba e Pivetti, tuttavia, questa svolta radicale nell’impianto di politica economica, consistente nel restringimento dello spazio di manovra all’interno e nell’espansione della dimensione esterna e dei relativi vincoli alla crescita, non era inevitabile se si pensa alle istanze protezionistiche (basate sul controllo delle importazioni) che pur si erano manifestate nei paesi europei prima della deriva liberoscambista: istanze di matrice keynesiana nel Regno Unito (da parte del CEPG), gollista in Francia (Jean-Marcel Jeanneney), socialdemocratica in Germania (Wolfang Hager). Nonostante l’emergere di manifestazioni di dissenso verso il libero scambio (molto meno robuste in Italia, soprattutto da parte della sinistra), il processo di piena liberalizzazione dei mercati si impose in modo incontrastato portando ad un significativo incremento del grado di apertura dei paesi. Secondo Barba e Pivetti lo stesso aumento del rapporto importazioni/PIL che si è registrato negli ultimi quattro decenni nei paesi avanzati è legato al fatto che lo stesso incremento delle importazioni ha determinato un rallentamento della crescita del prodotto. In generale, le ripercussioni della svolta neoliberista hanno comportato deindustrializzazione, ipertrofia dei servizi, delocalizzazioni produttive all’estero, indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori e contrazione salariale.
Barba e Pivetti criticano in modo articolato la tesi post-industrialista della terziarizzazione della produzione come evoluzione fisiologica che riflette la terziarizzazione dei consumi e quindi il passaggio alla fruizione di beni superiori con incrementi di benessere. In realtà, la trasformazione strutturale è stato un processo traumatico che ha comportato disoccupazione, esclusione sociale e peggioramento delle condizioni di vita. I servizi hanno svolto il ruolo di «settore spugna» che, lungi dal garantire il pieno impiego, ha messo in luce l’assenza di politiche di gestione della domanda in grado di assorbire la disoccupazione tecnologica e quella legata ai processi di integrazione internazionale. La tesi di Barba e Pivetti − che la deindustrializzazione e la terziarizzazione non sono state un percorso «naturale» ma sono state il frutto di scelte di politica economica legate all’adesione alla svolta neoliberista − è assolutamente condivisibile. La loro tesi è in linea con l’interpretazione dell’interruzione del processo di industrializzazione dei paesi del Sud Europa come risultato della «liberalizzazione prematura», e in contrasto con l’idea di «terziarizzazione prematura» sostenuta in alcune visioni «essenzialiste» dello sviluppo delle economie mediterranee6.
Nell’ambito del settore terziario, in paesi come l’Italia, il turismo internazionale ha svolto e svolge un ruolo rilevante, sia in termini di contributo diretto e indiretto all’occupazione e al valore aggiunto complessivi dell’economia, sia come componente fondamentale del saldo delle partite correnti. Barba e Pivetti dedicano un Capitolo significativo all’argomento, segnalando gli effetti distorsivi di uno sbilanciamento eccessivo della struttura produttiva verso le attività turistiche: le ripercussioni in termini di inquinamento e degrado ambientale per effetto degli spostamenti e dello smaltimento dei rifiuti; lo stravolgimento culturale e sociale delle tradizioni e delle comunità locali; aggiungerei, la precarietà e la bassa qualità dei posti di lavoro attivati. In generale, possiamo dire che questo progressivo sbilanciamento produttivo verso le attività turistiche rientra nel solco dei processi di finanziarizzazione innescati dalla svolta neoliberista. Il processo di Europeizzazione post-Maastricht e l’appartenenza all’UME hanno canalizzato ingenti flussi finanziari dai paesi centrali a quelli periferici, tra cui l’Italia (con continuità almeno fino alla crisi del 2008). Questi flussi non hanno alimentato investimenti industriali a lungo temine (come sarebbe stato auspicabile), ma hanno finanziato attività con rendimenti a più breve termine e con caratteristiche di maggiore volatilità. Il turismo rientra in queste attività. Come ricordano Barba e Pivetti, questa ipertrofia del settore turistico in Italia − unitamente ai drammatici tagli alla sanità dovuti alle politiche di austerità perseguite negli anni precedenti − si rivelerà fatale quando nel 2020 irrompe la pandemia: la forte incidenza dei settori legati al turismo su PIL e occupazione è una circostanza che ha reso il nostro Paese particolarmente vulnerabile all’impatto economico del coronavirus e delle misure di contenimento del contagio.
Di fronte alle evidenti fragilità legate ad un’eccessiva dipendenza dalle attività turistiche, Barba e Pivetti propongono una serie di misure volte, da un lato, a contenere i flussi turistici internazionali (per esempio, aumentando in modo sostanziale le tasse aeroportuali o quelle di soggiorno, o introducendo regole più severe nella frequentazione dei centri urbani e delle altre località turistiche), dall’altro lato, a sostituire le attività legate al turismo con misure di sostegno della domanda interna. I due Autori propongono un vero e proprio «piano di sviluppo sociale, culturale e ambientale» attivato dallo Stato con l’obiettivo di far ripartire investimenti di edilizia popolare, infrastrutturale (strade, trasporti, ospedali) e di manutenzione del territorio (rispetto agli eventi sismici o al dissesto idrogeologico). Il problema è che il settore turistico contribuisce a riequilibrare strutturalmente la bilancia dei pagamenti di un paese come l’Italia, e un suo ridimensionamento andrebbe in conflitto con l’equilibrio esterno. Pertanto, nella parte finale del libro, la questione del rispetto del vincolo estero in presenza di elevati livelli di occupazione viene affrontata da Barba e Pivetti attraverso l’identificazione delle strategie di politica industriale e commerciale più opportune ed efficaci.
I due Autori, col supporto di dati significativi, illustrano molto bene come negli ultimi decenni la stagnazione degli investimenti, oltre a contribuire al calo dei consumi e dei salari, abbia determinato un aumento del contenuto di importazione della domanda. Industrie strategiche di base − come quella siderurgica, quella chimica e farmaceutica, quella energetica e ora quella dei semiconduttori (definiti come «acciaio dell’era digitale») − sono diventate fortemente dipendenti dalle importazioni, in Italia e in altri paesi europei. Inoltre, aggiungerei che i processi di segmentazione del mercato del lavoro in Europa, determinando una crescente incidenza dell’occupazione a basso salario e dei working poor, hanno accresciuto le importazioni dei beni di consumo finali (e loro componenti) dai paesi a basso costo del lavoro. Barba e Pivetti propongono, allora, la politica industriale come strumento principale per una sorta di «reindustrializzazione»; finalizzata, cioè, a far ripartire gli investimenti pubblici nei settori sensibili a cui si è accennato e, nel contempo, attivando l’espansione della domanda interna per il riassorbimento della disoccupazione. La politica commerciale attraverso controlli selettivi delle importazioni e l’imposizione di tariffe − da preferirsi rispetto alle restrizioni quantitative, in quanto le entrate tariffarie consentono di compensare eventuali squilibri distributivi − servirebbe ad allentare il vincolo esterno («creare spazio») nella fase di transizione richiesta affinché gli investimenti pubblici raggiungano l’obiettivo di ridurre la dipendenza dall’estero. Pertanto la politica commerciale, più che incentivare la produzione interna sostitutiva delle importazioni, svolgerebbe il ruolo di complemento alla politica industriale, che viene identificata dai due Autori come il cardine della strategia di crescita del prodotto e dell’occupazione.
Ovviamente, come ben sappiamo, questa strategia confligge con l’assetto delle regole che l’Unione europea si è data nel dominio della politica industriale. Che fare, allora? Per rispondere a questa domanda, può essere utile guardare ad alcuni recenti sviluppi che riguardano il ritardo dell’Europa nella competizione tecnologica con Stati Uniti e Cina in alcune aree chiave (come i semiconduttori o le tecnologie verdi), che è stato ampiamente documentato negli anni recenti7. Di fronte all’affermazione di un competitor globale aggressivo come la Cina che ha impiegato massicci fondi statali per sostenere particolari settori strategici (semiconduttori, batterie agli ioni di litio, pannelli solari, ecc.), dall’Ue sono arrivati, almeno sulla carta, segnali di un possibile cambio di passo nella conduzione della sua politica industriale. Un passaggio da un approccio orizzontale (politiche industriali neutre, intese come politiche della concorrenza) ad un approccio verticale, più «muscolare», che punta a sostenere settori strategici. In effetti c’è stato un proliferare di iniziative della Commissione europea in questa direzione. Ne cito due, a mo’ di esempio: il REpowerEU (sul fronte energetico) e l’EU Chips Act (sul fronte dei semiconduttori, di cruciale rilevanza per la transizione digitale, elettrica, nonché ecologica). Queste iniziative segnalano il passaggio dell’UE da attore neutrale sul piano globale (con un’attitudine normativa e orientata al mercato) ad attore geo-economico che punta all’autonomia strategica? Il confronto con la potenza di fuoco quantitativa e qualitativa (in termini di interventi di politica industriale) messa in campo da competitor globali come USA e Cina non sembra suffragare questa ipotesi. Questi paesi hanno un potere decisionale dello Stato (che si traduce in vigorosi interventi di politica industriale) che l’UE, come un tutto, non ha (Barba e Pivetti citano il caso passato del consorzio Airbus come importante investimento industriale strategico europeo, ma sostanzialmente lo etichettano come un progetto «anti-comunitario», a ragione). La stessa deroga dalle regole comunitarie che impediscono/limitano gli aiuti di Stato alle imprese è oggetto di divisione oggi in Europa. La Germania sarebbe favorevole a questo allentamento delle restrizioni, ma soltanto se gestito in proprio da ciascun paese. I paesi più piccoli, e quelli con minore spazio fiscale, si oppongono alla posizione tedesca, perché la soluzione individuale condurrebbe ad un ulteriore allargamento dei divari centro-periferia tra i paesi europei (cosa che in effetti è avvenuta durante la pandemia: le imprese tedesche sono quelle che hanno beneficiato maggiormente degli aiuti di Stato). Se l’allentamento delle restrizioni agli aiuti di Stato fosse invece supportato da un fondo comune europeo, i paesi periferici sarebbero favorevoli, in quanto i rischi di ulteriore polarizzazione sarebbero minori.
Di fronte alle divergenze e alle contraddizioni che minano ormai da tempo la sostenibilità del progetto europeo, un radicale cambiamento del modello di sviluppo seguito finora dai paesi dell’Unione si impone, anche lungo le linee suggerite da Barba e Pivetti. Tre pesanti shock globali nell’arco di quindici anni (la crisi del 2008, la pandemia ed ora la guerra in Ucraina) hanno cambiato significativamente i processi di integrazione internazionale. La fase di iper-globalizzazione che abbiamo conosciuto fino a pochi anni fa si è interrotta e, probabilmente, non si ripeterà più. Già la pandemia ha mostrato la fragilità delle catene globali del valore e l’importanza per i paesi europei e per l’Italia di non perdere la capacità di produrre internamente quello di cui necessitano, come ci ricordano Barba e Pivetti. Per la prima volta, forse, l’emergere di questa consapevolezza ha rappresentato una discontinuità rispetto all’ossessione per la competitività e alla promozione del modello di crescita guidato dalle esportazioni che sono state una costante del processo di integrazione europea (e della relativa retorica) negli ultimi decenni.
Soprattutto nella fase attuale, lo stesso modello export-led sembra poco adatto a funzionare in un contesto geo-economico-politico in cui lo stesso commercio internazionale è «militarizzato», con paesi che controllano materie prime, input intermedi e tecnologie chiave e sono pronti a esercitare il loro potere per decidere a chi destinare le loro produzioni. Pertanto, se il modello export-led è in crisi, gli elementi che sono alla base di questo modello − la moderazione salariale, la compressione della domanda interna e pubblica, l’assenza di incentivi alla diversificazione della produzione, gli elevati input intermedi importati – sono ancora giustificabili nel nuovo contesto globale? Probabilmente no, come converrebbero Aldo Barba e Massimo Pivetti. Inoltre, la crisi del modello export-led − che è soprattutto tedesco, ma che è anche stato il modello guida dell’UE − porterà a un arretramento del paese centrale e quindi a una convergenza verso il basso in Europa, o, in alternativa, aprirà alla possibilità di un’espansione del mercato interno nella stessa Europa? Questa seconda alternativa, accompagnata da un ribilanciamento della capacità produttiva tra i paesi europei, sarebbe sicuramente auspicabile. Sebbene il passaggio da una piattaforma manifatturiera pensata per l’esportazione (come quella tedesca) a una ripensata per il mercato interno rappresenti una sfida formidabile, questa trasformazione sarebbe vantaggiosa per la stessa Germania, considerando la contrazione dei margini di manovra per l’export tedesco emersa negli ultimi anni, sia a causa delle guerre commerciali inaugurate da Trump, sia per la fragilità delle catene del valore svelata dalla crisi pandemica e dalla guerra.
di Giuseppe Celi


