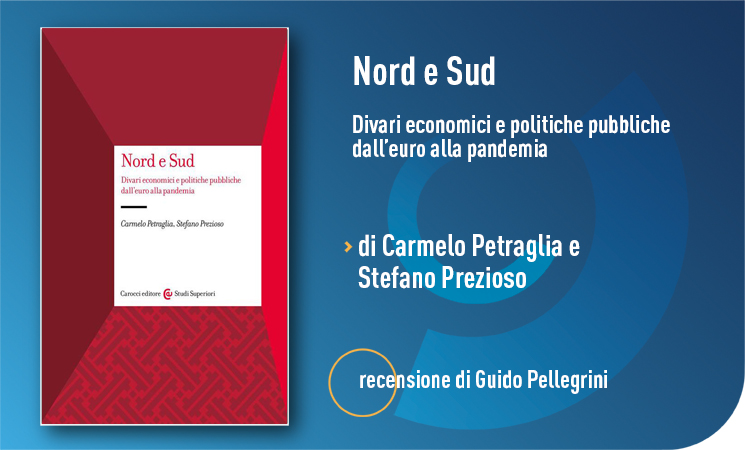
Spesso, presi dalle vicissitudini del presente, ci dimentichiamo quale sia stata l’origine dei problemi e le loro cause. Un caso esemplare di tale attitudine è l’analisi delle disuguaglianze economiche e sociali tra Nord e Sud, talvolta attribuite a differenze culturali, o di indole, e quindi irrimediabili. Lo stimolante lavoro di Carmelo Petraglia e Stefano Prezioso ci riporta invece a un’analisi storica solida del contesto di come questo divario si sia determinato e di come siano attribuibili le responsabilità. Il saggio parte da un momento storico decisivo (il dopoguerra) per concentrarsi sull’esito degli shocks prima della «lunga crisi» degli anni 2008-2014, e poi di quella del Covid-19, i cui impatti non sono stati neutrali sulle disuguaglianze geografiche nel Paese. Il lavoro si conclude con uno sguardo ai problemi dell’oggi: il conflitto russo-ucraino e l’attuazione del PNNR, con le implicazioni che comportano e che potranno determinare.
Il saggio ha un taglio interpretativo molto preciso: molte delle disuguaglianze sia economiche che sociali sono da attribuire all’azione di politiche pubbliche, che hanno complessivamente comportato effetti sfavorevoli per il Mezzogiorno. Questo è avvenuto sia per scelte deliberate, oppure come conseguenze secondarie di azioni intraprese a livello nazionale, che hanno riguardato interventi legislativi e istituzionali. Anche le possibili soluzioni vengono rintracciate in un intervento pubblico «intelligente» che può partire dalle azioni previste nel PNNR.
Il ruolo della politica pubblica ha contrassegnato, secondo gli Autori, le fasi principali del percorso economico del Mezzogiorno dal dopoguerra. In primo luogo, la «grande trasformazione», ovvero la forte riduzione dei divari economici e sociali registrata fino agli anni Settanta viene attribuita al big push, ovvero ai massicci investimenti pubblici che hanno sostenuto lo sviluppo e la modernizzazione delle regioni meridionali. Questo avvenne con una guida centralizzata, data dalle azioni della Cassa del Mezzogiorno, che specie nel primo decennio di intervento ebbe un ruolo essenziale nella guida dell’intervento pubblico e nell’uso delle risorse. La reazione agli shocks degli anni ’70 e ’80 si accompagnò ad un atteggiamento più difensivo delle politiche, con interventi basati sui sussidi e sull’incentivazione della domanda, che però non aiutarono l’adeguamento del sistema produttivo e quindi spinsero l’area a porsi in concorrenza con i sistemi industriali meno sviluppati, basati sul basso costo della manodopera. Inoltre, la questione «settentrionale» prendeva il posto di quella «meridionale», con una accentuazione del ruolo delle Regioni e una minore attenzione delle politiche alla riduzione dei divari territoriali.
Anche a fronte dei due shocks di inizio secolo dovuti ad eventi esogeni, come l’introduzione dell’euro e il pieno affermarsi della globalizzazione, con l’entrata prepotente della Cina sui mercati internazionali, che hanno sfavorito in misura maggiore le industrie meridionali rispetto al resto del Paese, le politiche economiche (oltre che le scelte imprenditoriali) si sono rivelate inadeguate a ridurre il gap tra Nord e Sud. Gli Autori sottolineano tre aspetti: l’orientamento restrittivo della politica monetaria, a seguito dei vincoli imposti dalla moneta unica, che portò a una diminuzione delle risorse specialmente per gli investimenti, quindi riducendo in particolare le risorse per il Sud; il ruolo della
politica di coesione europea, non aggiuntivo ma sostitutivo di risorse nazionali, e le cui risorse non avrebbero potuto comunque, da solo, ridurre il gap territoriale; il fallimento della Nuova programmazione, una politica che si poneva in discontinuità con quelle degli anni passati, e che puntava ad uno sviluppo endogeno dal basso. Gli Autori attribuiscono il fallimento di tale politica sia alle eccessive suggestioni localistiche, che hanno sopravvalutato i segnali di dinamiche positive di piccole imprese e di alcuni distretti industriali meridionali, sia all’inefficienza gestionale e amministrativa delle istituzioni locali coinvolte, a fronte di una frammentazione degli interventi, inevitabile quando il processo decisionale avviene a un livello eccessivamente decentrato.
Negli ultimi quindici anni l’Italia è stata colpita da due crisi, anch’esse esogene ma di diversa tipologia: la cosiddetta «lunga crisi», figlia della crisi dei mercati finanziaria nata negli Stati Uniti, ma poi diffusasi in tutta Europa, sebbene con diverse gradazioni; la pandemia, che ha causato la più grave recessione dalla fine della Seconda guerra mondiale. Anche in questo caso gli Autori sottolineano il ruolo delle politiche nei processi di aggiustamento, con effetti anche perversi sulla crescita e le disuguaglianze regionali. Nella prima crisi le politiche di austerità e risanamento dei conti pubblici hanno colpito maggiormente il Mezzogiorno, più dipendente dalle politiche pubbliche. In particolare, hanno decisamente influito la riduzione dell’impiego pubblico e soprattutto la contrazione degli investimenti pubblici, che avevano un peso relativo molto più importante al Sud che nel resto d’Italia. Gli Autori segnalano come gli effetti sulle disuguaglianze regionali siano stati molteplici, dall’occupazione ai salari, dalla povertà assoluta all’accesso ai diritti di cittadinanza. Per quest’ultimi, gli Autori sottolineano il pericolo di un forte inasprimento delle disuguaglianze, a seguito di quello che chiamano «il regionalismo all’italiana», legato alla riforma del Titolo V della Costituzione fino al progetto di autonomia differenziata recentemente all’attenzione del Governo.
Nella crisi pandemica le differenze sono state meno marcate, anche perché la pandemia è iniziata in alcune regioni del Centro-Nord. Nel complesso, la pandemia non ha di per sé acuito i divari regionali, sia per la rimozione dei vincoli di bilancio che hanno permesso una azione pubblica più intensa al Sud, sia perché le politiche hanno favorito i settori delle costruzioni e dei servizi che sono tradizionalmente importanti nell’economia meridionale. Il calo del PIL è stato piuttosto omogeneo nelle diverse aree territoriali, anche perché, a differenza della crisi precedente, vi è stato un intervento massiccio a sostegno da parte della spesa pubblica, cresciuta per finanziare gli aiuti al settore sanitario, alle famiglie e alle imprese in difficoltà.
Leggendo trasversalmente il saggio, non si può non concordare con gli Autori sul ruolo decisivo, se non determinante, della politica nella mancata riduzione dei divari territoriali. L’impatto descritto nel libro assume a mio parere tre direzioni, che è utile evidenziare esplicitamente.
In primo luogo, vi è l’impatto diretto derivante dall’ammontare di risorse destinato alla crescita differenziale dell’area e quindi alla chiusura del gap. Questo contributo è diminuito nel tempo, coinvolgendo sia i fondi nazionali che comunitari. Un dato, riportato dagli Autori, riguarda il dimezzamento della spesa in conto capitale per il Sud, che è passata da 21,9 miliardi di euro a prezzi costanti nel triennio 2007-2009 a 11,3 miliardi di euro nel triennio 2017-2019. La necessità di risorse è importante per migliorare la qualità del tessuto produttivo meridionale e attrarre nuove iniziative, specie nei settori più innovativi. Per colmare almeno parzialmente le distanze con i sistemi industriali del Nord e dei concorrenti europei serve un ampio rinnovamento della base produttiva, come segnalano gli Autori. Aggiungo che abbiamo visto qualcosa di simile già ai tempi della legge 488/1996, che ha permesso un aggiornamento tecnologico dell’apparato industriale meridionale, consentendogli all’epoca di rimanere in qualche modo agganciato al resto del Paese. È stato quello un esempio di un utilizzo massiccio ma efficace di risorse, che dovrebbe essere preso ad esempio (tra i tanti studi si permetta un rimando a A. Cerqua e G. Pellegrini, Do subsidies to private capital boost firms’ growth? A multiple regression discontinuity design approach, «Journal of Public Economics», 2014, vol. 109, issue C, pages 114-126, e alla bibliografia ivi citata).
In secondo luogo, vi è l’impatto territoriale di politiche nazionali. Qui ci si riferisce soprattutto all’offerta di servizi pubblici, soprattutto sanità e istruzione, ma anche acqua, gas, elettricità, che appare relativamente deficitaria al Sud. Questo è un aspetto particolarmente importante, tale da essere sottolineato più volte in letteratura (anche in questo caso si permetta un rimando a L. Cannari, M. Magnani e G. Pellegrini, Critica della ragione meridionale. Il Sud e le politiche pubbliche, Libri del Tempo, Bari, Laterza, 2010, p. 144). La semplice prosecuzione della spesa storica da sola non può bastare a richiudere il gap. Questi divari influenzano nel medio-lungo periodo non solo il benessere dei cittadini ma anche l’attrattività e la competitività del sistema economico. Il tema è di particolare attualità, in quanto la proposta Calderoli di aumentare le competenze regionali, e di trattenere le risorse a questo scopo, sotto la dizione di autonomia fiscale o tributaria, aumenta, e non riduce tali disuguaglianze. Non entro nel dibattito esteso e complesso legato ai LEP e ai Fondi di solidarietà. Sono d’accordo con gli Autori che in mancanza di una adeguata compensazione, il che allo stato attuale non appare politicamente proponibile, l’autonomia differenziata non è che una fonte «politica» di aumento dei divari.
Il terzo aspetto, ma non il meno importante, riguarda il ruolo della politica nei suoi assetti istituzionali. Mi spiego meglio. Un assetto istituzionale fortemente decentrato si basa sulla capacità amministrativa e di governo degli Enti locali. Ma se questa è fortemente diversificata territorialmente, per motivi storici ma anche per una differente dotazione di risorse, il risultato è un ampliamento delle differenze. Questo aspetto è sempre stato presente sin dalla formazione delle Regioni, e ha penalizzato in particolare le regioni del Mezzogiorno dove esiste una debolezza amministrativa, che spesso porta a tempi più lunghi e a una minore efficienza nell’utilizzo delle risorse. Non è un caso, a mio parere, che quando l’intervento pubblico è stato fortemente centralizzato, come nel primo decennio di operatività della Cassa del Mezzogiorno, le regioni del Sud hanno recuperato parte del divario legato agli investimenti pubblici.
Quali sono le prospettive future? Il saggio termina con il periodo della pandemia e la sua risposta politica, ovvero il Next Generation EU, che rappresenta lo sforzo intrapreso dall’Unione europea per la ripresa dopo la crisi, accompagnato dalla concessione di una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse finanziarie. Il più importante strumento del Next Generation EU è il PNRR, che nella versione italiana si traduce in un vasto programma di riforme e investimenti, che, come sottolineano gli Autori, restituisce centralità alla coesione economica, sociale e territoriale, mirando, come prescrive il trattato comunitario, a ridurre il divario di sviluppo tra le regioni meno favorite e il resto d’Europa.
Il PNRR agisce in tutte le tre direzioni indicate precedentemente. In primo luogo, incrementa, almeno sulla carta, le risorse a disposizione del Mezzogiorno, specie con l’impegno a destinare almeno il 40% delle risorse «territorializzabili» alle Regioni meridionali. D’altronde questo impegno non sarà facilmente rispettabile, come segnalano con un’analisi anche minuziosa gli Autori. In secondo luogo, il PNRR interviene anche nel campo dei servizi pubblici, come scuole, sistema sanitario, infrastrutture ed altro. Anche in questo caso gli Autori segnalano come il meccanismo di allocazione delle risorse sia di tipo competitivo fra gli enti territoriali, il che non favorisce certo gli enti del Sud, meno attrezzati a competere, mentre d’altro canto sarebbero quelli con maggiori necessità di sostegno. In questo quadro si inseriscono le riforme della Pubblica Amministrazione, orientate a favorire il ricambio generazionale degli organici e rendere più efficiente l’offerta di servizi pubblici. È questo un aspetto di cui le Regioni del Mezzogiorno potranno particolarmente giovarsi.
Infine, il PNRR per molti versi favorisce e contempla una certa centralizzazione delle decisioni, sia nel processo decisionale già avvenuto degli obiettivi, sia nelle modalità istituzionali di attuazione. Un esempio, a questo riguardo, è inserito nel decreto-legge n. 124/2023 che istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, ovvero una «ZES unica», che comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone Economiche Speciali, ora frammentate in 8 diverse strutture amministrative. Questo schema per molti versi ripropone la presenza di una «fiscalità di vantaggio» in tutto il Sud, con varie facilitazioni e semplificazioni. Certo, si perde la focalizzazione delle precedenti ZES soprattutto sul sistema portuale e infrastrutturale, sebbene con una sensibile eterogeneità nei comportamenti e nei risultati. Può essere per molti versi un’opportunità, sempre che le strutture dedicate delle Amministrazioni centrali riescano a gestire l’intero carico amministrativo e autorizzativo, e che vi sia una omogeneità e coerenza nelle linee di politica industriale e infrastrutturale, interagendo in modo coeso anche con l’azione dei Fondi strutturali e le altre tipologie di intervento sul territorio.
Gli Autori concludono il saggio chiedendosi come tornare a crescere, Mezzogiorno e Italia, riducendo le disuguaglianze. È una domanda complessa, a cui non esiste una risposta univoca e certa. Coerentemente con la loro visione, gli Autori suggeriscono come sia necessaria, sebbene non sufficiente, una «buona politica». Questo significa sfruttare pienamente e in modo efficiente le risorse del PNRR, soprattutto nelle sue finalità di riequilibrio territoriale; significa portare in porto la riforma della Pubblica amministrazione, rendendola più competente e motivata; significa rendere effettivamente aggiuntive e non sostitutive le risorse del PNRR e dei Fondi strutturali, in modo che le politiche nazionali lavorino e si integrino con quelle europee; significa avere delle priorità di politica industriale chiare e definite per il Mezzogiorno, per superare la debolezza del sistema produttivo meridionale, dove sono diffuse le specializzazioni in settori a bassa produttività e bassa innovazione. Una «buona politica», come suggeriscono gli Autori, che riguardi anche l’ambito europeo, evitando asimmetrie tra paesi e regioni e negoziando un ammorbidimento della austerità finanziaria.
Non si può che essere d’accordo con gli Autori che questo sia un canale, se non il principale, per favorire la crescita e ridurre le disuguaglianze. A questo si devono associare necessariamente una tensione collettiva, una consapevolezza di un impegno che passi per un miglioramento dei comportamenti in campo economico e sociale, un riconoscimento delle proprie potenzialità, e una concordia negli obiettivi da raggiungere.
Riprendendo quanto suggerito all’inizio di questo commento, l’ottimo lavoro di Carmelo Petraglia e Stefano Prezioso ci sollecita a ripensare l’origine dei problemi, il loro sviluppo storico e ci porta a comprendere come il nostro futuro dipenda da come agiamo, e in particolare dalle scelte politiche che compiamo, ora. È una visione ottimistica, perché ci ricorda che la crescita e la contemporanea riduzione delle disuguaglianze sono ancora nelle nostre possibilità.
di Guido Pellegrini


