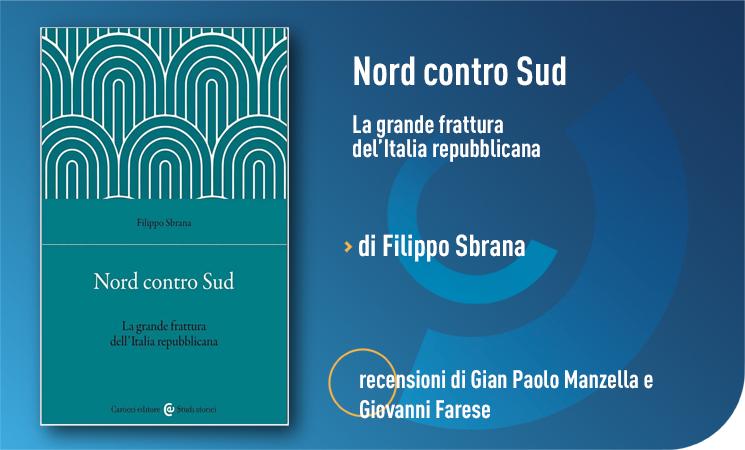
Nel 1972 migliaia di operai, provenienti da ogni parte del Paese, attraversarono l’Italia per partecipare a Reggio Calabria a una grande manifestazione per il Mezzo- giorno indetta dai sindacati. Parte da qui – da questo momento di ideale unità – questo libro di Filippo Sbrana, professore associato di Storia economica nell’Università per Stranieri di Perugia. Il volume è un importante contributo alla storia dell’Italia repubblicana, dalla nascita della Repubblica fino ai giorni nostri, con particolare riguardo al quarto di secolo compreso tra il 1968 e il 1992. Non è solo un libro di storia economica, ma anche di storia culturale, politica e sociale, dunque di storia tout court. È un libro che arricchisce non poco la storiografia nazionale.
Le novità principali sono almeno tre. Primo: il libro tiene insieme la “questione meridionale” e la “questione settentrionale”, spesso oggetto di analisi e ricerche separate, leggendole congiuntamente, “sia perché si influenzano vicendevolmente, sia perché gli avvenimenti dell’una aiutano a comprendere meglio quelli dell’altra” (p. 17). È una lettura binaria (di due “parti”), che diventa olistica nella considerazione di un “tutto” che è il Paese, la cui tenuta unitaria è infatti al centro delle preoccupazioni civili dell’Autore.
Secondo: al centro della interpretazione e ricostruzione non stanno tanto il divario e le politiche adottate per ridurlo, quanto la categoria di “consenso”, senza il quale “è molto difficile che possano essere attuate politiche economiche durature e rilevanti” (p. 17). È una scelta di grande interesse, oltre che di forte originalità. Del resto, già nel 2007 Sabino Cassese ha scritto che l’analisi della costituzione economica non deve limitarsi alle norme costituzionali e alle leggi – e lo stesso può dirsi per l’analisi delle strutture economiche –, ma deve comprendere “l’analisi dei mutamenti dell’opinione pubblica” (S. Cassese, a cura di, La nuova costituzione economica, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 4), come suggerito con l’idea di legislative public opinion dal giurista britanni- co Albert Dicey a fine Ottocento. Non a caso l’Autore ricorre, oltre che al vocabolo “consenso”, anche a vocaboli come “aspettative”, “attenzione”, “fiducia” (o crisi di), “imbarazzo”, “linguaggio”, “mentalità” (o cambio di), “noia”, “simbolo”, “segno”. E questo – è bene ribadirlo – senza che venga meno un solido impianto storico-economico, attento agli andamenti di fondo dell’economia, anche nei suoi legami e vincoli internazionali, oltre che ai cambiamenti nella struttura dell’economia italiana.
Terzo: lo scavo e l’impiego delle fonti, in particolare di quelle sindacali raccolte negli archivi storici della CISL, della CGIL e della UIL – soprattutto per gli anni Settanta e Ottanta, decenni che configurano un passaggio d’epoca tra il regime economico postbellico e quello attuale. Si tratta di una tipologia di fonti di grande interesse, spesso fatte oggetto di ricostruzioni parziali o settoriali, e che invece in questo libro vengono immesse nel solco di una storia più ampia. A queste e altre fonti primarie (per esempio quelle della Democrazia Cristiana e della SVIMEZ), l’Autore affianca un’attenta lettura dei quotidiani (“Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La Stampa”) e dei periodici e delle riviste (“Mondo economico”, “Nord e Sud”), tutte fonti atte a restituire, oltre che dettagli e notizie, lo stato e i mutamenti del consenso. Infine, sempre a proposito di fon- ti, Sbrana fa anche riferimento ai diari di alcune personalità, come Antonio Maccanico e Mariano Rumor, di volta in volta per misurare l’assenza (in negativo) o la presenza (in positivo) di certi interessi, preoccupazioni, temi. Ne risulta un impasto particolarmente efficace e sintetico.
Il libro è organizzato in cinque ampi capitoli ordinatamente diacronici, preceduti da una breve introduzione, ed è corredato dall’indispensabile e utilissimo Indice dei nomi, in cui spicca tra gli altri il nome di Pasquale Saraceno, la cui esperienza e il cui pensiero costituiscono, nel loro svolgimento, uno dei fili rossi della ricostruzione di Sbrana, assieme alla postura assunta via via nel tempo dalla SVIMEZ, di cui Saraceno fu anima oltre che animatore. Del resto, la SVIMEZ è stata nel dopoguerra – ed è anco- ra oggi – un attore di primaria importanza nella formazione di un consenso o comunque di un discorso pubblico sul Mezzogiorno e sul suo posto nel Paese, che, come detto, sta al centro del volume. L’opera è piena di notizie e di scoperte storiografiche, anche nelle ricche note, che hanno sia carattere di approfondimento biografico e tematico sia biblio- grafico, con ampi riferimenti alla letteratura consolidata e a quella più recente sul tema.
Nel primo capitolo (Il Mezzogiorno “questione nazionale”) si dà conto della centralità assunta dalla questione meridionale nei “trent’anni gloriosi” tra la fine della guerra e la crisi del 1973, con il Mezzogiorno al centro del terreno di scontro politico (basti ricordare lo Schema Vanoni e la Nota La Malfa). Nel 1950 nasce la Cassa per il Mezzogiorno, a cui farà da complemento la legge n. 647 del 1950 per opere al Centro e al Nord, e si afferma per un periodo non breve la visione di Saraceno secondo cui le due parti del Paese dovevano essere ricondotte a una sostanziale unità. Nello stesso capitolo Sbrana ricostruisce anche i primi passi del Movimento per l’Autonomia Regionale Piemontese (MARP; alle politiche del 1958 la “P” starà per “Padana”), fondato nel 1955, a favore dell’autonomia regionale e ostile alle grandi migrazioni interne del tempo (le migrazioni interne e internazionali, e i loro effetti economici e sociali, ieri e oggi, sono peraltro spesso richiamate nel volume). Il capitolo si chiude con una riaffermazione della sostanziale tenuta dell’idea unitaria del Paese ancora all’inizio degli anni Settanta, ricordando, da una parte, l’impegno meridionalista contenuto in vari statuti regionali anzitutto nel Nord, a cominciare dal Piemonte (in quegli anni il primo presidente della Regione Lombardia, Piero Bassetti, dirà che lo sviluppo del Mezzogiorno è un “preciso interesse dei lombardi”, p. 40); dall’altra, ricordando la spinta dei sindacati per battaglie nazionali, capaci di unificare e unire, dando al Paese una moderna attrezzatura civile e superando il ristagno della produzione. Luciano Lama parlerà di “coscienza avanzata”, di coscienza di un comune destino, di rischio del moltiplicarsi delle isole (pp. 50-51). Uno sforzo unitario, dunque, condensato nello slogan “Nord e Sud uniti nella lotta”, for- te tanto quanto la consapevolezza del rischio di una divergenza che non avrebbe tardato a emergere.
Nel secondo capitolo (“Crisi economica e difficoltà dell’intervento straordinario”) l’Autore si concentra sulla crisi degli anni Settanta e sulla fine del ciclo espansivo postbellico, che ha tre conseguenze: genera una forte recessione nel Nord; contribuisce all’incepparsi dell’intervento straordinario; mette in ginocchio l’industria fordista. Ne deriva una minore attenzione per il Mezzogiorno. Cambia l’idea di fiducia e di speranza degli anni precedenti. Vi era la necessità non più di espandere la capacità produttiva, ma l’efficienza, in una fase in cui il deterioramento dell’efficienza gestionale nelle partecipazioni pubbliche si manifestava palesemente. La ristrutturazione che ne seguì distolse attenzione (e fondi) dal Mezzogiorno, come nel caso della legge n. 675 del 1977, le cui risorse andarono per l’85% alle imprese settentrionali (p. 59). Fu una fase di crisi esistenziale, oltre che di difficoltà finanziaria, per la SVIMEZ, come emerge dai verbali del consiglio di amministrazione e dalla corrispondenza di Saraceno (tra gli altri con Gino Martinoli, col quale sarebbe occorso più avanti un significativo scambio, riportato da Sbrana, sulla centralità o meno della piena occupazione per la politica economica, che Saraceno riprendeva quasi letteralmente da Keynes, p. 135). La SVIMEZ, che nei primi anni non aveva goduto di contributi statali, si trovava ora a dover contare perlopiù su di loro, con una quota di fondi privati che nel 1976 era scesa al 23% (p. 65) e che con l’uscita nei primi anni Ottanta di soci fortemente simbolici come Comit, Credit, ENI, Fiat, Finsider, sarebbe scesa sotto il 10% per cento. Era un segno dei tempi. Faceva eccezione in questo desolante quadro la Mediobanca di Enrico Cuccia, che Saraceno nel 1981 ringraziava, riconoscendo in lui “immutato il Cuccia degli anni Trenta che ho conosciuto nel lavoro comune del primo IRI”, p. 66, nota 44). Crepe, del resto, si avverti- vano anche nel sindacato, “la cui scelta per il Sud rimase confinata in parole d’ordine” (p. 70). La crisi mordeva, e Fausto Bertinotti, allora segretario regionale della CGIL Piemonte, parlava di uno “scasso” che produceva un processo di interiorizzazione che portava le aree del Nord a concentrarsi su di sé. Ne seguiva divisione, scarsa partecipa- zione e stanchezza nel mondo operaio. La crisi distolse non solo fondi ma anche “fiducia” nell’intervento straordinario e nel Mezzogiorno, tanto che nel 1978 Saraceno registrava “il risorgere di controversie che credevamo spente per sempre” (p. 79). Incideva-
no anche due altri fattori internazionali e istituzionali. Il primo: già da un quindicennio circa, dal 1965, la Banca mondiale aveva interrotto il proprio finanziamento al Mezzo- giorno, che significava anche controllo sulla gestione dei prestiti, sulla base dell’argomentazione per cui l’Italia era oramai paese “market eligible”; il secondo, l’allargamento della Comunità Economica Europea, con l’ingresso di paesi segnati da divari e dualismi come l’Irlanda e il Regno Unito. Anche questo distoglieva attenzione, oltre che fondi, dal Mezzogiorno, che nel dopoguerra era stato un caso di policy e di studio per le istituzioni finanziarie europee (BEI) e internazionali (Banca mondiale).
Nel terzo capitolo (“Le regioni e le trasformazioni degli anni Ottanta”) si parte dalla costituzione delle regioni e dalle speranze, ma anche dall’intuizione di alcuni rischi, intravisti per esempio da Rumor, che scriveva del pericolo di “organi locali auto- nomi e autarchici con piena indipendenza a guisa di satrapia e di clan” (p. 88); da Franco Mattei che paventava un aggravamento degli squilibri, o da Vittorio Ciampi, che temeva soprattutto il riprodursi fatale dei “mali della partitocrazia” (p. 90). L’istituzione delle Regioni finì per avere “conseguenze assai negative” (p. 91). A lungo rimase solo una grande confusione, che peraltro si proietta fino ai giorni nostri, al netto di non pochi interventi, a partire dalla legge 142 del 1990. Si finì per “aggiungere al sistema politico italiano una nuova stratificazione nella distribuzione della spesa pubblica” (p. 95), ma con rendimenti assai differenziati tra le Regioni. Appoggiandosi a Putnam, l’Autore ricorda che l’efficienza delle regioni ricalcava i livelli di sviluppo acquisiti in passato e, a sua volta, condizionava quelli raggiungibili in futuro. Iniziava a emergere una contrapposizione tra regioni del Nord e regioni del Sud, lungo tutto lo spettro politico, tanto che si parlava di “alleanza delle regioni ricche” (p. 100). Dieci anni di crisi, all’incirca, ave- vano spazzato via, in un tempo relativamente breve, la memoria dello sviluppo postbellico. Si manifestava forse anche un fenomeno generazionale: nel 1963 avevano compiuto 18 anni i nati nel 1945; nel 1981 i nati nel 1963. Vi era anche una forte perdita di efficienza della Cassa per il Mezzogiorno. Le regioni subentrarono alla Cassa in diverse materie e furono cooptate nel suo Consiglio di amministrazione, con una pluralità di interessi e voci che era esattamente ciò che la costituzione di un ente unitario aveva, su consiglio degli americani fatto proprio dagli italiani, inteso fare. Nel 1984, dopo una fa- se difficile, la Cassa fu sciolta. Nella nota 51, a p. 102, Sbrana cita Guido Pescosolido, il quale ha di recente ricordato che le regioni fallirono prima nel rapporto con la Cassa, poi nella gestione dei fondi europei; viene fatto di chiedersi che cosa sarebbe stato possibile fare, se vi fosse stata la Cassa di un tempo e la classe dirigente che, alla Cassa e alla Banca mondiale, ne aveva segnato la fase eroica; ma una domanda siffatta dovrebbe comunque tener conto dei cambiamenti intervenuti nell’economia mondiale. Emergeva- no infatti nuove tendenze di fondo, una delle principali delle quali era la “terziarizzazione” (nel 1983, la quota dei servizi sul PIL, 47,5%, supera quella dell’industria, 45,8%, p. 108), che segnava la fine dell’ambiente di fabbrica, con tutto ciò che esso
aveva rappresentato, in senso materiale e simbolico, aprendo la via al “dispiegarsi di un individualismo competitivo essenzialmente antisociale” (p. 110). L’insicurezza della classe operaia dettava la fine della speranza e l’emergere di una “paura operaia” con il timore di perdere quanto acquisito, che, a sua volta, generava un senso di estraneità, se non di fastidio, per il Mezzogiorno. Iniziava la stagione del “riflusso” (già nel 1978 il Censis aveva messo l’accento sull’individualismo, p. 111, nota 84). Nel 1981 il X Con- gresso della CGIL segnava in questo senso un ripiegamento rispetto all’impegno per il Sud.
Nel quarto capitolo (“Dalla freddezza alla contrapposizione”) l’Autore si sofferma dapprima sull’indebolimento delle forze unificanti (Chiesa, partiti, sindacati), tutte investite, per ragioni diverse e in parte sovrapposte, da una crisi della partecipazione. Finiscono anche le migrazioni interne, che avevano imposto al Nord una riflessione sul- la necessità di sviluppo del Mezzogiorno. Il dibattito intorno alle politiche per il Mezzogiorno si articola, sin da allora, su due tronconi separati: uno è complesso, fatto di distinguo tra una prima e una seconda fase, tiene in conto vari fattori, ma resta chiuso nei circuiti intellettuali e nelle riviste; l’altro è liquidatorio e semplificatorio e consiste in una condanna senza appello dell’intera esperienza dell’intervento straordinario. A Sara- ceno, che lamentava il disinteresse generale verso il Mezzogiorno, Antonio Maccanico, segretario generale della Presidenza della Repubblica, rispondeva (dolendosene) che “se far valere le ragioni del Mezzogiorno in periodi di crescita e di espansione è difficile, in periodi di rallentamento e di recessione è veramente una impresa sovraumana” (pp. 134- 135). I bisogni e le ragioni del Nord venivano sempre più spesso contrapposti a quelli del Mezzogiorno, anche a causa dell’apparire delle “leghe”: la Liga Veneta, la Lega Lombarda, la Lega Nord (a proposito della quale c’è un interessante spunto sul ruolo svolto dai Gastarbeiter italiani “di ritorno”, p. 159, nota 109). Arretrano in quegli anni in aree tradizionalmente bianche e rosse sia la DC sia il PCI, così come arretra l’industria. Sbrana nota che lì dove la grande industria reggeva alle trasformazioni, teneva meglio anche l’idea di unità del paese, come in Piemonte, diversamente dal Veneto che era trainato dalle piccole e medie imprese.
Nel quinto capitolo (“Seconda Repubblica e centralità della questione settentrionale”), dopo una disamina della presenza del Mezzogiorno nei discorsi di fine anno dei presidenti della Repubblica Leone (che parlava di un “irrisolto problema nazionale”), Pertini (specie dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980), Cossiga (che ribadiva come alla questione meridionale fosse legato il destino del Paese), il libro dedica pagine documentate e intense al terremoto dell’Irpinia. Se, da una parte, la tragedia costituì un momento di genuina “scoperta” del Sud e di sentita solidarietà, dall’altra l’allargamento dell’area degli interventi (che coinvolse alla fine ben 687 comuni, “alcuni dei quali distanti oltre 200 chilometri dall’epicentro”, p. 184), la corruzione e gli sprechi non fecero altro che alimentare ulteriori moti di diffidenza, disprezzo, distacco dal Mezzogiorno. Con la legge n. 64 del 1986 nasceva Agensud, un organismo di tipo erogatorio che lasciava alle Regioni l’attività di programmazione: “si spendeva molto, ma lo si faceva male” (p. 178), in un contesto in cui il debito pubblico cresceva dal 60% del 1980 fino e oltre il 100% intorno al 1990. Ancora una volta Saraceno, che sarebbe scomparso nel 1991, faceva sentire la sua voce nel Rapporto SVIMEZ per l’anno 1990 denunciando un “blocco sociale” che legava imprese, politica e società in una dinamica perversa che occorreva spezzare. La Lega Nord saldò, specie dopo il 1987, la critica all’aiuto pubblico, la denuncia della crisi dei partiti, la polemica contro lo Stato centrale. Il confronto tra la ricostruzione in Campania e in Friuli dopo gli eventi sismici che avevano colpito queste regioni divenne paradigmatico e proverbiale di un paese diviso in due. L’Italia era sempre più divisa anche sul piano politico: alle elezioni politiche del 1992 la DC e il PSI rimanevano forti nel Mezzogiorno, mentre la Lega cresceva nel Nord (8,6% a livello nazionale con 55 deputati e 25 senatori eletti, p. 202). La “questione settentrionale” aveva ora il suo posto, oltre che nella società, anche nel Parlamento e nelle istituzioni del paese. Nel 1992 il governo fissava con decreto la cessazione dell’intervento straordinario, sostituito con un nuovo sistema di agevolazioni esteso a tutto il territorio, che “nella sostanza cancellava la questione meridionale” (p. 205). L’alleanza tra Forza Italia di Silvio Berlusconi e la Lega Nord di Umberto Bossi – e in generale l’incardinamento nelle coalizioni di centro-destra, e non solo quelle, delle ragioni esclusiviste della “questione settentrionale” – segnerà i successivi trenta anni, fino ai giorni nostri, fino alla cosiddetta “autonomia differenziata”. Si affermavano parole come “federalismo”, mentre il centro-sinistra non riusciva complessivamente a prendere una iniziativa per il Mezzogiorno, salvo qualche eccezione. Il risultato fu un acuirsi dei divari, specie dell’occupazione, sull’onda lunga della Grande recessione, non ancora pienamente superata dall’Italia al momento dello scoppio della pandemia nel 2020. Dal 2001 a oggi, oltre un milione di persone ha lasciato il Mezzogiorno (p. 224), sia pure un Mezzogiorno oggi molto più avanzato e diversificato di quello uscito dalla Seconda guerra mondiale.
Questo libro, che così bene traccia gli scricchiolii e le svolte, ricorda tra le altre cose quanto sia difficile comprendere gli eventi mentre essi si svolgono come trasfor- mazioni silenziose, se su di essi non si esercita il pensiero critico e storico. Grazie a esso il libro individua tre nessi. Il primo è la sovrapposizione tra il passaggio dalla cosiddetta prima repubblica alla cosiddetta seconda repubblica con la transizione dalla dominanza della questione meridionale a quella della questione settentrionale. In questo senso, la “grande frattura” del titolo non è solo geografica ed economica, ma anche politica e temporale, giacché l’occorrenza della grande frattura (che in realtà è una successione di microfratture intercorse nel quarto di secolo a cui si faceva riferimento in apertura, quel- lo che va dal 1968 al 1992) consente di distinguere due fasi politico-sociali, e perfino esistenziali, del paese. Il secondo nesso, che l’Autore riprende da Paolo Frascani, è quello tra crisi economiche e crisi politiche o, meglio, l’incidenza nella storia d’Italia
delle crisi economiche sul tessuto politico e sociale e il loro riverberarsi con un lag temporale anche ampio: un aspetto non sempre adeguatamente valorizzato nella storiografia. Il terzo consiste nell’individuazione di una relazione tra industrializzazione e questione meridionale e tra de-industrializzazione e questione settentrionale, in cui si inserisce anche una finale riflessione sul populismo (pp. 227-228). Sono tre nessi evidente- mente collegati e che si influenzano a vicenda, anche se il terzo, per il suo impatto eco- nomico e sociale sul piano collettivo e individuale ci appare il più forte e duraturo. Sono in ogni caso tre nessi preziosi per la storiografia.
Il libro di Filippo Sbrana è, in definitiva, un importante contributo per chiunque voglia capire i problemi dell’Italia di oggi (“i divari si sono ampliati ed appare chiara non solo l’esistenza di una questione meridionale, ma anche di una più complessiva questione nazionale”, p. 235) ed eventualmente agire con cognizione di causa e profondità storica (“si sconta la dimenticanza del passato, che ha inciso anche sulla cultura del nostro paese”, p. 234). Profetiche restano le parole di Saraceno nel Rapporto SVIMEZ per il 1990: “Ritornare ad una politica per il Mezzogiorno ispirata allo sviluppo e non all’assistenza, ad una visione strategica di medio lungo periodo e non soltanto alla risposta precipitosa ai bisogni emergenti, alla netta separazione anziché alla confusione tra potere politico e responsabilità gestionale, significherebbe battere il blocco sociale di cui si è detto” (pp. 225-206). Profetiche anche nel condizionale che, insieme al dubbio, che non possiamo non coltivare nel contesto diviso e oppositivo dei giorni nostri, ci invita anche a non abbandonare l’impegno ad alimentare un dibattito pubblico adeguato ai problemi dell’Italia di oggi.
di Giovanni Farese


