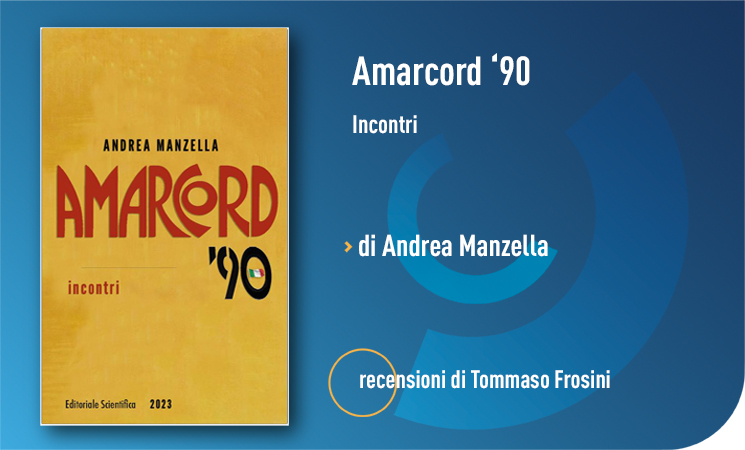
Nostalgia canaglia. Per quel mondo di ieri, che si manifestava – attraverso i suoi protagonisti delle istituzioni – in un’Italia civile, che oggi stenta a riproporsi e chissà se mai ci riuscirà. A compiere questo viaggio “felliniano”, un amarcord fatto di ricordi e racconti, è un uomo che ha percorso un lungo e significativo itinerario istituzionale e politico. Andrea Manzella ha avuto tante vite professionali, difficilmente riassumibili in sintesi. Grand commis della Repubblica, si dice di lui. Questo francesismo individua un pezzo della sua storia: quello di funzionario parlamentare e consigliere di ministri e go- verni. Poi c’è il magistrato (ordinario e amministrativo), il professore universitario (di diritto parlamentare) e il parlamentare (europeo e nazionale), oltre a tanti incarichi di responsabilità, come quelli in campo sportivo.
Tante vite, tanti incontri. Alcuni di questi ora descritti, come dei cammei, in questo libriccino di piacevolissima lettura, che raccoglie una serie di articoli pubblicati dal 1965 a oggi. Per festeggiare nel modo più bello il novantesimo genetliaco dell’autore, appena compiuto.
C’è l’Italia civile, come si è detto. Apre la galleria dei ricordi Aldo Moro, del quale Manzella seguì le lezioni di filosofia del diritto all’Università di Bari. Ed è la filosofia del diritto di Moro che viene raccontata in poche pagine, tra morale e diritto. Dopo Mo- ro, Ugo La Malfa. Il leader repubblicano, che proprio nel governo Moro II si dimette da presidente della commissione bilancio della Camera, per protesta contro le leggine clientelari che svilivano il controllo parlamentare di quella commissione. Manzella- Ot- tomano (lo pseudonimo con il quale firmava gli articoli sulla rivista Nord e Sud) spiega e racconta i motivi di quella decisione. Quattordici anni dopo ci fu “il tentativo La Malfa” di formare un governo, sulla base dell’incarico esplorativo affidatogli da Pertini, che Manzella affisserà in un volumetto dedicato proprio a quel tentativo.
A seguire, ritratti e ricordi di: Costantino Mortati, fidem servavit; Beniamino Andreatta, con degli assai gustosi calambour sull’uomo e sulle vicende politiche. Sostiene Manzella: “sempre, almeno secondo gli altri, in sospetto fuori gioco. Ma sempre davanti a tutti”. Ancora, Giovanni Spadolini, “il primo della classe”, di cui Manzella fu consigliere e ispiratore anche del cd. “decalogo Spadolini” sulle riforme istituzionali. Poi Leopoldo Elia, il costituzionalista e parlamentare, che fu anche presidente della Corte costituzionale in un periodo in cui la Corte si fece “più vicina” al legislatore. Una rapida fotografia Manzella la scatta anche per Silvano Tosi, parlamentarista, nel ricordo del suo impegno per gli studi, i giovani, il Parlamento e aggiungerei l’attività di opinionista sui giornali. Anche quella su Ciriaco De Mita è un flash di quasi due pagine. Magari sarebbe stato interessante avere qualche informazione in più di chi, come Manzella, fu (il primo) segretario generale della presidenza del consiglio, quando De Mita divenne capo del governo. A Giovanni detto “Vanni” Sartori, invece, Manzella, dedica un articolo di divertente polemica sulla forma di governo. Che Sartori, nella sua prepotente dialettica, aveva immaginato a “due motori”: un governo che nasce parlamentare e può diventare presidenziale nel corso della stessa legislatura. Una bizzaria, sebbene elaborata dal grande politologo. Dopo Sartori, la galleria di ritratti si interrompe per lasciare spazio a un articolo dedicato a “il sindaco d’Italia”, ovvero alla legge del 1993 che ha previsto l’elezione diretta dei sindaci. Non so se questo articolo, collocato a metà libro, vuole es- sere una sorta di intervallo nella filiera degli incontri manzelliani, ma forse lo si sarebbe potuto escludere. Non per il tema, che è importante perché ha rappresentato una “rivoluzione costituzionale”, piuttosto per l’argomento che non è in linea con gli altri.
I ricordi e i ritratti riprendono, dopo una sosta, con Carlo Azeglio Ciampi, di cui Manzella fu amico e anche segretario generale a Palazzo Chigi. La definizione di Ciampi “il patriota dell’euro” è perfetta. All’Europa, anzi allo “scomputo” europeo è dedicato il successivo ritratto di Giorgio Ruffolo. Viene poi pubblicata la lettera indirizzata a Montanelli, e la sua risposta, sulla proposta di dedicare, a Bagnocavallo, una via a Leo Longanesi. Un Maestro, come accenna Montanelli nella sua epistola, “che ha contato molto, forse più di chiunque altro, nel campo della editoria, del giornalismo, della pittura, e anche della pubblicità di alto e originalissimo gusto”.
A questo punto, il libretto di Manzella si sofferma su Paolo Ungari. Dagli amici chiamato “Paolino” non per il suo fisico minuto, anzi era cicciottello, ma per quel viso bambinesco, con due occhioni celesti e un’aria sognante, che faceva tenerezza. Era un uomo distratto e un po’ bohemien, ma soprattutto geniale per quello che diceva, faceva e scriveva. Manzella ricorda un’opera unica nel suo genere: Profilo storico del diritto par- lamentare in Italia (1971). Unici e di assoluta importanza sono anche altri due libri di Ungari: Alfredo Rocco e l’ideologia giuridica del fascismo (1974) e Storia del diritto di famiglia in Italia (1974). Il libro su Rocco subì una spietata recensione critica, che venne accolta con “sorridente tolleranza” da Paolino. Il recensore però non si potè esimere dallo scrivere di Ungari e delle sue “eccezionali doti naturali di intelligenza e diremmo di genio”. Era proprio così.
Dopo Ungari, Manzella dedica un ricordo a un altro personaggio che faceva parte di quella schiera di intellettuali, come Ungari e molti altri, vicini al partito repubblicano di La Malfa prima e di Spadolini poi. È Antonio detto Tonino Maccanico. Davvero un grand commis de l’Etat. Che fu l’alter ego di Pertini alla presidenza della repubblica, poi ministro per le riforme istituzionali e anche lui, come Ugo La Malfa, protagonista di un tentativo di dare vita a un governo, dopo l’incarico di formarlo che gli venne attribuito e che invece fallì.
Il sedicesimo e ultimo ritratto è dedicato a Eugenio Scalfari. Testo ancora inedito, dove Manzella, all’epoca funzionario parlamentare, rievoca lo Scalfari deputato della Repubblica nella V legislatura, eletto nelle file del partito socialista. Prese molto sul se- rio il mandato parlamentare. Come disse il vecchio liberale Aldo Bozzi, riferendosi al parlamentare Scalfari: “è appena entrato e vuole fare tutto”. Fece molto, seppure il suo nome rimane scolpito nella storia del giornalismo italiano.
Chiude il libretto un’intervista all’autore. Qui, Manzella si concede un breve ritratto di sé stesso, che riassume le sue tante vite professionali: “ho sempre e solo cercato di migliorare, per quel che potevo, il meccanismo che mi era affidato, di guardare un po’ più in là della semplice ripetizione burocratica dei ‘precedenti’, di rimediare, nel mio assai modesto margine d’azione, a qualcuna di quelle istituzionali ‘fragilità’ di cui, una volta per sempre, aveva parlato Moro”.
di Tommaso Edoardo Frosini


