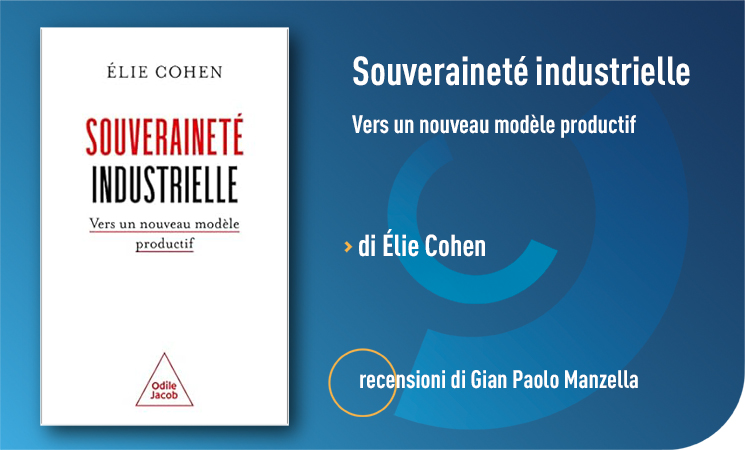
Profondo conoscitore della politica industriale francese – è lui ad aver coniato il termine “Colbertisme high-tech” per descriverne le evoluzioni degli anni Settanta – Elie Cohen torna sul tema. E decide di farlo in un momento molto specifico. La politica industriale, infatti, è di nuovo tra noi. La questione produttiva è tornata in auge dopo che si era illusi ci si potesse affidare alle sole dinamiche del commercio internazionale, alle reti di fornitura lunghissime che negli ultimi avevano avvolto l’economia globale e ne avevano ridisegnato i confini. E, di conseguenza, anche l’Europa ha progressivamente abbandonato la propria impostazione di politica industriale ‘orizzontale’ e neutra, ed ha cominciato a decidere su cosa scommettere per il futuro.
Ci sono, oramai, tecnologie chiare su cui focalizzare l’azione: basti pensare al deep-tech, alle biotecnologie e alle tecnologie verdi su cui si concentra l’attenzione del recente programma di finanziamento STEP; e, insieme, ci sono settori chiaramente individuati strategici per il domani industriali europei, le nostre ‘industries de l’avenir’: i semiconduttori, le materie prime critiche, le batterie elettriche, le produzioni legate alla transizione green.
È un passaggio che configura, secondo molti osservatori, una vittoria del ‘modello francese’ di politica industriale; ed anche per questo è di estremo interesse leggere il pamphlet di Cohen. Con lo sguardo di Parigi, ma con una visione che abbraccia anche le principali esperienze di politica industriale a livello globale, ripercorre, infatti, ragioni e dinamiche di questo cambiamento.
A spiegare questa recente evoluzione europea ci sono diversi fattori: la preoccupazione per il ritardo dalla ‘frontiera tecnologica’; la progressiva consapevolezza di di- pendenze strategiche sempre più evidenti; un assetto geo-economico in cui la Cina gio- ca oramai un ruolo fondamentale, anche grazie ad una precisa ed ‘aggressiva’ articola- zione dei rapporti tra Stato ed industria. Sull’insieme di questi fattori, che già militavano per una diversa attenzione europea alla “questione industriale” è poi arrivata l’accelera- zione legata al COVID, che ha fatto esplodere in modo concreto e immediato i nodi industriali ‘portandoli dentro’ i sistemi economici e sociali.
Nelle dinamiche di risposta europea a queste sollecitazioni ‘sistemiche’ la posi- zione francese ha effettivamente contato (e molto). Non è un fatto casuale e non va solo spiegato con il permanere di una tradizione culturale.
C’è, infatti, dietro questa ‘vittoria’ francese anche un dato politico: molto chiaro. Essa è, infatti, il frutto di una riflessione-azione politico-amministrativa che, dalla seconda metà degli anni Novanta, si preoccupava di una “deindustrializzazione” del tessuto imprenditoriale francese sempre più marcata, e che spingeva, per contrastarla, per un ritorno della politica industriale.
Si tratta, a pieno titolo, di una ‘riflessione-azione’ perché essa è consistita sia in un’attività di analisi, sia di azione amministrativa.
Ci sono, così, rapporti governativi molto influenti (pensiamo a quelli affidati dalla politica a personalità dell’industria come Jean Louis Beffa, nel 2006, o Jean Louis Gallois, nel 2012). Ci sono atti di strategia periodicamente adottati dai Ministri competenti, che riportavano ‘dentro’ al dibattito politico francese il tema dell’industria. C’è stata un’azione molto vocale a livello europeo: verso la Commissione, nei cui confronti la Francia ha sempre più fatto valere la necessità di un cambio di approccio in vista del nuovo assetto globale; nel costruire un’alleanza strategica con una Germania inizialmente molto titubante su questi temi. E, ancora, c’è stata la centralità della politica industriale nelle campagne presidenziali, in cui i candidati scendevano direttamente sul campo della discussione.
Il quadro che si presenta oggi, sulla base di queste dinamiche e di questa ‘in- fluenza francese’ è un panorama di politica industriale che gira attorno a concetti oramai consolidati nel linguaggio europeo: dal sostegno alla “doppia transizione” (digitale ed ambientale) alla nozione di “ecosistemi industriali” – intesi come raccordi tra i mondi dell’università, della ricerca, della produzione, delle istituzioni – per arrivare alla “sovranità industriale”, direttamente legata a quell “autonomia strategica” che è sicuramente il concetto più caratterizzante del discorso pubblico europeo più recente.
È qui, nel concreto avverarsi di questi obiettivi, il punto cruciale di uno sforzo di policy che, ed è lo stesso Eli Cohen a precisarlo, dev’essere “corale”. Certo c’è la presenza pubblica ed il ruolo di indirizzo e di impulso svolto da Stato e regioni, ma nel nuovo contesto globale tutto questo non basta. Accanto ad esso ci debbono essere gli al- tri attori dell’economia: le imprese, le Università ed i centri di ricerca, le startup, gli investitori privati Ed è proprio qui che sta la sfida europea dei prossimi anni: costruire un sistema di governance che coordini tutti questi attori attorno a vere e proprie missioni ‘sempre più articolate’.
Cohen è molto chiaro nel dirci che non basta più, insomma, il rapporto top-down che caratterizzava le esperienze di politica industriale del passato. Sono più ampi, oggi, gli obiettivi che la politica industriale persegue – dall’ambiente sino all’elemento territo- riale, passando per la qualità dello sviluppo – e molto maggiori, quindi, gli attori da far lavorare insieme. La nuova politica industriale è, insomma, molto diversa da quella che abbiamo conosciuto sino ad ora. Dev’essere capace di ‘far parlare’ i mondi diversi, di individuare obiettivi precisi con metriche altrettanto precise, di cambiare in corsa sulla base di valutazioni, di accettare di terminare i programmi quando essi non funzionano più.
Ed è proprio per questa specifica rilevanza dell’elemento della governance nell’attuale politica industriale che si apre un periodo di grande interesse per lo studioso di diritto pubblico dell’economia, chiamato ad aiutare e qualificare questi sviluppi. È il lavoro di analizzare in maniera comparata le diverse esperienze; di promuovere nuove istituzioni e nuovi strumenti di intervento; di delineare forme di coordinamento ed integrazione tra i le diverse leve a disposizione e tra i diversi livelli di governo. A contribuire, insomma, dal punto di vista giuridico, al pieno affermarsi di questa nuova politica industriale, che sino ad ora ha visto un ruolo preponderante degli studiosi dell’economia. Ed è così anche per chi studia i problemi del Mezzogiorno e del suo sviluppo.
Tra gli obiettivi ampi della attuale politica industriale, come scrive Élie Cohen, ci sono in prima linea anche quelli legati agli squilibri territoriali. E questo significa per il Mezzogiorno linee di lavoro molto precise per rendere attrattivi i propri territori; per favorire l’insediamento di nuove imprese in settori strategici; per realizzare una rete di centri di ricerca in pieno dialogo con il mondo della produzione. E, ancora, per formare e qualificare lavoratori per nuove tipologie di impresa e, nella dimensione larga, od ‘olistica’, che ormai ha la politica industriale, per avere una rete di istituzioni amministrative di qualità.
In questa politica industriale “in costante divenire”, come la definisce Cohen, c’è dunque un cantiere di lavoro amministrativo molto chiaro da affrontare: tradurre le indicazioni politiche e le esigenze che emergono nell’economia in fatti di intervento. Ed è proprio in quest’ottica che la lettura di questo libro, con le sue coordinate di analisi, i suoi richiami all’esperienza francese (e non solo), il suo allertare su come evitare gli errori del passato, è importante. Lo è per definire i cardini essenziali nell’affrontare questo momento europeo con la consapevolezza piena delle sue implicazioni, molto dirette, sui percorsi dello sviluppo industriale meridionale.
di Gian Paolo Manzella


