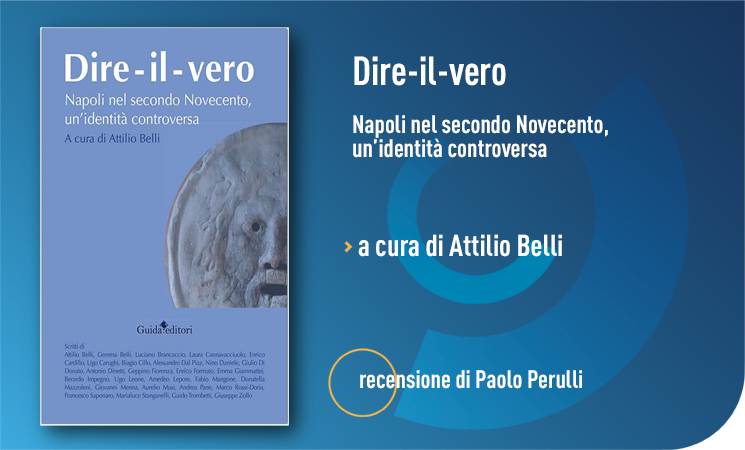
Napoli, unica metropoli europea nel Settecento insieme a Londra e Parigi, capitale europea della musica, fin dal 1799 apripista di rivoluzioni civili, arriva al Novecento in affanno: l’Italia unita la ha “dimenticata” guardando altrove, soprattutto a Torino, Milano, Firenze, Roma. Eppure, ancora nel Novecento Napoli è, per Christian Norbert-Schultz (1979), prototipo del genius loci, “dove spazi e caratteri classici incontrano l’atmosfera romantica del mare e le forze ctonie del vulcano”, e per Walter Benjamin (negli anni 1920) immagine della “città porosa”, dove pubblico e privato si intrecciano in modo così diverso dalla rigida città borghese europea.
La città come fenomeno culturale trova quindi in Napoli una interrogazione, un punto di domanda: come si passa alla modernità senza perdere il patrimonio enorme del proprio passato? E chi, quali forze devono guidare questo passaggio?
Attilio Belli sta sondando con scavi successivi questo passaggio. Prima con una collezione di testi rivolta al futuro (Napoli 1990-2050, Dalla deindustrializzazione alla transizione ecologica, Napoli, Guida, 2022), ora con uno sguardo al passato recente (Dire- il-vero. Napoli nel secondo Novecento, un’identità controversa, Napoli, Guida, 2023) su cui qui ci concentreremo.
“Dire il vero” a chi? Secondo i Greci, ai propri pari nell’assemblea di uomini liberi che forma la polis. Parlare en parrēsia significa parlar franco, senza paura, anche rischiando. In età moderna significa parlar franco al potere, speak truth to power come hanno fatto Gandhi e altri leader di movimenti non-violenti. Michel Foucault ha ripreso il tema nelle sue lezioni degli anni ’80 al Collège de France, ma Noam Chomsky ha poi osservato che il potere conosce già la verità e fa in modo di nasconderla: occorre piuttosto parlar franco con chi potere non ne ha, cioè i deboli. Tutto questo si ritrova nella densa introduzione di Attilio Belli al volume, in cui gli aspetti filosofici ed epistemologici si intrecciano con quelli tecnici e urbanistici.
Chi deve “parlar franco”? Innanzitutto ‒ e soprattutto ‒ gli intellettuali, quel corpo specializzato che affianca, consiglia, critica il potere. Essi sono contigui al potere, secondo Sabino Cassese (citato da Belli) sono parte della classe dirigente, dell’élite. Essi devono spiegare, chiarire la realtà, criticare e proporre. Per Max Weber e per Georg Simmel le professioni intellettuali hanno una terzietà rispetto al potere, e la dialettica tra ‘scienza come professione’ e ‘politica come professione’ è uno dei fondamenti della società libera. In ogni caso hanno una vocazione che li guida. La dimensione morale è essenziale.
Giusto quindi che il volume, nella prima parte, presenti una fitta trama di intellettuali napoletani che tra la prima e la seconda metà del Novecento hanno parlato franco al potere, spesso facendone parte direttamente, altre volte su posizioni più eccentriche e defilate. Sfilano le figure di Croce ‘civile’, di Bordiga ‘urbanista’, di Caccioppoli ‘intellettuale critico’, di Geremicca ‘mediatore’, di Cenzato, Brun, Giustino ‘imprenditori visionari’. I loro disegni per lo più irrealizzati si muovevano a metà strada tra regola e modello, in una città che arrivava alla sfida della modernizzazione senza né regole né modelli. Anzi con una vasta, la più vasta in una metropoli come Napoli, area di sregolazione, in cui l’autogoverno della camorra (come lo chiamava Benjamin) può insinuarsi e prosperare.
Ma “chi è” il potere a Napoli? La risposta viene guarda caso da uno scienziato politico non napoletano, l’inglese Percy Allum nel suo studio su Potere e società a Napoli nel dopoguerra (uscito prima in Inghilterra e poi in Italia nel 1975, edito da Einaudi). Per la prima volta appare un’analisi della società come chiave per interpretare il potere, e non solo una riserva di arretratezza o di familismo amorale. Allum parte dalla società: struttura economica, rapporti di classe e valori morali, politica e tradizione culturale della città. Passa poi ad analizzare il popolo napoletano, le sue visioni politiche del mondo, il suo comportamento elettorale. Giunge così a mettere a fuoco gli uomini politici napoletani, il loro sistema clientelare e l’uso del voto di preferenza, perfino il carattere dei parlamentari. E infine il teatro della politica napoletana e i suoi attori: partiti, sindacati, giornali, clero, prefetti; il ruolo di Lauro e dei Gava che transitano dal ‘boss cittadino’ alla ‘macchina politica’ (due concetti sicuramente weberiani) anzi al ‘consorzio di macchine politiche provinciali’ come dirà poi Allum in Napoli punto e a capo. Partiti, politica e clientelismo: un consuntivo (L’Ancora, Napoli, 2003), fino ai rapporti tra la società napoletana e lo Stato italiano.
Allum è anche il primo a spiegare la complementarità tra economia del vicolo nel centro storico, in cui vive da sempre la plebe napoletana, e decentramento produttivo disperso e frammentato lungo i nuovi assi mediani dell’area metropolitana, in cui si addensa la neoplebe. In realtà, come ha spiegato altrove Giovanni Laino, nella realtà cittadina napoletana si mescolano, spesso ai vari piani dello stesso edificio, diverse classi sociali e qui aveva visto giusto Benjamin, perché elevata porosità urbana equivale a maggiore mixitè sociale. Il tutto è stato innervato e sostenuto da una politica delle infrastrutture e dell’edilizia funzionali a questo assetto post-industriale, entro il quale la modernizzazione industriale (di cui è emblema l’intervento dell’industria statale a Bagnoli) ha mantenuto un ruolo tutto sommato circoscritto nel tempo e nello spazio.
In quella che mi sembra una tripartizione della società utile anche per capire Napoli, cioè l’élite, la classe intellettuale creativa, e la neoplebe, le analisi contenute entro il libro di Belli assegnano un peso di gran lunga prevalente agli intellettuali. I professionisti e i professori dell’urbanistica e della cultura urbana napoletane: Roberto Pane, Luigi Cosenza, Domenico Andriello, Luigi Piccinato, Marcello Vittorini, Daniela Lepore (unica presenza femminile nella rassegna: ma perché non Fabrizia Ramondino e Mirella Stampa Barracco?), Antonio Iannello, Mario De Cunzo firmano a vario titolo le pagine principali della pianificazione urbanistica e territoriale napoletana, ne sono i tecnici e i critici. Il geografo Francesco Compagna con la rivista “Nord e Sud”, lo storico Giuseppe Galasso autore della prima legge nazionale sul paesaggio, Aldo Masullo filosofo e politico, il giornalista Giancarlo Siani assassinato dalla camorra, completano il quadro ricchissimo della prima parte del volume. Un bilancio sul ruolo degli intellettuali come classe qui si impone, ed è nel complesso un bilancio in deficit. Manca l’egemonia, sostiene Masullo nel libro intervista Napoli siccome immobile (Guida, Napoli, 2008): hanno fallito tutte le élites nel rendere popolo una moltitudine, hanno fallito le borghesie nell’introdurre innovazioni sociali moderne e durature, hanno fallito gli stessi intellettuali nel rendere i pur importanti nuclei delle istituzioni scientifiche e tecniche da essi animate un fattore sistemico di modernizzazione. Quindi la plebe, continua Masullo, è rimasta ai margini dello Stato democratico e così relegata alla egemonia della camorra, “unica vera egemonia vista all’opera con una significativa carica espansiva”.
L’altro aspetto del bilancio critico che emerge nel volume sul ruolo degli intellettuali, riguarda i diversi modi di “dire il vero” analizzati da Foucault e ripresi da Belli: la profezia, la saggezza, l’insegnamento e il sapere tecnico, la parrēsia. Molti i tecnici, i saggi, i parrēsiasti: ma nessun profeta. Politica e profezia sono per Max Weber due aspetti del lavoro intellettuale come professione: ebbene questa dimensione profetica, letteralmente “dire la verità sul futuro” sembra mancare nel panorama intellettuale napoletano. Prevale, nell’identità controversa che il volume documenta puntualmente, il realismo politico, a volte
accomodante altre volte disperato. Emblematico quanto ricaviamo dal volume riguardo al rinascimento napoletano degli anni ’90 con l’elezione diretta del Sindaco, e poi all’epoca del “Sindaco di strada” dei primi anni 2000. Nel complesso un episodio, dopo gli anni delle speranze che esso aveva suscitato, che si iscrive anch’esso nel generale tradimento dell’identità della città di cui parla Belli nell’introduzione.
La controversa identità di Napoli è ben sviscerata nel volume, e soprattutto messa a tema nell’importante saggio di Donatella Mazzoleni: la Città e la sua Ombra. Napoli ha una identità duale fin dalle origini: vista dall’esterno è solare e sublime, ma dall’interno è ambigua e feroce. Quindi Caos e Ordine convivono fin dalla fondazione mitologica, l’Eroe e la Sirena, l’uomo e l’ambiente, l’intelligenza della città e la natura ostile sempre in agguato. E da allora la cultura della città di Napoli, che fu immensa in ogni epoca ma soprattutto nei Seicento e Settecento, esprime questo dualismo tra luce e ombra, tra città dell’istruzione e città del residuo. Quindi gli anni del secondo Novecento non fanno altro che riprodurre questo dualismo. Segnati da catastrofi in sequenza impressionante (distruzioni belliche, mani sulla città, colera, terremoto, munnezza, camorra) e apparenti tentativi di riforma che infine si trasformano in “accettazione dello sviluppo urbano senza regole” anche da parte dell’“ambigua casta accademico-professionale”. Diagnosi senza appello e rivalutazione di un punto di vista diverso, quello femminile, sia nella professione che nella cultura: Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese (Adelphi, Milano,1953) mostra le manomissioni urbane che impediscono di vedere il mare, mentre il paesaggio non può essere del tutto cancellato.
Le speranze vengono dalla seconda parte del volume, la verità dell’arte: è qui, nel romanzo di Domenico Rea, in quello altissimo di Anna Maria Ortese, di La Capria, Incoronato etc. nel teatro di Eduardo e di Titina che si avvia un modo di dialogare con le persone, “Napoli nella sua essenza” (nelle parole di Marialuce Stanganelli ne La città di Eduardo). Così nel cinema di Francesco Rosi di denuncia e di alto valore didattico, “un misto di amore, di delusione, di preoccupazione e anche di dolore” per la città, come il regista si esprime nel saggio di Andrea Pane (Napoli nel cinema civile di Francesco Rosi). Si riprende qui nell’alta lezione del cinema di Rosi il dire la verità che compariva nel saggio di Luigi Piccinato su Il destino urbanistico di Napoli (in F. Malusardi, Luigi Piccinato e l’urbanistica moderna, Roma, Officina Edizioni, 1993): “una società bacata non può non produrre una città altrettanto sbagliata”. Il saggio conclusivo sulla città di domani, Dire il vero ai tempi del digitale di Antonio Dinetti, si affida all’improbabile effetto di Internet per ridisegnare il futuro urbano. Come nell’ambiguo ottimismo tecnologico di Carlo Ratti citato nel testo, si immagina che i dati e le piattaforme siano la chiave per condividere idee, sapere e best practice. Invece l’intero percorso del digitale nelle città mostra come la tecnologia sia solo un fattore ulteriore di polarizzazione sociale, se pensata come espressione di un inesistente “smart citizen”. Si pensi alla Grande Parigi, dove l’open data riguarda solo alcune collettività locali, la maggioranza di esse non ha risorse né volontà politica, gli attori digitali si forgiano una posizione di potere, rapporti di potere che riproducono asimmetrie territoriali e antagonismi istituzionali preesistenti (F. Artioli, P. Le Galès, La métropole parisienne, une anarchie organisée, Paris, Science Po, 2023).
Il volume curato da Belli non ha conclusioni, una scelta certamente voluta: si tratta di un cantiere aperto di esplorazioni successive, senza tracce conclusive. Come del resto concludere un discorso sull’identità controversa della città, se essa è per definizione sempre in relazione con l’alterità mutevole del contesto, oggi segnato da profondissime nuove crepe a livello globale e locale? Si conclude un atto, una stagione, un capitolo, non certo la Storia che qui fluisce e che si racconta egregiamente nelle mille storie di cui il volume ci dà conto. Napoli come metafora di un dualismo incancellabile è però già traccia di un discorso più ampio e generale, di quell’essere duale (polis/civitas, ordine/disordine, visione orizzontale/visione zenitale, oriente/occidente etc.) in cui ogni città del futuro dovrà rispecchiarsi.
di Paolo Perullo


